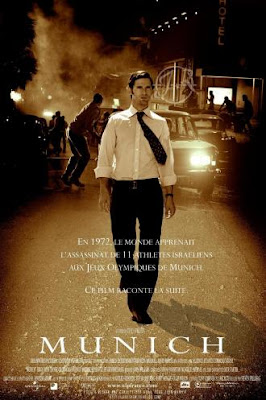279_IL GRANDE UNO ROSSO (The Big Red One); Stati Uniti, 1980; Regia di Samuel Fuller.
Quando assistiamo all’incipit de Il grande Uno Rosso di Samuel Fuller, ci viene in mente subito un
suo precedente film, La tortura della
freccia, del 1956: anche là c’era un’uccisione sul filo di lana della fine di
un conflitto bellico e, in quel caso, si parlava della Guerra Civile americana. La scena iniziale de Il grande Uno Rosso è invece ambientata ai tempi della Grande Guerra, con il sergente Possum,
interpretato da uno statuario Lee Marvin, che accoltella a morte un tedesco che
andava dicendo che la guerra era finita; come in effetti era. In realtà, il
resto del film ci racconta della II
Guerra Mondiale, e si chiude con una scena del tutto analoga: ancora il
sergente ad accoltellare un povero tedesco che sta festeggiando la fine delle
ostilità. Stavolta il soldato viene invece salvato, o almeno così sembra. Forse che proprio Fuller voglia lasciarci con un filo di speranza nel futuro? Chissà;
certo, l’impressione, vedendo il suo film, non è delle più ottimiste: la
struttura circolare dell’opera, ci troviamo nella stessa situazione iniziale,
col sergente che accoltella il nemico a
tempo scaduto, non aiuta. E se vogliamo analizzare il film di Fuller da un
punto di vista più teorico, come sembra richiesto dallo stesso autore, le cose
addirittura peggiorano. Perché le due scene, così simili tra loro, che
racchiudono Il grande Uno Rosso,
ricordano, come detto, un film di Fuller che accennava alla Guerra Civile americana, forse il primo
conflitto ad essere stato reso un’autentica carneficina dall’efficienza delle
armi moderne. E allora il moto di speranza finale si fa più flebile, perché più
che circolare l’andamento sembra essere a spirale, ovvero non solo senza alcuna speranza
di uscita, ma anche indirizzato verso lo sprofondo.
Anche perché le parole di commiato al film del
sergente Possum, ‘senti gran figlio di
puttana, devi vivere o ti ammazzo di botte’, ironicamente rivolte al
tedesco appena accoltellato, sono un ponte
ideale con un altro film di Fuller e, al contempo, con un’altra guerra. ‘If you die, I kill you!’ diceva infatti
il sergente Zack in Corea in fiamme del
1951: insomma, questi legami non
sembrano lasciare troppe speranze, la guerra è praticamente senza soluzione di
continuità, e le interruzioni
(verrebbe da dire momentanee) non sembrano molto efficaci.
Ma naturalmente c’è
anche un corpo filmico, ne Il grande Uno
Rosso; il cui titolo fa riferimento al simbolo della I divisione, la cifra uno
di colore scarlatto che, tra l’altro,
è un ulteriore collegamento tra i due maggiori eventi bellici del XX secolo. Il
film è, in concreto, la guerra vista da uno che l’ha vissuta: Fuller era
effettivamente un reduce di guerra, e l’impressione di essere un sopravvissuto
per miracolo ad una simile mattanza è resa perfettamente dalla sensazione di
invulnerabilità dei cinque protagonisti, il citato sergente e i suoi quattro fedeli soldati.
Griff (Mark
Hamill), Zab (Robert Carradine), Vinci (Bobby di Cicco) e Johnson (Keyy Ward);
tutti gli altri commilitoni sono visti come personaggi anonimi, e questo è
anche rimarcato, se qualcuno, come il soldato Kaiser, prova ad emergere un po’.
Uno dei momenti emotivamente culminanti è ovviamente l’arrivo al lager nazista:
all’EsseEsse nascosto nel forno
crematorio, Griff scarica l’intero caricatore. Tanta sostanza, per quanto
cruda, e poca retorica. Ma i passaggi forti, spesso pittoreschi, venati da humor nero o cinismo, sono numerosi: il
colonnello francese della repubblica di Vichy che muore col grilletto della
mitragliatrice premuto, continuando la sua guerra anche dopo morto, o i soldati
tedeschi che si fingono cadaveri per tendere un’imboscata, rinforzano l’idea
che la guerra sia senza fine, e quindi nemmeno la morte la possa fermare.
Ma la
guerra non si pone alcun confine, nemmeno quelli della logica razionale, così
la surreale danza dell’infermiera è scandita dagli sgozzamenti ai camerati
tedeschi, mentre un matto, inforcato un mitra di uno dei caduti, spara
all’impazzata sui presenti al grido ‘Ve
l’avevo detto che sono normale!’ Le pennellate di Fuller tratteggiano però
un universo completo, nel senso di
non unicamente pessimista: la trattativa col bambino italiano, anzi siciliano,
che vuole la bara per la sua mamma in cambio di un’informazione, e la ragazzina
a cui il sergente lascia con noncuranza la sua scarsa razione di cibo, sono
passaggi commoventi nella sensibilità sobria dell’autore.
Mentre l’ironia
emerge ancora spassosa ma anche corrosiva e disturbante nella contrazione dei
due motti pacifisti ‘fate l’amore, non la
guerra’ e ‘mettete dei fiori nei
vostri cannoni’, quando i nostri infilano dei preservativi sulle canne dei
loro mitragliatori per proteggerli. Che la guerra sia una metafora del sesso?
In questo senso Fuller sembra piuttosto dire che la guerra è una metafora della
vita, visto che il carro armato tedesco viene svuotato dai cadaveri per
alloggiarvi una sala parto dove, in un’altra scena surreale, una povera donna
partorisce aiutata dal soldato Johnson. Anche qui, Fuller non rinuncia a
sdrammatizzare la scena col suo tipico stile da B-movie: Johnson, per invitare la donna a spingere, la sprona
gridando pussy, pussy, pussy simile
ma dal significato ben diverso dal poussez
che gli era stato suggerito.
La guerra come portatrice di vita, si potrebbe
quindi desumere? Mah, il regista sembra piuttosto dire che c’è vita nonostante la guerra, e che la capacità
dell’uomo di adattamento è straordinaria. Ma c’è un’immagine simbolo, un’altra
che apre e chiude il film, che ha protagonista il Salvatore, e forse può aiutare a comprendere cosa pensa Fuller
delle nostre concrete speranze in un futuro più sereno. Il cristo intagliato
nel legno, quello dell’incipit che il sergente ritrova nel finale, non ha più
nemmeno gli occhi e nelle orbite vuote si aggirano fameliche le formiche: il
suo calvario è ben lungi dall’essere finito.
Se c’è quindi una salvezza per l’umanità, non è affatto
vicina.