1485_L'ULTIMO BAMBINO (The Last Child). Stati Uniti, 1971; Regia di John Llewellyn Moxey.
La fantascienza distopica è il sorprendente genere del terzo Movie of the Week per la rete televisiva ABC firmato da John Llewellyn Moxey. Il film è noto per essere l’ultima interpretazione di Van Heflin nel ruolo del senatore George: l’attore morì d’infarto poco tempo dopo che si erano chiuse le riprese e, di conseguenza, la triste sorte del suo personaggio nel finale del racconto finisce per avere maggiore enfasi. Che poi, di suo, il soggetto di Peter S. Fischer è già abbastanza sconvolgente: gli Stati Uniti, in un futuro talmente prossimo da sembrare quasi contemporaneo agli anni Settanta in cui venne prodotto il film, sono divenuti una sorta di dittatura democratica. Il che suona contradditorio, è chiaro, ma è appunto qui la cosa che lascia spiazzati. Il tema principale è, come in parte evocato dal titolo, il fatto che il governo americano abbia istituito un ferreo controllo delle nascite, per combattere la sovrappopolazione. Queste teorie ebbero effettivamente applicazione pratica nella realtà in Cina ma solo due anni dopo la trasmissione del film di Moxey, che anticipò quindi i tempi, da buon film di fantascienza. Quello che non riuscì peraltro ad intuire fu l’approccio all’argomento dell’aborto che, nel racconto, viene esercitato dal sistema per controllare le famiglie mentre nella realtà americana, dopo la celeberrima sentenza Roe Vs Wade del 1973, divenne una vittoria delle organizzazioni progressiste. Peraltro il tema dell’aborto è ancora oggi particolarmente delicato e con effetto divisivo immediato e automatico: L’ultimo bambino, con la coppia di genitori che si vuole tenere a tutti i costi il proprio figlio in procinto di nascere in un contesto di una società iper-sorvegliata che ne cerca invece la soppressione, finirebbe con ogni probabilità per scontentare entrambi gli esacerbati schieramenti che, inevitabilmente, si creano in questi casi. Ma se abbandoniamo un attimo l’argomento principale del film, l’aborto e le sue sfaccettature, per focalizzarci su temi meno scottanti e quindi più semplici da affrontare, non possiamo evitare di notare la lungimiranza dell’opera e il suo mettere in rilievo alcune contraddizioni che oggi forse tendiamo ad accettare per buone. Prendiamo l’uso della carta di pagamento, che nel film sembra aver sostituito il denaro: politica e organi di stampa ci martellano inesorabilmente con la demonizzazione del contante, che sarebbe l’anticamera dell’illegalità.
Bene, il film ci mette in guardia da quelli che sono i rischi di avere forme di pagamento interamente digitalizzate: nel caso di una forma di governo oppressiva, per il cittadino che finisse sotto speciale osservazione non vi sarebbe alcuno scampo, visto che si potrebbe trovare all’improvviso privato di ogni risorsa economica. Il che sembra un rischio solo teorico, considerato come siamo abituati a ritenere le nostre attuali forme di governo. Tuttavia, a tutt’oggi, se dobbiamo parlare di dittatura, in Italia, giusto per fare un esempio, non dobbiamo andare indietro nel tempo nemmeno di un secolo per trovarne una insediata stabilmente al potere. Non si tratta, quindi, di ipotesi poi così remote, almeno storicamente parlando. Un'altra curiosa teoria che mette in campo questo L’ultimo bambino è che la produzione dei veicoli, nel futuro distopico presentato, sia stata fermata; il che è sicuramente il sogno per ogni ecologista che si rispetti di oggi. In effetti l’inquinamento è uno dei problemi più gravi ma nel soggetto di Fischer non è chiaro se le auto siano state messe al bando per motivi ecologici o per carenza di combustibili: quello che emerge, almeno nell’ipotesi messa in campo dalla storia, è che senza le auto sarà assai più semplice controllare gli spostamenti delle persone. Il che è opinabile, in quanto con le targhe e il loro tracciamento non vi è oggi troppa differenza tra girare in automobile o dover passare la propria tessera personale in un controllo della stazione. In ogni caso, quello che L’ultimo bambino riesce efficacemente a comunicare – al netto di previsioni futuribili fatte agli inizi degli anni Settanta che si possono comprensibilmente essere rivelate non del tutto esatte – è che la società, nel momento in cui vuole l’assoluto controllo sulla vita dell’individuo, rischia di essere qualcosa di terribile. In effetti, al momento siamo lontani da una legge che vieti alla medicina di curare gli over 65 – questa la causa della morte del personaggio di Van Hefling – ma anche questa non sembra poi un’ipotesi cosi campata in aria. E, anche in questo caso, le recenti battaglie per il suicidio assistito rischiano di sovrapposti a questo tema del film, facendolo passare per un testo contro l’evoluzione civile. Ma è proprio questo il pregio de L’ultimo bambino: un film concepito come progressista e contrario ai totalitarismi negli anni Settanta, se visto oggi rischierebbe di passare per reazionario. Al netto delle posizioni di ognuno, vedendo il film, almeno un dubbio, su quanto ci viene oggi fatto passare per giusto e insindacabile, ci dovrebbe o almeno potrebbe venire. Tanta roba, comunque.
Janet Margolin











.jpg)
.jpg)






.jpg)







.jpg)



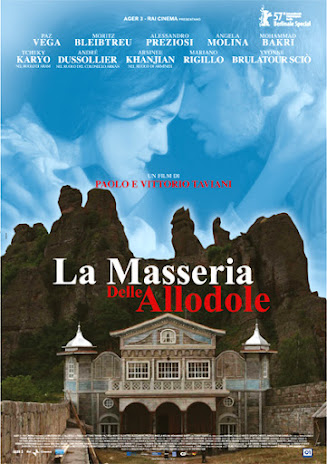













.jpg)


.jpg)
.jpg)









