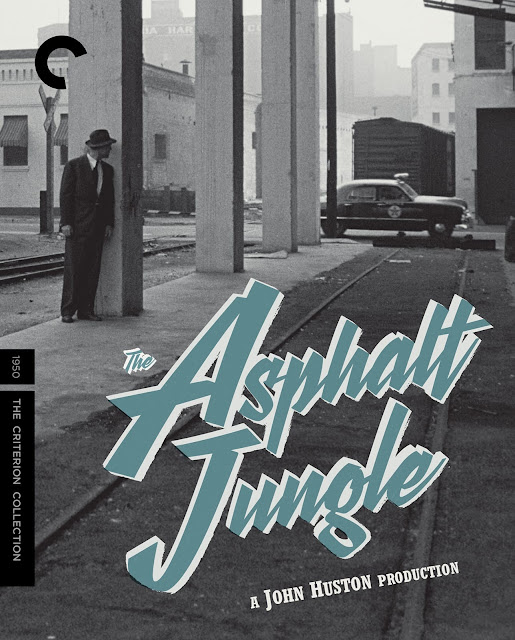1217_1997: FUGA DA NEW YORK (Escape from New York). Stati Uniti, 1981; Regia di John Carpenter.
Tra il 1978 e il 1980 John Carpenter dirige Halloween – La notte delle streghe (1978) e Fog (1980) per il cinema e Pericolo in agguato (1978) e Elvis il re del rock (1979) per la televisione: ha la mano caldissima. Visto il positivo riscontro di pubblico, la Avco Embassy, lo studio che aveva prodotto Fog, chiede a Carpenter un altro film e il regista americano decide di mettere mano ad un vecchio soggetto a suo tempo pensato per Clint Eastwood: 1997 Fuga da New York. Come detto Carpenter a quel tempo è in formissima oltre ad avere guadagnato la stima e la considerazione dell’ambiente. Per capirci: per Halloween – La notte delle streghe Carpenter ebbe a disposizione un budget di 325.000 dollari, per 1997 Fuga da New York 6 milioni. Il film, questo va messo a referto prima di ogni altra cosa, è un assoluto capolavoro frutto di abilità singole, collettive e congiunzioni astrali. A concorrere alla riuscita dell’opera e alla sua capacità di ergersi a icona simbolo di un genere e di un periodo in modo quasi sfacciato, va quindi considerata la capacità di Carpenter di fare tesoro delle proprie esperienze. Il successo planetario e clamoroso arrivò inaspettato per Halloween – La notte delle streghe dopo che il valido esordio Dark Star (1974) era stato ignorato e la stessa sorte era capitata inspiegabilmente al successivo Distretto 13 – Le Brigate della Morte (1976). Dopo la fortunata svolta con protagonista Michael Myers, come detto Carpenter aveva lavorato ad un paio di lungometraggi televisivi, Pericolo in agguato e Elvis il re del rock, nei quali, dovendo farne a meno, si era reso conto di quanto fosse importante la propria abituale squadra di lavoro.
Fog, il seguente ritorno al grande schermo, segnerà un clamoroso successo ma è interessante notare che “sul banco del montaggio, Fog subisce un radicale cambiamento voluto da John Carpenter” [Il Cinema di John Carpenter, G. Salza e C. Scarrone, Fanucci Editore, 1985, pagina 103, e per stessa ammissione del regista, come si può leggere a pag. 33 del libro-intervista John Carpenter di G. D’Agnolo Vallan e R.Turigliatto, Lindau]. Il regista americano, in quel preciso momento, sa cosa rende un film un successo; molto probabilmente non in modo del tutto consapevole, ma la sua sensibilità artistica sa esattamente cosa fare. Questo ipotetico aspetto della non completa coscienza della propria poetica è interessante perché permette di intuire parte della grandezza di 1997: Fuga da New York. Sempre nell’intervista contenuta nel volume Lindau possiamo apprendere che il regista non si capacitava degli aspetti che gli spettatori trovavano in Halloween – La notte delle streghe. A pagina 31 Carpenter dice: “La gente mi trattava come se sapessi qualcosa che in realtà non sapevo […] Il film aveva assunto una vita tutta sua, indipendente da me.” Sempre usando questa intervista a mo’ di strumento per comprendere meglio alcune dinamiche che stanno intorno a 1997: Fuga da New York non può non sorprendere che il film in questione venga saltato: le domande sono poste un po’ a ruota libera su base cronologica, per cui potrebbe essere un caso, è vero.
Ma 1997: Fuga da New York è forse il film più celebre di Carpenter, al massimo il secondo dietro Halloween – La notte delle streghe, impossibile non farne parola quando si stanno rievocando i primi anni Ottanta del regista. In ogni caso, pagine e pagine dopo (pag.55), quando si arriva a Fuga da Los Angeles, gli intervistatori si rendono conto che non hanno ancora parlato del primo capitolo della saga, quello appunto ambientato a New York. Carpenter è abbastanza sbrigativo a questo proposito virando presto su Fuga da Los Angeles, per il quale spende parole migliori. Al netto dei gusti, qualunque criterio di valutazione oggettivo (incassi, recensioni) predilige, e di molto, il capostipite al remake/sequel del 1996. Forse, proprio con il fenomeno descritto dallo stesso regista per Halloween – La notte delle streghe, il primo film con Jena Plissken ha assunto una sua propria autonomia, un significato non del tutto conosciuto, almeno a livello consapevole, dallo stesso Carpenter. E per quanto a posteriori se ne possa dire freddo e indifferente 1997 Fuga da New York è la perfetta sintesi della sua poetica. Frutto di una serie di circostanze fortunate, forse, o di un’alchimia di cui l’autore non è del tutto cosciente – chissà – comunque è chiaro che per comprendere il film in questione il suo realizzarsi è forse più utile che non il risultato, perfino troppo disarmante nella sua semplice efficacia. Radunato il proprio staff di collaboratori, a partire da Debra Hill come produttrice, vengono inoltre ingaggiati i migliori tecnici in circolazione: l’art directors a cui dobbiamo l’aspetto visivo del film è Joe Alves, mentre per girare costantemente in condizioni di buio Dean Cundey utilizza lenti Ultra Speed Panatar. Roy Arogast è un altro nome eccellente per gli effetti meccanici mentre pare che negli effetti visivi fosse coinvolto anche James Cameron. Non si tratta di fare un elenco di nomi ma di rendere merito ad uno stuolo di persone la cui collaborazione, abilmente orchestrata da Carpenter, ha permesso all’opera di girare come il meccanismo di un orologio.
E i nomi sarebbero tanti e, si possono ricordare ancora almeno Nick Castle, all’opera insieme a Carpenter a soggetto e sceneggiatura, e Larry J. Franco in produzione e regista della seconda unità. Un discorso a parte merita la musica, scritta dallo stesso Carpenter e di cui il regista conosceva l’estrema importanza per il successo di un film; ad assisterlo, chiama Alan Howarth per un risultato semplice, quasi ossessivo e quanto mai efficace. Anche il cast è composto da attori in molti casi già diretti dall’autore americano, tra questi: Kurt Russell è Jena Plissken (Snake, nell’originale americano), Donald Pleasence è il Presidente degli Stati Uniti, Adrienne Barbeau è Maggie, Frank Doubleday è Romero, Tom Atkins è Rehme. Lee Van Cleef (è Hauk), Ernest Borgnine (è il Tassista) e Harry Dean Stanton (è Mente) sono invece palesi legami con il cinema a cui Carpenter fa riferimento in 1997 Fuga da New York. Sia Van Cleef che Borgnine erano stati in grado di interpretare sontuosamente sia i western classici che le derive successive più decadenti pur non limitandosi certo solo a quel genere.
Stanton era anch’egli un caratterista eccezionale e guardando la sua filmografia si rimane esterrefatti sebbene raramente gli sia stato riconosciuto il giusto merito. Preparato gli eccezionali ingredienti, Carpenter non si avventura in qualcosa di troppo originale, semplicemente cristallizza in un’opera una serie di spunti che già aleggiano nell’aria. Ad esempio, il debito di 1997 Fuga da New York verso I guerrieri della notte (1979) è evidente ma Carpenter enfatizza la situazione di degrado descritta da Walter Hill ambientando il suo film in un futuro prossimo in modo da avere mano libera. Un po’ come aveva fatto George Miller per Mad Max – Interceptor (1979), tanto per capirci. Da parte sua il regista ribalta il concetto a cui era particolarmente legato del Male che assedia dall’esterno per raccontare di una società nella quale il Male è talmente ben radicato da poter essere efficacemente rappresentato dalla Manhattan trasformata in carcere di sicurezza che vediamo nel film. L’idea del tempo che incalza ma può anche essere dilatato dalla regia, nella scena della resa dei conti finale, è uno stratagemma narrativo che non da alcuno scampo allo spettatore, costretto come Plissken a non mollare mai la presa. Il carisma di Russel e le celeberrime battute del suo personaggio finiscono l’opera: 1997: Fuga da New York è un vero e assoluto capolavoro, un film al tempo stesso semplice ed epocale, e non poteva essere altrimenti. Ad essere del tutto onesti, oggi, oltre trent’anni dopo, guardandolo, si può forse scorgere qualcosa appena dopo il limite che il film raggiunge e sancisce, il limite del sublime. Quel limite oltre il quale si sfiora il ridicolo. Ma perché mai dovremmo farlo?
Adrienne Barbeau
Season Hubley
Galleria di manifesti






.jpg)







.jpg)
.jpg)


.jpg)









.jpg)




.jpg)
.jpg)










.jpg)
.jpg)