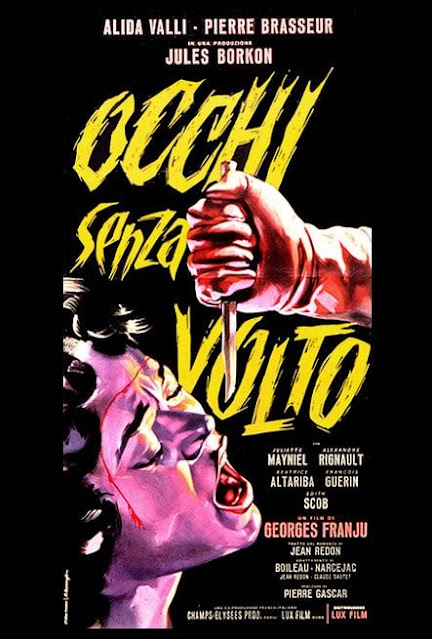1384_L'OCCHIO CHE UCCIDE (Peeping Tom). Regno Unito 1960; Regia di Michael Powell.
In una famosa citazione di Michael Powell a proposito de L’occhio che uccide, il regista esplicita e condensa l’aspetto metalinguistico del film nella semplice espressione “io sono il cinema”. E’ curioso che un autore acclamato da critica e pubblico per tutta la sua carriera, manifesti questo proclama parlando di un film che, al tempo, fu invece la causa del suo declino in termini di popolarità. Naturalmente, Powell – e nel caso anche il suo fido collaboratore Emeric Pressburger, non coinvolto però ne L’occhio che uccide – ‘era cinema’ anche nei suoi precedenti film. Quale che sia stato l’impulso che spinse Powell ad un’espressione tanto esplicita come il suo metalinguistico film, per renderla concreta su schermo si rivolse ad un tipo di storia per lui insolita. E, nel suo approcciarvi in modo personale e atipico, fu talmente sconvolgente che ridefinì il genere thriller grazie ad un film che, a vederlo ancora oggi, rimane disturbante e malsano. Ma non sono tanto le scene per l’epoca efferate degli omicidi a metterci in difficoltà, e nemmeno la paura che leggiamo nei volti delle vittime del racconto filmico. Tutto questo è finzione e in fondo ormai noi siamo assuefatti dalla violenza largamente diffusa nel cinema oltre che nella realtà. Quello che ci turba è la profondità dello sguardo del regista: a pensarci bene, è proprio quello a cui dovrebbe alludere l’occhio che uccide del titolo italiano. Powell, per sancire senza dubbio la sua identificazione col cinema, va alla radice; ma non tanto del media, del cinema stesso, ma dell’animo umano, della sua anima. Naturalmente gli animi degli autori cinematografici, i loro sentimenti, le loro speranze, i loro timori, sono presenti in tutti i film; in misura adeguata al loro valore, altrettanto naturalmente.
I generi, con i loro codici e i loro cliché, fanno da filtro, permettendo all’autore di non mettersi troppo a nudo di fronte al suo pubblico. Il messaggio arriva comunque, ma necessita di un minimo di rielaborazione, concedendo un po’ di legittimo pudore all’artista e agli interpreti. Un processo comprensibile, in fondo gli autori sono umani, con debolezze e incertezze come tutti noi; ma, con l’andar del tempo, si rischia che l’infrastruttura costruita per questi motivi, finisca per soffocare la vera natura del cinema. Powell, per scardinare questo sistema, si rivolge al sentimento più potente tra quelli spontanei: la paura. E, nello specifico, la paura di morire è la nostra paura più grande. Nel documentario che Mark Lewis (Carl Boehm) sta girando, vuole filmare proprio quella, la paura di una donna che sta per essere uccisa.
Ma siccome non è tanto la morte in sé, a spaventarci, essendo un concetto a noi incomprensibile, Mark pone uno specchio sul punteruolo del treppiede con cui uccide le sue vittime. Esse vedranno, quindi, il proprio volto impaurito per l’imminente morte: nel cortocircuito che se ne ricava, la vittima inorridita dalla sua stessa paura di morire, l’assoluta paura verrà cristallizzata nella cinepresa di Mark. Questo sentimento naturale, il più potente tra quelli istintivi, raggiunge quindi la massima espressione, autoalimentandosi. Il riferimento del titolo del film originale, Peeping Tom è però assai meno grave, visto che il significato della definizione è qualcosa tipo guardone, voyeur. In effetti Mark è anche attratto dalle scene di sesso o dalle nudità femminili e, se anche si può forse definire questo un comportamento poco opportuno, moralmente non è certo grave come uccidere la gente e osservarne perversamente la fine.
Per motivare narrativamente i disturbi del protagonista, Powell e Leo Marks (autore di soggetto e sceneggiatura) ricorrono alla psicanalisi, mostrando l’infanzia del piccolo Mark tormentato dal padre che lo filmava nel sonno, al funerale della madre o dopo avergli gettato lucertole nel letto. Ma questi aspetti sono secondari, tutto sommato, perché ognuno dei nostri comportamenti o delle nostre inclinazioni può e sarà anche influenzato dalle nostre esperienze infantili e formative. La cosa interessante è che l’attrazione per filmare la sofferenza, che determina le necessità assassine di Mark, ha la stessa matrice del voyerismo per il sesso. Non c’è tecnicamente una differenza tra la perversione nel vedere un atto violento che contraddistingue il protagonista e quella che spinge il distino signore che, nel film, compra le fotografie pornografiche. Si tratta sempre di desideri morbosi, che sono molto più diffusi di quel che ci piace pensare, e di quel che certamente si voleva credere nel 1960, anno di uscita del film. L’aspetto che utilizza Powell, di questi sentimenti estremi, è che attraverso il loro manifestarsi si vede distintamente l’anima, o almeno una parte di essa, dei personaggi: notevole, infatti, la performance di Carl Bohem, davvero convincente e umanissimo nel mostrare tutte le sue perversioni che altro non sono che umane debolezze. La comprensione umana per il protagonista non lo assolve dalla condanna morale, peraltro, e in questo senso c’è la presenza dell’ispettore Cregg (Jack Watson) a ricordarcelo. Ma L’occhio che uccide lascia la pista giallo-investigativa decisamente in un angolo, tanto che noi sappiamo sin da subito chi è il colpevole e anche la polizia non ci mette poi molto a capirlo.
Del resto, con una fotografia dagli sgargianti colori innaturali, il film di Powell non vuole certo essere un testo realistico. A questo proposito, va detto che il regista, che pure rimane formidabile nella messa in scena, coglie costantemente immagini che sembrano rubate, come se stessimo noi stessi guardando da un pertugio, da un buco della serratura. In fondo, lo spettatore cinematografico è il voyeur per eccellenza; e Mark, prima di essere regista è soprattutto spettatore, chiudendo in questo modo il cerchio metalinguistico. Il cinema, quindi, è questo: cogliere l’emozione, catturare l’essenza della vita. E il fatto che il protagonista del film sia un maniaco, è semplicemente perché attraverso il suo operato, il suo filmare il terrore profondo negli occhi delle vittime, questo possa risaltare in modo eclatante. Lo si è detto, la paura è il sentimento istintivo più forte. Ma sorge un limite: “tutto quello che riprendo è perduto” ad un certo punto sentenzia Mark. Da un certo punto di vista è ovvio, le vittime sono davvero perdute. Dall’altro il filmato registrato sembrerebbe smentire questa affermazione. Ma è l’arte ad essere immortale e una registrazione così sterile, paragonabile a quella degli snuff movie, lascia ben poco di sé ai posteri. Solo la paura di morire, una perdita, una mancanza, quindi. Ma Powell, non vuole certo connotare negativamente il suo film perché vorrebbe dire connotare negativamente il cinema. Certo, ci sono i guardoni, le ragazze disposte a spogliarsi – a mostrare la propria intimità, solo per fare soldi – e c’è perfino la sciatteria del cinema stesso – le scene delle riprese al film dove lavora anche Mark – ma questo panorama, che al di là delle opinioni non è che si possa definire troppo edificante, serve innanzitutto per contestualizzare il protagonista.
Che non è, quindi, un alieno piovuto dal cielo ma il frutto, deviato fin che si vuole, ma figlio della società a cui appartiene e a cui apparteniamo tutti. Ma, soprattutto, questo mondo desolato serve per dare ancora più risalto alla figura di Helen (Anna Massey) ragazza che si innamora di Mark e che con il suo ingenuo amore potrebbe anche riuscire salvarlo. Sua madre (Maxime Audley), cieca, proprio perché non vittima del desiderio voyeuristico ha la capacità di vedere davvero, di capire, e comprende per prima che Mark ha qualcosa che non va. Il suo è uno sguardo distaccato dalla vista e quindi obiettivo, ma non è che si può scegliere di essere ciechi per vedere. Bisogna essere in grado di vincere le difficoltà dello sguardo e non rifuggirlo. Helen, ormai innamorata, prova quindi a superare le paure della madre e anche le sue, e vuole vedere, cerca in tutti i modi di vedere quello che filma Mark. Del resto lei stessa ha bisogno dell’espressione impossibile nei volti della gente per illustrare il suo libro. Ma a differenza di quello del protagonista, lo sguardo di Helen sul mondo è pieno d’amore, per Mark, per la vita, per i volti delle persone. E il cinema, e il cinema di Michael Powell, più che nell’occhio assassino di Mark/Carl Bohem, lo si può trovare in quelli di Helen, semplice ragazza innamorata della vita.
Moira Shearer































.jpg)





























_1000_420_90_c1.jpg)