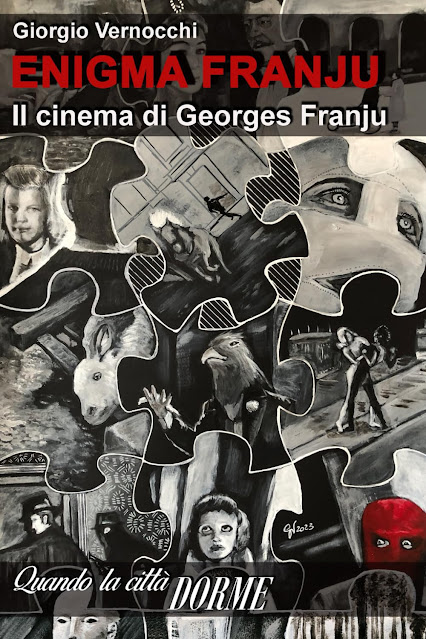1611_IL CONFINE . Italia 2018: Regia di Carlo Carlei

Sulla base di un soggetto assai ambizioso e ben
articolato, Il Confine, produzione televisiva Rai diretta da Carlo
Carlei, naviga a lungo sul filo del naufragio ma, con un po’ di sorpresa
perlomeno per lo spettatore non assuefatto alla moderna fiction, alla fine
riesce ad arrivare in porto. In effetti le caratteristiche tipiche delle
produzioni televisive odierne sono lo scoglio più difficile da digerire per chi
è abituato ai raffinati stilemi del cinema: ad esempio, il costante utilizzo
dell’obiettivo aperto, quasi grandangolare, con la scena sempre
completamente messa a fuoco, è assai poco stimolante per l’esercizio del
guardare. Viene voglia di distrarsi, guardando una di queste produzioni, magari
di focalizzare la propria attenzione su un dettaglio secondario della scena,
tanto è sicuramente ben visibile e nitido; non c’è un vero dialogo, in
questo senso, tra regia e spettatore. Il regista televisivo si limita a
riprendere la scena e se deve seguire un’infermiera che cammina in un
corridoio, la sua camera mette a fuoco tutto, compreso i fiori che si
vedono fuori dalle finestre. Spesso, si avverte una certa vacuità nella regia,
forse anche da parte dell’autore; a lenire questa sensazione probabilmente è
dovuta quell’abitudine a muovere in continuazione lo strumento di ripresa, con
lenti carrelli laterali che non hanno ragion d’essere se non evitare che
l’immagine fissa su una scena possa, per assurdo, turbare lo spettatore.
Sono limiti castranti dell’odierna produzione televisiva che difficilmente
permettono ad una fiction di essere appetibile per chi, come detto, si è
abituato al linguaggio del cinema; semmai adeguati, probabilmente, a chi si è
nutrito di reality e telequiz. E, ahimè, Il Confine rientra appieno in
questa categoria. Tuttavia, alla lunga, il tema forte della Grande Guerra
viene fuori e, sebbene in modo faticoso, dà il suo contributo per salvare la
produzione. Certo, per molto tempo la storia sembra fare acqua: si ha infatti l’impressione
di guardare una moderna versione, scialba e senza nerbo, dei melodrammi
strappalacrime degli anni cinquanta. Ma, eventualmente, questo si rivela essere
un pregiudizio del suddetto spettatore: proprio come nei melò di Raffaello
Matarazzo, tanto più assurdamente enfatica è la vicenda, quanto poi risulta
efficace la risposta emotiva finale. In questo campo gli autori del soggetto
sanno il fatto loro ed è soprattutto a queste caratteristiche del racconto che va
riconosciuta la funzionalità del film. Intanto è positiva l’idea di ambientare
a Trieste la vicenda: una città italiana ma sotto il dominio austriaco
all’epoca dei fatti raccontati. Questo permette una prospettiva centrata
sull’oggetto del discorso, i territori di lingua italiana da liberare,
ovvero il nostro pretesto bellico, ma lo affronta, almeno inizialmente, da una
prospettiva diversa, altra rispetta al nostro punto di vista e
appunto interna all’Impero Austroungarico.









.jpg)




.png)


































.jpg)


.jpg)