A scoprire che si tratta di una
produzione indipendente, imbastita dall’esordiente regista Lydia Guzhva e dal
militare Vadym Veydi, in origine giornalista freelance e in seguito arruolatosi
nell’esercito ucraino, si rimane sorpresi per la professionalità e la cura
formale che contraddistingue 93: Battle for Ukraine. Si tratta di un
documentario storico bellico suddiviso in tre capitoli, che ripercorre
cronologicamente le prime fasi della guerra russo-ucraina attraverso l’operato
della 93sima Brigata Corazzata Kholodnyi Yar dell’esercito di Kyiv. Lo
schema del film ricorda i documentari dei canali tematici come History Channel,
con interviste, scene dal vero e mappe degli eventi, che permettono di
comprendere in modo chiaro ciò che avviene sul campo di battaglia. Il primo capitolo,
First Days of War - The story of the 93rd Brigade Kholodnyi, realizzato
nel 2018, incomincia documentando le difficoltà incontrate dall’esercito di un
Paese che non si aspetta di ritrovarsi coinvolto in una guerra, con problemi
come la mobilitazione, l’addestramento delle truppe, e l’approvvigionamento di
armi. Il fatto che i separatisti, di loro altrettanto impreparati, abbiano
avuto sin da subito il pronto appoggio dell’esercito russo, un’autentica
macchina guerra organizzata e astutamente preparata già in precedenza
all’evenienza, ha acuito le difficoltà dei nazionalisti. Tuttavia, non c’è come
una guerra per velocizzare i tempi di apprendimento e, ben presto, si entra nel
vivo degli scontri. Tra gli episodi bellici rilevanti raccontati nel primo
episodio il più tremendo è il terribile Calderone di Ilovays'k, un’autentica
carneficina con gli ucraini fatti a pezzi dal bombardamento russo mentre
cercavano di ritirarsi. Stando alla versione ucraina e occidentale, i filorussi
avevano promesso un «corridoio verde»,
un passaggio che avrebbe consentito ai nazionalisti di evacuare l’area
incolumi: in realtà era la più infida delle trappole e il battaglione fu
praticamente distrutto.
Il 14 agosto 2020, a Leopoli, venne presentato il secondo capitolo dell’opera, presso
il Lviv Film Center; queste le parole del coautore di 93: Battle for Ukraine,
Vadym Veydi: “Nonostante il fatto che ci sia una triste tendenza al sostegno
alle posizioni filo-russe da parte di alcuni media civili ucraini, la
situazione nelle forze armate ucraine è notevolmente migliorata rispetto alla
situazione all’inizio della guerra. Sono stati creati servizi per la stampa e
sono arrivate persone ideologicamente interessate a svilupparli... Che video
che solo ora vengono mostrati alle forze armate ucraine! Sono pieni di
patriottismo, forza e fede!” [Maria Kull, La Prima del
documentario militare 93: Battle for Ukraine si è svolta a Leopoli, dal
sito GalInfo.com.ua, pagina web https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_vidbulasya_premiera_viyskovodokumentalnogo_filmu_93_biy_za_ukrainu_348967.html,
visitata l’ultima volta il 28 dicembre 2024]. L’entusiasmo ardente dello sceneggiatore del
documentario rivela la matrice apertamente schierata di 93: Battle for
Ukraine, cosa del resto già ben evidente guardando il film. Si tratta, in
buona sostanza, di un’opera di propaganda, pienamente lecita in tempo di guerra
da parte dei soggetti coinvolti, alla quale lo spettatore neutrale può
approcciare senza problemi o timori, a patto di tenere ben presente la natura dell’operazione.
Il secondo capitolo, War Diary of the 93rd Brigade Kholodnyi si apre con
alcuni interessanti considerazioni di Roman Huba «Malyi», comandante del
primo battaglione, e Oleh Mikats «Desna», comandante dell’intera brigata. Secondo
i due ufficiali, la guerra russo-ucraina fu preparata per tempo dal Cremlino,
addirittura una quindicina d’anni prima dell’annessione della Crimea, l’evento
che diede il là alle operazioni di Mosca. Huba fa un resoconto evidente: ai
tempi della dissoluzione dell’Unione Sovietica, l’Ucraina vantava un esercito
forte di 450.000 militari, che scesero nel tempo a 80.000, per arrivare, con
gli uomini pronti all’azione, ai soli 6000 mila nel 2014. Mikats è perfino più
esplicito, accusando di quest’opera di distruzione dell’esercito ucraino gli
ultimi due ministri della difesa, di cui sottolinea il fatto che fossero russi.
La realtà è un po’ più complessa da stabilire, ma non deve essere molto diversa
da quanto dichiarato dal comandante della 93sima Brigata. Forse l’ufficiale si
riferisce a Dymitro Salamatin, nato in quello che ora è il Kazakistan e Ministro
della Difesa nel 2012, accusato, tra le altre cose, di tradire il Paese in
favore della Federazione Russa [dalla voce di Wikipedia inglese
dedicata a Dymitro Salamatin, pagina web https://en.wikipedia.org/wiki/Dmytro_Salamatin,
visitata l’ultima volta il 28 dicembre 2024] e a Pavlo Lebedyev, nato effettivamente in Russia e
Ministro della Difesa tra il 2012 e il 2014, accusato di diserzione [dalla
voce di Wikipedia inglese dedicata Pavlo Lebedyev, pagina web https://en.wikipedia.org/wiki/Pavlo_Lebedyev,
pagina web visitata l’ultima volta il 28 dicembre 2024]. Per quanto, accuse simili sono
state indirizzate anche al Ministro della Difesa precedente, Mykhailo Yezhel,
in carica dal 2010 fino al 2012 reo, secondo i tribunali ucraini, di aver
venduto indebitamente due bombardieri alla Russia e di diserzione [dalla
voce di Wikipedia inglese dedicata Mykhailo Yezhel, pagina web
https://en.wikipedia.org/wiki/Mykhailo_Yezhel, pagina web visitata l’ultima
volta il 28 dicembre 2024], per
non parlare di quelle rivolte
al Capo di Stato Maggiore Volodymir Zamana che, secondo il procuratore militare,
avrebbe privato l’Ucraina del suo sistema di difesa avendo sciolto le divisioni
missilistiche [dalla voce di Wikipedia inglese dedicata Volodymir
Zamana, pagina web https://en.wikipedia.org/wiki/Volodymir_Zamana, pagina web
visitata l’ultima volta il 28 dicembre 2024]. Insomma, le parole degli ufficiali della 93sima
Brigata non sembrano affatto campate per aria e gettano una luce diversa su
tutta quanta la crisi. Per quel che concerne le operazioni belliche, il secondo
episodio si concentra sull’Assedio all’Aeroporto di Donets'k, dove i nazionalisti furono in grado di
resistere quasi quattro mesi ai pesanti attacchi dell’artiglieria filorussa.
Un’altra pagina di epica che, peraltro, gli ucraini si sarebbero risparmiati
volentieri; ma è altresì vero che questi episodi stanno cementando sempre più
il patriottismo della popolazione sotto attacco. Come Fisica insegna, «Ad
ogni azione corrisponde un’azione uguale e contraria», [Terzo Principio della
Dinamica] pertanto le manovre di Putin stanno sortendo anche effetti non certo
favorevoli ai suoi stessi scopi.
Stando al trailer, il terzo capitolo della serie, al momento ancora in
lavorazione, continuerà a seguire le vicende dell’esercito ucraino nella guerra
contro l’invasore, fornendo un rapporto dettagliato, ad esempio, sulla Battaglie
di Marinka o Pisky. Non resta che aspettare la diffusione del documentario.

LA STUDENTESSA E L'ORSO è uno studio sulla guerra russo-ucraina attraverso il cinema.
In vendita qui:














_trailer_1%20(1).jpg)


.jpg)









.jpg)

.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

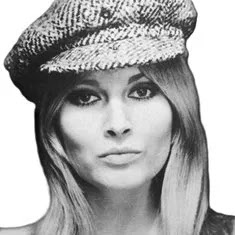
.webp)

.jpg)

