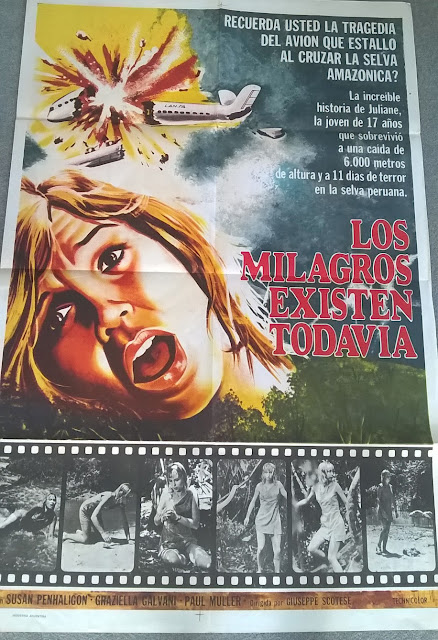1714_IL MANGIATORE DI PIETRE , Italia, Svizzera 2018. Regia di Nicola Bellucci
Il mangiatore di pietre è una sorta di opera prima, in quanto è l’esordio nel cinema di finzione di Nicola Bellucci, in precedenza già montatore, direttore della fotografia e regista di apprezzati documentari. Di per sé questo non deve essere motivo di particolare indulgenza, nei confronti di presunte lacune o difetti del suo film, ma considerato le scelte anche coraggiose di Bellucci, si può sospendere il giudizio su ciò che lascia perplessi, almeno fino ad un’eventuale ulteriore prova del regista toscano, e apprezzare quanto di buono c’è ne Il mangiatore di pietre. Dice, a proposito del suo film, lo stesso Nicola Bellucci: “Sono state le forti sensazioni suscitate in me dalla lettura del romanzo di Davide Longo (autore dell’omonimo libro preso a soggetto, NdA) a convincermi di voler realizzare Il mangiatore di pietre. Nella storia del «mangiatore» si rivelano i lati opachi delle cose, la duplicità dell’agire umano che mi affascina e spaventa, e che da tempo volevo cinematograficamente raccontare, arrischiandomi in un territorio affascinante e pericoloso, quello tra romanzo di formazione e film di genere. Il confine, territorio di mezzo, indeterminato e ambiguo: linea reale, convenzionale o culturale, che separa, sempre, ciò che è altro da sé è il luogo simbolico per eccellenza di questo film». [dal sito del Torino Film Festiva, pagina web https://www.torinofilmfest.org/it/36-torino-film-festival/film/il-mangiatore-di-pietre/36184/, visitata l’ultima volta il 7 agosto 2025]. È proprio il senso di indeterminatezza, di vaghezza, che traspare da Il mangiatore di pietre, l’elemento migliore del film di Bellucci. E quindi hanno probabilmente ragione i recensori che si trovano in rete, un po’ scettici nei confronti della struttura gialla dell’intrigo del racconto, che non sembra effettivamente irresistibile. Ed è vero che, soprattutto dopo la prima parte, con il paesaggio montano, grigio, freddo, molto evocativo, che legittima uno sviluppo più robusto del canovaccio di finzione, ci si ritrova poi per le mani una storia che effettivamente rischia di non decollare mai.
Ma, forse, anche questa perenne stasi, questa sostanziale attesa per qualcosa che non si traduce in nulla di concreto –le indagini della commissario Sonja (Ursina Lardi), la corruzione del maresciallo Boerio (Leonardo Nigro), il ruolo della malavita e del boss Antonio (Peppe Servillo)– è parte di questa ambientazione sospesa. Un film irrisolto che fa di questo la propria cifra stilistica: è accettabile? Lo si è detto, a questo punto si può sospendere il giudizio su questo aspetto, in fondo non si devono avere per forza tutte le risposte, o almeno non subito. In ogni caso: il film ha certo dei pregi, ad esempio la prestazione di Luigi Lo Cascio nel ruolo di Cesare detto il Francese, il «passeur» protagonista, e del cast nel suo complesso. Ed è interessante anche come il racconto si relazioni a questa attività, il «passeur», sorta di traghettatore oltreconfine di clandestini, professione illegale e certamente discutibile in linea di principio. Sergio (Vincenzo Crea), che ci si improvvisa e alla domanda di Cesare sul perché si impicci in simili affari, risponde con una battuta ad effetto: “qualcuno lo deve pur fare”. Una frase da cinema, detta poi da uno sbarbatello alle prime armi, che suona quindi ulteriormente posticcia. Il traffico di esseri umani è sempre da condannare ma occorre anche mettersi nei panni dei migranti, che hanno esigenze e necessità così disperate e lontane anni luce dai regolamenti sanciti dai confini del nostro mondo. Nel caso specifico, poi, ci sono questi disperati immigrati dall’Africa, nascosti in una baita d’alta montagna, in attesa di essere condotti dal passeur incaricato oltreconfine, in Francia. Il problema è che il contrabbandiere in questione è Fausto (Emiliano Audisio), il figlioccio di Cesare, che è appena stato ucciso e sul suo omicidio verte la trama gialla del film. Intanto, però, i poveri migranti rischiano di morire di fame e di freddo.
E qui subentra la coscienza di Sergio che, a differenza di quanto consigliatogli da Cesare, non chiama i carabinieri ma cerca di salvare questi poveri disgraziati, arrivando anche a rubare, per far loro qualcosa da mangiare. Evidentemente c’è la necessità di ribadire, da parte degli autori, che non è possibile restare dentro i confini della Legge. Diego chiede aiuto a Cesare, che conosce a menadito i passi alpini per farla in barba alle autorità di frontiera, ma il Francese non ne vuole sapere, è appena uscito di galera, era stato beccato ma non aveva tradito i suoi complici, e ora si trova coinvolto in un’altra bega, l’omicidio di Fausto, e tanto gli basta. La vicenda ha altri protagonisti, importanti per la soluzione del giallo, ma quello che conta è che poi, alla fin fine, Cesare darà retta a Sergio. Perché? Ma perché certi lavori qualcuno deve pur farli, che domande. È una motivazione sufficiente? Mah, difficile dirlo. C’è sempre qualcosa di sfuggente, ne Il mangiatore di pietre, come ad esempio nella scenografia, tanto che sembra un film ambientato negli anni 80 se non fosse per l’unica nota stonata rappresentata dagli smartphone. E, forse, è proprio in questa direzione che va cercata la soluzione al quesito che Cesare sottopone alla commissario sul perché la poliziotta non risponda mai al suo cellulare. La donna alla fine risponde al suo smartphone e il presunto mistero si squaglia come neve al sole. Un po’ come una vicenda che racconta di onore, forse malriposto, ma anche di altruismo e di coraggio, che poi si scopre abbia il suo centro in una banale questione di corna. Ma questa è la storia di un «passeur», una storia di confine.
Ursina Lardi
Galeria














.jpg)
.jpg)