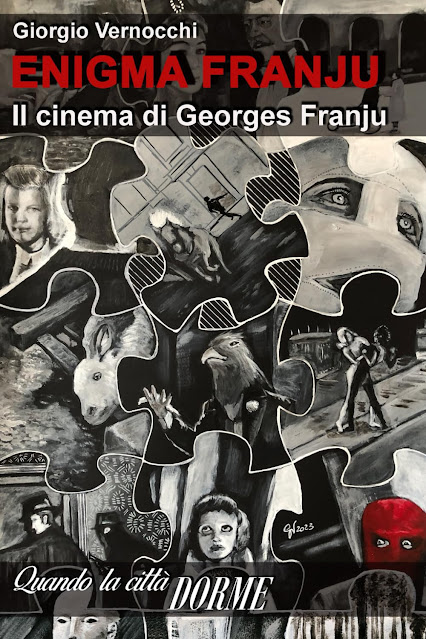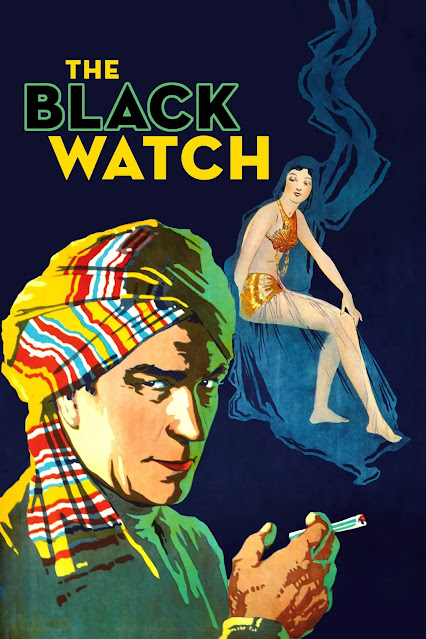1618_LA LIGNE D'OMBRE . Francia1973. Regia di Georges Franju

Tre anni dopo L’amante del prete tratto da
Emile Zola, George Franju prende in mano un testo di Jospeh Conrad per il suo
nuovo lungometraggio. Quello in progetto è un lavoro televisivo dal budget
assai modesto, dal momento che la carriera cinematografia del regista bretone è
ormai segnata. Rimasto escluso dalla Nouvelle Vague, la nuova corrente che ha
infiammato nel decennio precedente il cinema francese, Franju avrebbe meritato
ben altra considerazione dai produttori ma nel 1973 si deve accontentare di
lavorare per la televisione. La ligne d’ombre è un racconto di
formazione, se vogliamo così dire, nel quale Conrad racconta del primo incarico
di un giovane capitano. Il viaggio si rivela particolarmente duro, l’equipaggio
subisce un’epidemia di febbre tropicali e il vascello rimane in preda a lungo
della bonaccia, tanto che riaffiora il timore che la maledizione del vecchio
capitano stia sortendo i suoi effetti. Al termine di questo calvario, il
protagonista potrà ben dire di aver superato la propria linea d’ombra e
di essere pronto per affrontare nuove sfide stavolta in modo più preparato. La
necessità di Franju di rivolgersi a testi già pronti risultava dalla sua dichiarata
incapacità di raccontare: il bretone era un regista di visioni e le storie erano
pretesti per poter dare forma sullo schermo alla propria immaginazione in
proposito. La prosa di Conrad, per quanto questi fosse uno scrittore moderno, è
particolarmente difficile da adattare per lo schermo, in quanto verte su
personaggi di grande spessore interiore e quindi non semplici da rappresentare.
Nell’originale, il nome del capitano protagonista è omesso, tanto che viene
naturale interpretare il testo come autobiografico identificandolo con Conrad;
nell’adattamento di Franju prende invece il nome di Marlow (Jean Babilée) ha
significare invece un distinguo tra chi narra e chi agisce nel racconto. Ma non
è soltanto questa l’unica modifica che il regista bretone introduce, smentendo
in parte la sua stessa affermazione di non essere in grado di inventare
racconti. Tra le novità rispetto al racconto, nel film di Franju troviamo gli
ambigui fratelli Jacobus, Alfred e Ernest (interpretati dal medesimo attore,
Kurt Grosskurth), il commercio delle patate e, soprattutto, la figlia di
Alfred, Alice (Jaqueline Parent). Nonostante il nome potesse al massimo
rimandare al noto romanzo di Lewis Carroll (Alice nel paese delle meraviglie)
la ragazza è protagonista di un inserto sognante che ricorda Cenerentola,
evocata esplicitamente nella scena della scarpetta dove il feticismo latente di
Franju fa di nuovo la sua comparsa. La fiaba di Perrault è tra l’altro citata
nel discorso di commiato del capitano Mearlow che si appresta a salpare, mentre
saluta il capitano Gilles (Tino Carraro, inappuntabile come suo solito).
L’offerta irrinunciabile di Gilles, attraverso la quale Mearlow si ritrova in
un batter d’occhio capitano d’una nave, è paragonata alla carrozza che
magicamente appare dinnanzi a Cenerentola. A volte si è faticato a comprendere
la definizione che venne data al cinema di Franju, realismo fantastico,
e qui possiamo averne un bell’esempio. Le premesse sono di fantasia – quale
armatore affiderebbe una nave per un viaggio così impegnativo ad un inesperto
capitano? – ma la successiva realizzazione è particolarmente realistica, con il
cigolio perpetuo del veliero che non ci abbandona mai. Inoltre, non soddisfatto
del fantasma del capitano morto, quello evocato dal racconto dal secondo di
Mearlow, Burns (Roger Blin), che aveva maledetto la nave, introduce quello di
Alice. Il mazzo di fiori del giardino dei Jacobus è innaffiato con cura dal
cuoco Ransome (Luis Masson) e rievoca costantemente la breve storia
sentimentale tra il capitano Mearlow e Alice. Il cuoco si prende così la briga
di incarnare la presenza positiva all’opposto del secondo Burns, che in qualche
passaggio rievoca addirittura il Nosferatu di Murnau, tanto da spaventare gli
ispettori che salgono a bordo quando la nave arriva a destinazione. Del resto
appare evidente che, a livello narrativo, Burns avesse messo gli occhi sul
posto di capitano, poi soffiatogli d’improvviso da Mearlow: ancora un bel
accostamento tra il realistico senso di invidia e gelosia professionale, e il
fantastico, nel richiamo alla maledizione del vecchio capitano unita ad un
aspetto poco rassicurante del secondo. E’ comunque Burns a chiudere in
un certo senso la questione, svincolando la nave, e di conseguenza il suo
capitano, da queste ombre che vi aleggiano sopra. Burns prima getta in mare la
custodia del violino del vecchio capitano, e con lei la presunta nefasta
influenza di questi; poi, per chiudere il conto, butta nell’acqua del porto
anche i fiori di Alice, del resto ormai appassiti. Il capitano, il suo
capitano, è ora davvero pronto per un nuovo viaggio: le linee d’ombra sono
ormai alle sue spalle. E se quella del vecchio capitano, ereditata direttamente
dal romanzo di Conrad, può interpretare la paura di affrontare la vita, quella
di Alice, introdotta da Franju, riguarda la sfera sentimentale.
L’idealizzazione dell’amore – l’eccessivo rilievo dato ad un breve incontro, la
cui effimera consistenza è ben simboleggiata dal mazzo di fiori recisi destinati
ad appassire – è un’altra ombra da cui ci dobbiamo liberare.
.jpg)

Al cinema di Georges Franju Quandolacittàdorme ha dedicato ENIGMA FRANJU - IL CINEMA DI GEORGES FRANJU





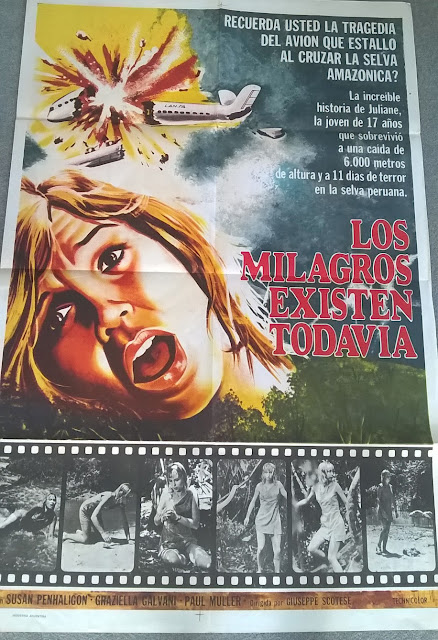














.jpg)

.jpg)

.jpg)