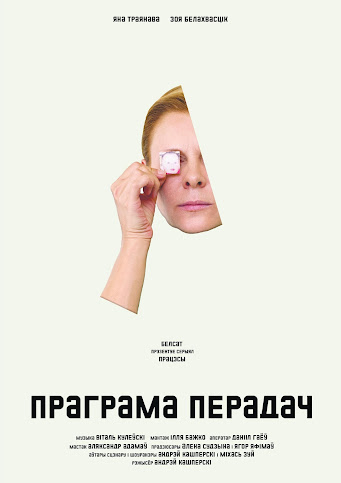1724_IL TENENTE SHERIDAN - QUALCUNO AL TELEFONO, Italia 1959. Regia di Stefano De Stefani
Nel 1959 la Rai mise in onda un curioso programma, Giallo
club – Invito al poliziesco, che inseriva, all’interno di una sorta di quiz
televisivo, alcuni lungometraggi della durata di un’oretta che avevano come
protagonista un personaggio che rimarrà nella storia della televisione
italiana: il tenente Sheridan. Interpretato da Ubaldo Lay, che finì per essere
identificato per sempre con il poliziotto dall’impermeabile color ghiaccio,
Sheridan era a capo della Sezione Omicidi di San Francisco ed era ritagliato
sulle figure della narrativa hard-boiled americana, come il Philip Marlowe di
Raymond Chandler o il Sam Spade di Dashiell Hammett, tenendo figurativamente d’occhio
soprattutto Humphrey Bogart nei suoi celebri noir. Ma con qualche significativa
correzione: via il cappello, forse troppo comune ai gangster, e niente whisky,
visto che il buon tenente beveva latte. Un particolare che sembrava voler
stemperare un po’ il clima plumbeo degli argomenti, come detto il tenente
lavorava alla Omicidi, con un rimando ai fumetti e a quel Cocco Bill,
personaggio di Jacovitti quasi coevo di Sheridan, che girava i saloon del far
west bevendo camomilla in luogo del più comune torcibudella. Del resto il rifermento
al mondo delle nuvole parlanti era ufficialmente dichiarato dagli autori che si
ispirarono a Ezechiele Lupo della Walt Disney per il nome di battesimo di
Sheridan, poi familiarmente chiamato Ezzy. Questo rimando –a quello che è in
sostanza uno dei cattivi dell’universo disneyano, per la precisione il lupo
cattivo che vuole mangiarsi i tre porcellini– è un elemento curioso, perché
presenta Sheridan come personaggio non del tutto positivo. Lay, oltretutto,
alimenta questa deriva, con una maschera poco espressiva se non per il suo
trasmettere inquietudine; insomma, non certo un personaggio rassicurante. Forse
è anche per questo che gli autori ambientarono la serie fuori dall’Italia, e
non solo genericamente oltreoceano ma a San Francisco, ben più lontano, per
esempio, della Nuova York che con la sua Little Italy aveva comunque un’area
famigliare nel Belpaese.
L’«invito al poliziesco», di cui parlava il
programma contenitore, forse aveva proprio questo scopo: far comprendere agli
italiani che le forze dell’ordine, anche per la natura del loro ruolo, non
erano necessariamente composte da cherubini e anime nobili. Una preoccupazione
inutile, a dirla tutta, considerata la Storia del nostro Paese, ma onesta in
ambito teorico e necessaria a non creare equivoci. E, rammentando le parole del
commissario Alzani –ricordato come il primo poliziotto della Tv italiana, dove
Sheridan è il secondo– si può comprendere come quest’operazione di
caratterizzazione delle forze dell’ordine sia stata fatta prendendola alla larga,
ovvero passando dalla lontanissima California. Alzani (Renato De Carmine), nell’ultimo
episodio della serie Aprite: polizia! sostiene infatti che “la
delinquenza non latina è sempre più crudele, più cinica”. In pratica, parole in
linea alla strategia alla base della scelta di ambientare a San Francisco la
serie cardine di Giallo club – Invito al poliziesco, ovvero un po’
quella di gettare il sasso nascondendo la mano. Per «svezzare» il Paese e farlo
crescere – compito primo della televisione di stato – occorreva fargli fare i
conti con la propria metà oscura –lo scopo catartico del racconto giallo– e con
la natura delle forze dell’ordine – quello più didattico del poliziesco– ma non
era il caso di essere traumatizzanti. Per cui, per prendere confidenza con
questo tema, ovvero l’ambiguità nel quale si muovono gli uomini deputati alla
sicurezza della collettività, meglio uno sguardo senza filtri ma che non ci
coinvolga subito direttamente. In fondo un saggio emblematico della politica intrisa
di spirito paternalistico che caratterizzava la classe dirigente dello Stivale.
La serie, una volta fatta la tara alle circostanze dell’epoca, si può affermare
sia realizzata con solido mestiere e, oltre al tenente protagonista, prevedeva
personaggi fissi come il sergente Steve Howard (Carlo Alighiero) e l’agente
Mills (Sandro Moretti), figure ricorrenti che aiutavano lo spettatore a
familiarizzare con i racconti. Il primo episodio, Qualcuno al telefono,
mette subito in mostra le capacità intuitive del tenente della Omicidi e
l’accuratezza formale del film, sceneggiato da Mario Casacci, Alberto
Cianbricco e Giuseppe Aldo Rossi, e poi diretto da Stefano De Stefani.











_-_DVD_2011.jpg)
.jpg)














.jpg)