1185_ATTENTATO AL PAPA . Italia 1986; Regia di Giuseppe Fina.
Se è vero che l’attentato al papa Giovanni Paolo II
avvenne il 13 maggio 1981, il processo che provò a far luce sulla vicenda si
chiuse alla fine di marzo del 1986. Questo fa di Attentato al papa,
miniserie TV uscita nei primi giorni di aprile di quello stesso anno, una sorta
di instant movie. Anche perché il racconto filmico di Giuseppe Fina si
basa sul libro Anatomia di un attentato di Claire Sterling, una
scrittrice e giornalista specializzata in terrorismo, e segue sostanzialmente
le indagini del giudice Martella (Ian Bannen) e gli interrogatori a cui venne
sottoposto l’attentatore, Mehmet Ali Ağca
(Christopher Buchholz). Il punto è che tra la primavera dell’81 e quella
dell’86 si arriva a capo di ben poco: Ağca è buono solo a far perdere tempo,
tra una dichiarazione e la successiva di senso contrario. Per cui, quando si
chiude il processo, le notizie che si hanno in mano, a parte la colpevolezza di
Ağca colto in flagranza di reato, sono scarne. Per quel che riguarda mandanti,
complotti e altre ipotesi su chi possa aver commissionato l’assassinio del
pontefice, ci sono ancora pochissime informazioni. Per questo Attentato al
papa, sebbene esca cinque anni dopo l’evento, di fatto presenta le lacune
degli instant movie senza aver la freschezza tipica di queste
produzioni; in fondo dall’attentato era passato un mucchio di tempo. Di contro,
l’opera scontava i limiti di questo genere di film: ricostruzione fedele degli
accadimenti ma scarso approfondimento dei motivi o delle implicazioni del caso.
Certo, emerge il coinvolgimento dei Lupi Grigi, organizzazione
terroristica turca, a cui apparteneva Ağca, e quello più interessante dei servizi
segreti bulgari. Cose risapute e che non davano però senso credibile al
tentativo di eliminare il papa polacco. Di veramente valido, il film propone un
paio di interessanti coincidenze che Ağca sforna e che mettono in serio
imbarazzo i due rappresentati bulgari presenti agli interrogatori. Ma è un po’
poco nell’arco di due ore e mezza di film. Mimetica l’interpretazione di
Christopher Buchholz nei panni del terrorista turco, sebbene il suo
comportamento enfatizzato, in un contesto narrativo privo di ritmo, venga presto
a noia. Il rischio peggiore che corre l’intera operazione filmica.








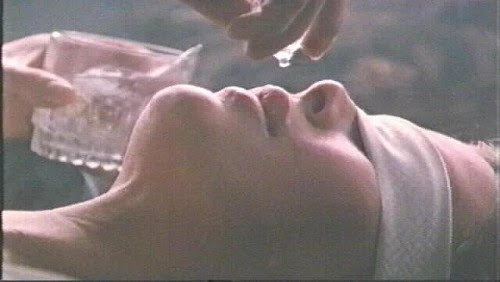


.jpg)






.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)







.jpg)


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

















