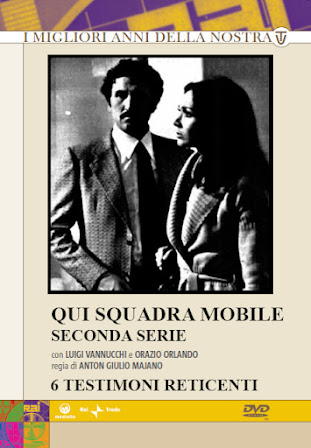1671_NESSUNO DEVE SAPERE Italia, Germania, 1972. Regia di Mario Landi

Nel
settembre del 1972, Il Padrino di Francis Ford
Coppola [Il Padrino,
Francis Ford Coppola, 1972]
era uscito anche nelle sale cinematografiche italiane; un film che aveva portato
alla ribalta internazionale l’argomento mafioso. Peraltro, nel Belpaese, Pietro
Germi, Francesco Rosi, Elio Petri, Giuseppe Ferrara, Damiano Damiani, tra gli
altri, avevano già dato corpo ad un filone cinematografico che poteva assurgere
a rango di vero e proprio «genere».
Curiosamente minore l’attenzione al fenomeno che aveva fin lì prestato la nostrana
televisione; che al tempo, in Italia, voleva sostanzialmente dire Rai, l’emittente
di stato che più che un emittente era una vera e propria istituzione nazionale.
Nell’ottobre del 1972 era stato trasmesso Joe Petrosino, uno sceneggiato
storico-biografico per la regia di Daniele D’Anza, ambientato prevalentemente a
New York ma con passaggi in Sicilia e strettamente connesso all’argomento
mafioso di origine italiana. Intanto, contemporaneamente, in quello stesso
ottobre ’72, nella Germania Ovest andava in onda una coproduzione tra le
tedesche Taurus e Westdeutscher Rundfunk e l’italiana Rai: Blutige Straße,
uno sceneggiato televisivo di oltre quattro ore e mezza ambientato in Calabria.
Nessuno deve sapere, questo il titolo italiano dell’opera, verrà
trasmesso nello Stivale solo nel corso del 1973, nonostante fosse stato
realizzato nel 1971 e comunque pronto per la messa in onda l’anno successivo,
come evidenziato dai palinsesti tedeschi dell’epoca. Un ritardo nella messa in
onda, un po’ clamoroso per la verità, che è, o sembra essere, semplicemente il
primo di una serie di episodi che ha sempre messo Nessuno deve sapere in
ombra, in secondo piano, quasi a voler intendere il titolo in senso
metalinguistico. Uno sceneggiato che è meglio non sia visto, insomma. Un’impressione
mantenuta vivida tutt’ora dalla perdurante difficoltà di visione dell’opera, sia
in DVD che su qualche piattaforma streaming; e dire che la Rai ne gestisce una,
Rai Play, che offre un’ampia scelta tra gli sceneggiati d’epoca. Questo,
soprattutto, in considerazione dell’eccelso valore del film di Mario Landi,
regista di Nessuno deve sapere, che va ascritto senza alcun timore di
smentita tra le produzioni meglio riuscite del citato genere mafioso. Lo
sceneggiato venne girato completamente in esterni, cosa non ancora del tutto
abituale per questo tipo di produzioni televisive, e Landi fa un utilizzo del
mezzo di ripresa in linea con i criteri cinematografici –le zoomate, i carrelli
all’indietro, i movimenti di macchina– che impreziosiscono il linguaggio
tecnico dell’opera. Le ambizioni del regista siciliano sono dichiarate anche da
evidenti riferimenti al cinema «di
genere» italiano, ad
esempio con lo spazio riservato agli inseguimenti in auto, un topos dei
poliziotteschi, e l’attenzione prestata alle vetture coinvolte, in questo caso
spicca la Maserati Indy del protagonista, è la conferma che non si tratta di
scene inserite per mere esigenze narrative. La bottiglia di J&B whisky, che
compare distintamente in un paio di occasioni, è il sigillo di garanzia
sull’operazione di affiliamento di Nessuno deve sapere al cinema «di genere» italiano, essendone il liquore
dalla bottiglia verde con etichetta gialla e rossa il riconosciuto marchio di
fabbrica. Questi rimandi non sono sterili virtuosismi cinefili ma la
dichiarazione d’intenti di Landi, che stempera efficacemente il clima narrativo
di Nessuno deve sapere che, diversamente, rischierebbe di essere troppo
cupo e pessimista. C’è la necessità, sentita da parte dell’autore, di essere
credibile e fedele alla realtà storica, ma c’è anche la volontà di lasciare uno
sguardo ottimista, di non annegare tutto quanto in un fatalismo senza speranza.
Questa difficoltà nel ricercare un punto di equilibrio tra istanze diverse, e
forse anche contrastanti, si evidenzia anche nel linguaggio parlato nello
sceneggiato: una stretta aderenza al dialetto locale avrebbe infatti reso
l’opera intelleggibile dal pubblico nazionale. La presenza nel racconto di
numerosi protagonisti provenienti dal nord Italia, permette di utilizzare
sostanzialmente sempre l’italiano come lingua «ufficiale»
del film, con le varie cadenze e inflessioni dei vari personaggi di turno. L’argomento
è, infatti, la costruzione di un’infrastruttura autostradale in Calabria ad
opera della Mondial-Strade, una società di Milano, che subappalta quindi i
lavori ad imprese locali. A questo punto subentra il tema legato alla
criminalità organizzata, con cosche mafiose che si contendono la concessione
dei lavori, facendo ricorso al tritolo e causando la morte di un guardiano di
un cantiere. Pietro Rusconi (Roger Fritz), il giovane ingegnere arrivato dal
capoluogo lombardo per dirigere i lavori, ne rimane sconvolto ma non intende
assolutamente accettare queste intimidazioni; anzi, vuole andare a fondo della
questione, e scoprire chi sono mandanti ed esecutori del crimine, a costo di
dare le dimissioni dal suo incarico in azienda.



Stefania Casini Gaia Germani







.jpg)

.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

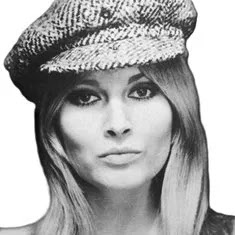
.webp)














.jpg)