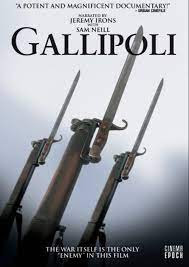946_CENERENTOLA (Cinderella); Stati Uniti, 1950; Regia di W. Jackson, H. Luske e C, Geronimi.
Nel 1950 il periodo bellico e i suoi strascichi potevano considerarsi alle spalle e Walt Disney, dopo sei lungometraggi in tono minore, decise di tornare a produrre un film che rinverdisse i fasti di Biancaneve e i Sette Nani. Si trattò di un azzardo; il boom degli anni cinquanta non si era ancora consolidato e la Disney non era riuscita a sistemare i propri conti in modo definitivo, non almeno nei termini che servivano a produrre un’opera impegnativa come Cenerentola. La decisione di Walt fu naturalmente lungimirante: è solo andando in anticipo, meglio se lieve come in questo caso, che si può fare davvero il botto, come di fatto avvenne. Quando si ha l’intuito geniale, e Disney ce l’aveva di sicuro, prendendosi il rischio di giocare sul tempo c’era la possibilità di cristallizzare qualcosa che era già prossimo a succedere (e sarebbe successo comunque) ma interpretandolo tempestivamente, si legava a filo doppio la propria opera con il contesto storico sociale. E, soprattutto, si andava incontro alle necessità del pubblico, proprio quando queste andavano maturando; a quel punto, oltre all’incasso, ci si prendevano anche i meriti autoriali. Che è quello che accade appunto con Cenerentola che, prima di ogni altra considerazione, va considerato come il classico per antonomasia di casa Disney; se Biancaneve e i Sette Nani è l’archetipo assoluto dei classici, se La Bella Addormentata nel bosco ne è l’apice tecnico artistico, Cenerentola è il classico perfetto. Dopo le limitazioni legate al periodo di guerra, occorreva una sterzata decisa che riportasse i film d’animazione della casa di Burbank al primo periodo aureo (dal citato Biancaneve a Bambi) e la soluzione scelta fu semplice e funzionale.
Si mise in campo una sorta di remake di Biancaneve, in fondo si trattava di ricominciare a fare grandi film d’animazione; lo schema narrativo di Cenerentola ricalca infatti quello del precursore, la giovane e innocente protagonista vessata dalla matrigna, le difficoltà, il lieto fine col principe. Ma con alcuni distinguo cruciali e che fanno di Cenerentola un caposaldo non solo tra i classici disneyani e non solo del cinema, ma dell’intera società americana (se non occidentale). Innanzitutto è rimarcata l’origine aristocratica europea dell’opera, con l’incipit che è una fiaba disegnata, presa di peso da un libro illustrato; questo aspetto, ivi compreso la nobiltà della protagonista (è la figlia di un aristocratico vedovo, che successivamente si risposa), non è da sottovalutare. Qui il concetto borghese americano, che è alla base di tutto il cinema hollywoodiano e sostanzialmente di tutta la cultura degli States, sembra vacillare.
E non è cosa da poco, perché Cenerentola, con la sua inarrivabile classicità, rappresenta quanto di più classico abbiano mai potuto ambire ad immaginare negli Stati Uniti: il Sogno Americano. Ma andiamo con ordine, perché, letteralmente, le cose non sembrano stare proprio così: se la protagonista della nostra avventura è una nobile, allora dovremmo essere di fronte ad una storia tipica della Vecchia Europa, e non della democratica America. Però, se vogliamo, l’incipit non è effettivamente animato ed è narrato dalla voce fuori campo; insomma, si riferisce a qualcosa di precedente alla avventura filmica vera e propria che andremo ad assistere.
Un po’ come se fosse da intendere come la Storia europea che i coloni americani si portavano in dote ma che nel Nuovo Mondo non conterà di fatto più nulla. Infatti, l’essere di nobile stirpe non comporta nessun vantaggio a Cenerentola, nel film e, piuttosto, il principe quando la incontra al ballo se ne innamora pur senza avere nessuna notizia a riguardo. Per cui la natura democratica, popolare, dell’eroe, o meglio dell’eroina, tipicamente americana è semmai rivalorizzata dal film. Non è più un eroe popolare, ma un’eroina aristocratica trattata come una popolare, visto che la stirpe nobile non ha comunque alcun valore ai fini della nostra storia. Cioè viene tolta la possibile interpretazione che il Sogno Americano premiasse un uomo del popolo non per scelta, ma per mancanza, in America, di una vera e propria aristocrazia titolata. Un altro aspetto interessante, in Cenerentola, è il rapporto familiare della protagonista: in questo caso si ripete lo schema di Biancaneve, e il nuovo classico non modifica l’impostazione dell’archetipo. Sembra cioè importante, per Disney, rimarcare le difficoltà di relazionarsi con la famiglia tradizionale: padre assente e matrigna cattiva al posto della madre, per entrambi i classici. Sono due film che mettono al centro della scena una ragazza, cosa poi non così scontata, per l’epoca; in entrambi i casi, le giovani si accasano, e lo fanno con un ottimo partito. Disney era americano, quindi una persona pratica, concreta: se ci si deve sposare, meglio farlo con un uomo ricco. In tutte e due i casi, con un principe, la cui descrizione però è sempre solo abbozzata, bidimensionale.
Come dire che la figura maschile, nella famiglia, serva a dare solidità, a dare corpo al sogno (americano), ma abbia poi poco peso nel complesso. Forse la nobiltà raggiunta dall’eroine può essere intesa come garanzia di sicurezza finanziaria anche se rimane un po’ l’idea di un certo conservatorismo, una volontà a restare ancorati alla solida tradizione europea, a cui, in fondo, la Disney, già a partire dal castello fiabesco che ne è l’emblema, non ha mai ufficialmente rinunciato. Il che sembra un contrasto, all’interno di opere che, nella prima metà del XX secolo, mettevano totalmente al centro della scena giovani donne, relegando ai margini i maschi della storia. In questo senso, pare non un caso che il principe, in Cenerentola, abbia un ruolo minore rispetto al collega all’opera in Biancaneve e si veda per giunta privato anche dell’aggettivo Azzurro, che era una sorta di titolo di merito a prescindere, visto che qui è solo un generico Principe.
Se le figure maschili sono così poco rilevanti, padri assenti e promessi sposi niente che più che simboli, la vera partita si gioca tra donne. Del resto, in America, era stato proprio il periodo bellico, con gli uomini impegnati al fronte, a veder emergere l’importanza della donna nella società: in fabbrica le ragazze si erano fatte valere, dimostrando le loro capacità (si veda la propaganda pubblicitaria dell’epoca) e adesso, a guerra finita, non si poteva far finta di niente e rispedirle a casa con l’ordine di tornare alle faccende domestiche e basta. Anzi, l’emancipazione femminile permetteva di allargare il mercato dove far sfociare lo sviluppo tecnologico, al solito balzato in avanti durante il periodo bellico, e elettrodomestici e accessori casalinghi vari necessitavano di donne che avessero voce in capitolo anche in sede decisionale famigliare.
Questo furono gli anni cinquanta americani (e non solo) e Cenerentola li aprì degnamente, mettendo in scena un conflitto tutto femminile che, stavolta, rispetto a Biancaneve, si allarga. C’è, nel film, una sorta di schema a raddoppio imperfetto, quasi a voler sporcare la specularità che una storia impostata su una divisione ferrea tra bene e male potesse lasciar intendere. Perché se Cenerentola è di animo buono, la matrigna, Lady Tremaine, è assolutamente cattiva e, essendo completamente umana, e non una strega come la Grimilde di Biancaneve, non ha nemmeno alcuna giustificazione narrativa per questo. Si può quindi dire che, in fondo, la cattiveria della regina in Biancaneve è legata al suo ruolo, è una strega, mentre Lady Tremaine non ha attenuanti. Ma, curiosamente, la dicotomia della contrapposizione madre (o meglio matrigna) vs figlia è raddoppiata dalla presenza delle sorellastre (Anastasia e Genoveffa) che biforcano ulteriormente il rapporto visto che sono due. La ragazza protagonista è quindi di fronte a due tipi di avversari diversi e tre soggetti differenti, a testimonianza che la battaglia è quasi sociale più che famigliare. In questo senso il film banalizza il messaggio: la bellezza è certamente un valore, e Cenerentola è bella e quindi buona; essere di aspetto sgradevole è invece un elemento negativo e quindi le sue tre rivali sono brutte e cattive. In questa semplicità di impostazione c’è, più che un tentativo di plagiare il gusto del pubblico o altre critiche che si sono sentite spesso rivolte alla Disney, l’intenzione di andare incontro alla mentalità infantile per la quale la propria mamma è sempre la più bella oltre che la più buona. E’ chiaro che rinfrancare il parallelo che ogni bambino dà quasi per scontato, ovvero bellezza uguale a bontà, è rischioso, ma Cenerentola, come tutti i classici Disney, è visto, impostato, sull’ottica infantile per cui non c’è una riflessione su questo aspetto, che è invece semplicemente un presupposto. Infantile, certo e, da un punto di vista adulto, confutabile; ma Cenerentola è e rimane principalmente un film per bambini.
Quello che incoraggia il film è, naturalmente, a darsi da fare, a non mollare ma avere fede nei propri sogni, tanto che, nel caso possano sembrare irrealizzabili, può sempre succedere un miracolo, in questo caso l’incantesimo della Fata Smemorina, che dia una mano. Ma si tratta di un aiuto temporaneo perché poi, senza il concreto e faticosissimo lavoro degli animali amici della protagonista, topi Giac e Gas in testa, tutto sarebbe comunque vano. Gli animali stanno anch’essi su un doppio schieramento, buoni o cattivi, con il gatto Lucifero, perfido e dispettoso che, da solo, regge e bilancia la moltitudine di avversari. Cenerentola appare infatti ben integrata con l’ambiente naturale costituito dagli animali della residenza che, per numero e indole, si dimostrano migliori dei personaggi umani della storia.
La natura, in Disney, è sempre un elemento positivo con cui bilanciare gli effetti spesso negativi introdotti dall’umanità ma, in Cenerentola, che è un classico allo stato puro, questi elementi sono veloci pennellate che servono per inquadrare tutta quanta la vicenda. Volendo, c’è anche una sponda rivoluzionaria, quando gli animali si ribellano alla cattiveria umana e di Lucifero, ma anche questa è, più che altro, una soluzione narrativa. Il vero fulcro non è comunque la lotta tra bene e male ma è che il personaggio protagonista sia una ragazza; e il fatto che sia meno fanciulla e, diciamo così, più svezzata di Biancaneve pone l’accento in modo inequivocabile sul suo genere di appartenenza. Disney, saggiamente, non ostenta in modo evidente lo sviluppo fisico di Cenerentola, che ha una bella linea ma è contenuta all’interno di una siluette abbastanza sobria (niente curve provocanti, insomma), ma sottolinea la cosa in una serie di riferimenti che risultano perfino più audaci.
Intanto all’inizio della storia, assistiamo alla sua doccia e, per un istante, può venire il dubbio che poi si possa intravvedere qualcosa; in realtà mancano opportunamente i fotogrammi osé, ma la cosa risulta evidente lo stesso. Poi la ragazza canta I sogni son desideri, a sottolineare l’importanza del desiderio, elemento su cui le donne degli anni cinquanta cominciavano ad accampare diritti anche in un ambito che, fino a quel tempo, era stato a loro, almeno apertamente, precluso. Nella scena, tecnicamente sopraffina, in cui lava il pavimento del salone, la sua figura si raddoppia nelle bolle di sapone; anche qui, il proliferare delle bolle e dei loro riflessi, annacqua il tema duplice.
La scena della scarpetta è poi un evidente rimando feticista, presente già nella fiaba ma ostentato anziché sminuito dalla versione animata disneyana. Questo passaggio, che è il più importante del racconto, esalta l’impostazione a raddoppio sporcato: la scena clou è anticipata quando Lucifero è in agguato sulla scala e Cenerentola, avendo perso una scarpetta, si gira su sé stessa per rinfilarla, mandando a vuoto l’attacco del gattaccio. Ma una volta che la cosa si è ripetuta, in modo assai più cruciale la sera del ballo, la specularità perfetta dello schema è viziata dal finale, quando la ragazza riperde di nuovo la scarpina. E perfino lo stratagemma di inquadrare le scene tramite il monocolo di Monocolao, utile per stemperare ironicamente la grandeur del ballo tra il principe e Cenerentola, ha anche una funzione piccante quando si focalizza sulle gambe della ragazza prima della prova della scarpa di cristallo.
Certo, è un’inquadratura casta, le si vedono le gambe solo sotto il ginocchio ma, in questo ambito, vista la reazione dell’arciduca quasi degna del lupo di Tex Avery, ci si muove su un terreno scivoloso. L’abilità della Disney è di far passare tutto quanto in modo non sospetto, come anche che fosse quasi naturale che un re possa baciare appassionatamente la scarpa di una bella ragazza. Questo versante sessuale è tenuto ben nascosto, dal tenore generale dell’opera, ma è anche insistito; non è quello il tema, non può esserlo in un classico Disney, ma è importante che l’impressione non sia più quella della situazione infantile, e asessuata, che impregnava Biancaneve, perché i tempi sono cambiati e, con gli anni cinquanta, le donne possono rivendicare le peculiarità specifiche del loro genere (di cui I sogni son desideri potrebbe essere l’inno).
Tecnicamente, sebbene ci sia stato un ritorno alla qualità dei primi classici, Cenerentola non comporta innovazioni di grande rilievo; da segnalare il pregevole utilizzo della cosiddetta polvere Disney, il luccichio che accompagna l’incantesimo della fata Smemorina e, in particolare, lo spettacolare vestito da sera della protagonista. In sostanza, per quello che fu il classico che rilanciò definitivamente lo studio, vennero messe a frutto le conoscenze accumulate nei lungometraggi precedenti. L’equilibrio tra forma è contenuto è qui, forse per qualcuno insospettabilmente, spostato sul secondo elemento; la confezione formale è notevole ma non eccessiva, semmai adeguata a mettere bene in evidenza le coordinate che il classico dei classici andava a definire. Dagli anni cinquanta, il sogno americano era non solo fruibile anche per la donna ma, a guardare in quest’ottica Cenerentola, sembrava addirittura quasi a suo appannaggio esclusivo. Tuttavia, nel corso del tempo, l’effetto incantesimo di quei favolosi anni passò. E se anche il film mostrasse che c’era comunque da lavorare concretamente per coronare nella realtà i propri sogni (o desideri), sarebbero entrati in scena altri elementi che nemmeno Disney poteva prevedere. E l’ideale di un mondo in cui l’armonia riesca a vincere tra le contraddizioni (il conservatorismo dello studio e le sue aperture ecologiche), tra tradizioni secolari (fiabe, castelli, balli di gala) e nuove rivendicazioni (la sguattera che fa carriera), tra egemonia maschile (il re, il principe) e l’esuberante emancipazione femminile (Cenerentola, chi altri?), trovando la giusta alchimia per una società in cui vivere felici e contenti, sembra esso stesso un incantesimo ormai svanito da tempo.