1635_L'HOMME SANS VISAGE . Francia, Italia, Jugoslavia, Germania, 1975. Regia di Georges Franju
L’anno successivo all’uscita nelle sale di Notti Rosse, sulla rete Télévision Française 1 viene trasmesso L’homme sans visage serie televisiva in otto capitoli che ne estende la trama. In realtà, Notti Rosse, pur essendo evidente che non fosse un capolavoro, non aveva dato l’impressione di essere un riassunto; e dire che il riferimento erano i lunghissimi serial cinematografici di inizio secolo di Louis Feuillade che Franju aveva già adattato al cinema in modo efficace ne L’Uomo in Nero nel 1963. Anche stavolta l’apporto di Jacques Champreux è notevole: non solo interpreta il villain protagonista, l’uomo senza volto del titolo ma, come già in Notti Rosse, cura anche la sceneggiatura. Per la verità, scorrendo i dati tecnici, scopriamo che Champreux si occupa anche dell’adattamento e dei dialoghi, del resto il polivalente artista doveva essere un vero appassionato nei feuilleton cinematografici con gli eroi mascherati avendo curato la sceneggiatura anche per il citato L’Uomo in Nero dove si raccontavano le gesta di Judex. Tuttavia la gestazione de L’Homme sans visage è particolarmente tribolata e il risultato non deporrà proprio a favore né della sua carriera e nemmeno in quella di Franju, se vogliamo essere onesti. Il primo episodio si intitola La nuit du voleur de cerveaux [La notte del ladro di cervelli] e vede subito all’opera proprio Champreux nei panni non solo del cattivone della serie ma anche in quelli di Mademoiselle Ermance, l’insospettabile copertura sotto cui l’Uomo senza Volto si nasconde. Rispetto a Notti Rosse apprendiamo il modo in cui viene arruolato nella banda criminale il dottor Dutreuil (Clément Harari) che in questo episodio è in sostanza il ladro di cervelli del titolo. Il folle dottore, con una serie di operazioni chirurgiche su persone rapite, sta cercando la formula per trasformare gli uomini in obbedienti robot. L’idea garba anche all’Uomo senza Volto che, con il prezioso aiuto della sua splendida e anonima compagna (Gayle Hunnicutt) riesce a scoprirlo ed assoldarlo. Il secondo episodio Le masque de plomb [La maschera di piombo] intreccia troppe piste avanzando un po’ a fatica, almeno finché non si arriva al nuovo laboratorio del dottor Dutreuil dove gli esperimenti di disumanizzazione stanno avendo successo. Il ritmo narrativo si riprende nel successivo Les tueurs sans âmes [Assassini senz’anima]: l’Uomo senza Volto ha messo gli occhi sul fantomatico tesoro dei Templari e questi ultimi, lungi dall’essere una leggendaria setta del passato ormai scomparsa, si preparano alla lotta. Intanto la polizia, capeggiata dal commissario Sorbier (Gert Frobe) e dall’ispettore Péclet (Enzo Fisichella), tra una beffa e una cantonata cerca vanamente di stare al passo.
Proprio durante una gaffe clamorosa del commissario, che si fa buggerare da un efficace travestimento dell’Uomo senza Volto, irrompe sulla scena Paul de Borrego (Ugo Pagliai) nipote del facoltoso uomo ucciso dal cattivo della storia nel tentativo strappargli il segreto del tesoro dei Templari, che pare esista davvero. Ad allentare un po’ la tensione, fanno la comparsa anche Martine (Josephine Chaplin), fidanzata di Paul, che chiama in soccorso un investigatore privato suo spasimante e un po’ imbranato, Séraphin (Patrick Préjan). Il quarto capitolo è un concentrato d’azione, pur nel ritmo narrativo compassato del tipico racconto televisivo del tempo. In ogni caso la prima parte di La mort qui rampait sur les toits [La morte striscia sui tetti] vede all’opera il personaggio senza nome interpretato da Gayle Hunnicut che si incarica di dar corpo al titolo dell’episodio. In un’attillata tutina nera, Gayle si muove sinuosa e tiene a lungo in scacco il commissario Sorbier e i suoi poliziotti; a catturarla ci pensa, un po’ clamorosamente, il più goffo, Séraphin, peraltro aggredendola alle spalle. Il detective privato sale comunque sugli scudi e si rende protagonista del proseguo del racconto, quando combina un vero pasticcio catturando il povero professor Pétri (Henri Soskin). Questi è un amico dello zio di Paul ucciso in precedenza dall’Uomo senza Volto ed è un vero professore, esperto di Templari e altre facezie storiche. Séraphine, memore che l’avversario è in grado di camuffarsi e spacciarsi per chiunque, lo blocca e lo sistema in una cassapanca insospettito dal parrucchino che l’uomo indossa. Finito il diversivo leggero si ritorna in clima nel laboratorio del professor Dutreuil per un aggiornamento sui suoi terribili esperimenti ormai in grado di creare un esercito di uomini robot. La marche des spectres [La marcia degli spettri], il quinto episodio, presenta un paio di spunti che rispolverano la tipica vena surreale di Franju. Si comincia con una fallimentare trappola tesa all’Uomo senza Volto che per poco non si rivela al contrario fatale a Paul, che si trova a fronteggiare un gruppo di uomini robot dall’aspetto di manichini. Séraphin, che alterna trovate geniali a gaffe clamorose, stavolta riesce nell’impresa di salvare la pelle all’amico. L’altra pennellata surrealista è un pilastro di cemento da cui sbuca una mano umana: è infatti così che avviene il ritrovamento solo ora di uno dei primi cadaveri seminati dall’Uomo senza Volto. La vittima era stata colata in uno dei pilastri della Città della Felicità, complesso residenziale in costruzione dall’impresa di Monsieur Baklava, che altri non è che l’Homme sans visage in uno dei suoi travestimenti. La ferita al polso, rimediata in uno scontro con Paul, tradisce però il nostro cattivo e l’ispettore Peclét si convince che Baklava e l’Uomo senza Volto siano la stessa persona. Il racconto procede a blocchi narrativi, senza disperdersi troppo; ad esempio in questa puntata non appaiono né Martine e nemmeno il dottor Dutreuil: la fruizione ne giova con l’attenzione dello spettatore che si può concentrare su un passaggio per volta. Arrivati al sesto capitolo, Le sang accusateur [il sangue accusatore], Franju e Champreux gettano la maschera, per così dire, e rivelano la natura da romanzo d’appendice dell’opera. Fino a questo momento, tutto sommato, il racconto era stato abbastanza credibile, almeno nell’ottica di una storia improbabile di uomini mascherati e scienziati in grado di trasformare gli uomini in robot. Ma gli incastri narrativi del racconto rispettavano discretamente la coerenza interna o almeno erano in questo senso convincenti. Questo nuovo capitolo lascia invece due sensazioni contrastanti: il ritmo è sempre serrato e trascinante ma troppi passaggi narrativi dell’intrigo sono poco credibili. Per esempio, come possa Paul arrivare a salvare Séraphin – messo in trappola da Baklava, alias l’Uomo senza Volto – non è dato sapere.
Nel feuilleton le spiegazioni delle soluzioni narrative sorprendenti sono di norma sostituite da nuove svolte del racconto, così che il lettore venga distratto e non si curi più del passaggio precedente. Negli anni Settanta è una pratica giustamente desueta perché gli spettatori non sono ingenui come i lettori di inizio secolo e l’idea di ricorrervi in modo così palese è, da parte degli autori, piuttosto rischiosa. Anche perché il settimo episodio, Le rapt [Il rapimento] rincara la dose: le modalità del rapimento di Paul, la sua liberazione grazie all’arrivo sulla scena di Molue à Singe (Laurent Oget) – un ragazzino abbandonato – e le clamorose coincidenze del finale sono effettivamente eccessive. A Parigi, la città più grande di Francia e forse d’Europa, Paul e Séraphine si nascondono in una squallida bettola sullo stesso pianerottolo dove alloggia le Sacristain (Jean Saudray) un ex bandito al soldo dell’Uomo senza Volto. Non bastasse questa combinazione, Molue à Singe, incaricato da Paul e Séraphine, va alla ricerca di Martine che, tra i continui colpi di scena – il fidanzato è prima accusato dalla polizia quindi rapito dai banditi – non sa più a chi rivolgersi o dove nascondersi. Fortuna narrativa vuole che il ragazzino la incontri per caso passeggiando in un parco; nella periferia di Parigi, giusto per ricordarlo. Perplessi da questi passaggi, seguiamo quindi l’Homme sans Visage sulle tracce del tesoro dei Templari quando alla trama si aggiungono nuovi rivolti, giusto per non dare troppo tempo per riflettere agli spettatori. L’ultima puntata Le secret des Templiers [Il segreto dei Templari] certifica che ormai la serie è completamente deragliata: lo scontro finale vede il prepotente ritorno sulla scena dei Templari, l’arrivo tardivo della polizia, la sconfitta dell’Uomo senza Volto e il salvataggio di Paul, Sérafine e Martine, che erano finiti sotto le grinfie del dottor Dutreuil. C’è tempo, prima della chiusura, affinché il Gran Maestro dei Templari riveli ai nostri eroi il segreto dei cavalieri, una sorta di crogiolo alchemico in cui sarebbe possibile produrre oro ma che emana costantemente radioattività. Ed è l’impossibilità a bloccarne la reazione che ha indotto i Templari stessi a rimanere nei secoli alla sua custodia perenne: soluzione narrativa degna, almeno negli anni Settanta, per una storia del fumetto Topolino della Disney, ma vabbè. Bello invece il finale con l’Homme sans Visage che, mascherato da Mademoiselle Ermance, si defila alla chetichella in compagnia della sua fedele alleata. Del resto era il finale con cui si era chiuso anche Notti Rosse e a questo proposito la visione complessiva della serie L’Homme sans Visage chiarisce un’altra cosa. Vedendo Notti Rosse, che altro non è che una visione condensata della serie televisiva, si rimaneva un po’ stupiti del fatto che, nonostante lo scarso mordente, non si avvertisse l’impressione di trovarsi di fronte ad un riassunto. In effetti le ramificazioni imbastite da Champreux nella sceneggiatura della serie televisiva sono talmente fini a sé stesse che il loro taglio non provoca particolari contraccolpi. Insomma, non si può considerare L’Homme sans Visage molto positivamente. E’ certamente un peccato, perché si tratta di una delle ultime fatiche di Franju alla regia e, almeno fino a metà della serie, lasciava qualche speranza. Ma per ricordare Georges Franju al suo meglio è più consono rivolgersi altrove.






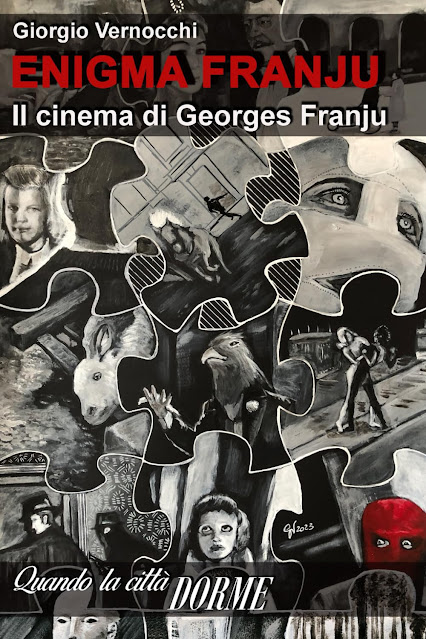























.jpg)





.jpg)
.jpg)
