1620_LA DONNA NEL MONDO . Italia 1963. Regia di Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi
Leggendo i commenti del
tempo, l’idea più diffusa era invece che La donna nel mondo fosse stato
realizzato con i residui del materiale di Mondo cane: quasi un modo per
stroncare a priori un film che, in sostanza, sarebbe fatto con lo scarto dello
scarto. Per la verità, la critica non fu poi molto più severa, nei confronti di
questa nuova fatica del trio di autori, rispetto alla precedente, tuttavia furono
più compassati anche i pochi commenti a favore. In sostanza La donna nel
mondo evitò forse le stroncature più trancianti, ma ottenne anche un plauso
minimo che, quando vi fu, fu legato proprio al suo essere meno sfrontato di
quanto potesse essere prevedibile.
Emblematica, in tal senso
una recensione dell’epoca: “questo secondo film di Jacopetti ha un solo
vantaggio sul primo: si serve di materiale che non fu ritenuto sufficientemente
macabro e orrido per Mondo cane, e perciò le sue immagini sono meno
atroci e, grazie a questo, anche più verosimili. [Dino Biondi, “Il resto del Carlino”. Jacopetti Files pagina 59]. Nello specifico, Biondi chiudeva poi la sua analisi
stroncando La donna nel mondo e liquidando l’opera di Jacopetti,
Prosperi e Cavara con quella superficialità comune alle altre recensioni del
tempo. Tuttavia, seppure sia partito probabilmente da un presupposto sbagliato
– La donna nel mondo non sembra fatto con gli avanzi di Mondo cane–
l’analisi del critico del «Carlino» in parte centra il punto. In effetti,
questo secondo documentario dei tre autori ha meno mordente rispetto al
precedente, è meno cattivo, meno cinico. L’impressione è che gli autori
avessero tenuto da parte uno dei piatti forti, di questa loro nuova idea di
documentario: da sempre gli argomenti sconvenienti sono sesso e violenza. In Mondo
cane di violenza ce n’era, ma il sesso era stato messo un filo in secondo
piano, forse per darvi spazio nel successivo lavoro. Naturalmente, per tre
autori uomini, in un mondo, quello del cinema, manovrato da altri uomini,
parlare di sesso voleva dire, inevitabilmente, mettere al centro del discorso
la donna, e qui poteva essere nata l’idea de La donna nel mondo.
Poi, forse, anzi
senz’altro, nelle mire di Jacopetti e soci c’era già l’intenzione di allargare
il tema, mostrando non solo la sfera sessuale, ma sembrava evidente quale fosse
il richiamo principale dell’operazione. Del resto i Mondo movie erano nati con Europa
di notte che, prima di dar vita al genere come noi oggi lo conosciamo,
aveva scatenato una serie di imitazioni a puro sfondo erotico, dal citato Il
mondo di notte in poi. Una simile situazione giustificherebbe la relativa
morigeratezza di Mondo cane in campo sessuale: l’intenzione poteva
infatti essere quella di lasciare il terreno «vergine» per La donna nel
mondo. Se queste erano le premesse, poi, in concreto, il secondo film di
Jacopetti, Prosperi e Cavara le disattende, almeno in parte, rimanendo
piuttosto vago in fatto di contenuti espliciti e inserendo, al contrario,
segmenti che esplorano altre sfere della vita delle donne nel globo terrestre.
Secondo il critico Onorato
Orsini, fu soprattutto la censura a smorzare i toni de La donna nel mondo.
Scrisse, infatti, Orsini su La Notte: “Documentario squilibrato, ma non
è colpa dei realizzatori. È abbastanza chiaro che quattro mesi di permanenza in
censura, sforbiciate, raccomandazioni, inviti alla prudenza, minacce di «blocco», devono aver
fatto alla pellicola più danni di un terremoto” [Onorato Orsini, “La Notte”, Jacopetti Files, pagina 58]. Lo scetticismo del giornalista era comunque più profondo: “La
donna nel mondo manca certo di unità e coerenza, e questo è il difetto più
vistoso, un vizio d’impianto che non si può ragionevolmente attribuire
all’intervento della censura” concludeva infatti il critico. [Ibidem]
Le tematiche dei segmenti
sono, in effetti, molto disparate tra loro, del resto questo era stato il
marchio di fabbrica di Mondo cane, ma stavolta la cosa sembra funzionare
meno. Il film si apre sul posteriore ancheggiante di un’elegante signorina,
sulle note spumeggianti delle musiche di Riz Ortolani e Nino Oliviero, ma
presto si arriva alle più sobrie donne soldato israeliane, non prese
propriamente sul serio. Il tono del documentario continua sulla stessa
falsariga, con un vecchio colonnello scozzese che, stando al divertito commento
del confermato Stefano Sibaldi, ha un harem di 84 mogli in una sperduta isola
che, a quanto si può ascoltare, sarebbe abitata da sole donne. Con un tipico
ribaltamento di 180°, si passa quindi in un isolotto-prigione nel mare di
Carpentaria, nel nord dell’Australia, un lembo di terra in mezzo alle acque su
cui sono insediati galeotti che, a quanto si vede, sembrano per lo più
aborigeni.
Qui il tono si fa decisamente più serio e il documentario sfodera uno dei tipici colpi della «Jacopetti e soci», con il riferimento ad un presunto rito d’amore, piuttosto scabroso in realtà, con protagonista un povero dugongo, un animale spesso spacciato per la mitologica sirena dalle leggende dell’oceano Indiano. Il successivo passaggio si sposta in Francia, dove si festeggia la caduta della Bastiglia, con una serie di pubblici ed appassionati baci tra coppie prese tra la gente per le vie parigine. L’accostamento tra gli aborigeni e il loro presunto discutibile culto sessuale e i romantici french kisses potrebbe oggi far pensare ad un paragone palesemente razzista. Ma, questo, come altri «stacchi» del lungometraggio, sembra più che altro il tipico montaggio jacopettiano che gioca con contrasti, assonanze, rimandi, concatenando, ora in un senso, ora nell’altro, i vari segmenti narrativi. In tema di veridicità, rimane clamoroso ed esplicito il monito degli autori a dubitare di quanto si sta vedendo: ad un certo punto Sibaldi, con la sua voce suadente, ci informa che Molière avrebbe citato la Statua della Libertà: peccato che il commediografo francese visse nel XVII secolo, e Miss Liberty fece la sua comparsa sul finire dell’Ottocento! A parte la credibilità di quanto mostrato, tema sempre caldo negli shockumentary –come sono conosciuti i Mondo movie nei paesi anglosassoni– La donna nel mondo lambisce costantemente i contenuti erotici, bilanciati anche da passaggi ora seri, ora meno, dal momento che lo scopo principale del testo è stuzzicare, ma senza esagerare, evitando, al contempo, di annoiare. Così il segmento figurativamente molto bello, con le suore missionarie, che, nei loro candidi vestiti, si recano ad evangelizzare il cuore dell’Africa Nera, è accostato ad alcune modelle, rappresentanti dell’alta moda, che, secondo il commento, si trovano analogamente in quei remoti luoghi per portare la «parola di Dior».
Nel finale, La donna nel
mondo torna ad incupirsi: prima una sorprendente ed esplicita visita in una
moderna sala parto, poi le donne beduine che rischiano la vita tra le dune di
sabbia del poligono di tiro d’artiglieria pesante per recuperare il metallo dei
proiettili, infine un passaggio perfino azzardato, nel suo approccio morale.
Siamo a Liegi, una donna belga ha abortito la figlia vittima di una
malformazione alle braccia: Sibaldi, che quando vuole è assai credibile, nel
commento ce lo presenta come un fatto “straordinario, imprevedibile e moderno”.
«Moderno»: successivamente, il riferimento è alla Talidomide, un farmaco usato
negli anni Sessanta che, come effetto collaterale, causava gravidanze con gravi
alterazioni congenite, in genere del tipo di cui si è accennato in merito alla
signora belga.
Mentre il commento si interroga sul triste stato d’animo della donna, il documentario si sposta in Germania, dove pare vi siano 7800 piccole vittime degli effetti collaterali della Talidomide, accudite con amore dalle rispettive madri e famiglie. Un tema, questo, che inevitabilmente alimentò l’antipatia per gli autori, da parte della sinistra italiana che, sebbene i tempi della legge sull’aborto [Legge 22 maggio 1978, n. 194] fossero ancora lontani, certo già all’epoca si preparava ideologicamente alla battaglia. Il finale chiarisce, d’altronde, a quale approdo Jacopetti mirasse per cercare una sorta di protezione: l’ultimo, toccante, segmento ambientato a Lourdes, prova ad accattivarsi le fantasie della sponda cattolica del paese, mettendosi, di conseguenza, ancora più in contrasto con l’élite culturale italica.
Cercando di fare un
bilancio complessivo, si nota il tentativo da parte degli autori di non scadere
tanto nel maschilismo e nel sessismo, tipici dei sexy-movie scaturiti da Europa
di notte, e nemmeno in un, al tempo forse ancora in divenire sui nostri
lidi, sentimento propriamente femminista. Il quadro generale è, per assurdo, al
netto dei passaggi più fantasiosi, anche credibile, proprio per il suo non
essere faziosamente schierato né con una sponda né con l’altra, almeno tra
quelle più prevedibili. Tuttavia l’impressione di essere di fronte a quello che
in seguito verrà efficacemente definito cerchiobottismo può legittimamente
sorgere, oltre a lasciare la pietanza un po’ insipida. Insomma: un Mondo movie
moderato è, sostanzialmente, un ossimoro.
Al fenomeno dei Mondo Movie, Quando la Città Dorme ha dedicato il secondo volume di studi attraverso il cinema: MONDO MOVIE, AUTOPSIA DI UN GENERE, AUTOPSIA DI PAESE











.jpg)

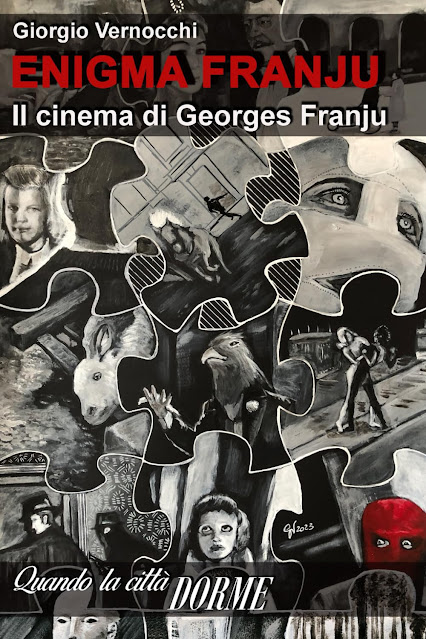












.jpg)




.png)






