IL RITORNO DELLO ZAR: #L'ORA DELLA FINE
1143_KLONDIKE . Ucraina, Turchia 2022; Regia di Marina Er Gorbach.
“Hanno bombardato il passeggino!” Questa curiosa esclamazione racchiude perfettamente lo spirito della guerra in Ucraina anzi, probabilmente della guerra in senso assoluto. Senza alcuna ironia, intendiamoci, perché Irka (un’intensa Oksana Cherkashyna), protagonista di Klondike, non ha alcuna voglia di scherzare dopo che si è ritrovata la casa sventrata da un colpo di mortaio. Il personaggio cardine del fondamentale film di Maryna Er Gorbach è una donna incinta che, nel 2014, vive nell’area del Donbass contesa da nazionalisti ucraini e secessionisti filorussi. Un’area al margine di quella che è la terra al margine per definizione, dal momento che ‘Ucraina’ vuol dire appunto confine o qualcosa del genere. Il tema della marginalità dei personaggi, del loro essere quasi insignificanti rispetto alle forze in gioco – quanto un passeggino che finisce sotto una bomba – è rimarcato dalla storia, dalla stessa struttura del film e perfino dalle scelte registiche della Gorbach che anche in questo particolare specifico si dimostra autrice di rango. Andiamo con ordine e cominciamo con qualche cenno del racconto su cui verte Klondike: insieme al marito Tolik (Sergey Shadrin), Irka vive in una landa desolata con una vacca e qualche gallina. L’uomo è filorusso, mentre Yaryk (Oleg Shcherbina), fratello di Irka, è un fervente nazionalista: Tolik cerca di barcamenarsi come può, mantenendo buone relazioni coi secessionisti ma cercando di non inasprire troppo i rapporti in famiglia. Per la verità con la moglie ci sarebbe anche un bel legame intimo di coppia ma la pesantezza della guerra, non ultimo il bombardamento che devasta la loro casa, rende le cose molto più difficili, con la donna sempre più insofferente.
Irka ha ragione da vendere, sia chiaro, soprattutto quando vede i miliziani filorussi spadroneggiare e fare i prepotenti, sequestrare la loro auto e pretendere dal marito che la vacca venga macellata e consegnata per sfamare i militari. Da parte sua Tolik, pur palesando simpatie politiche per gli occupanti, rivela anche una natura pratica badando alla sicurezza e alla sopravvivenza della famiglia, considerato che Irka proprio non ne vuole sapere di lasciare la sua terra. Con Yaryk, invece, l’uomo è in aperto contrasto, anche per via dell’intransigenza del cognato, arroccato su posizioni nazionaliste. Appare quindi chiaro che le ragioni che minano la serenità famigliare sono tutte di natura geopolitica, almeno per quel che si vede. Se ne potrebbe quindi dedurre che il conflitto non è una logica conseguenza di una situazione che arrivi dal campo ma, al contrario, sia vero che l’odio che si va propagando tra la popolazione sia stato indotto dalle scelte politiche e militari dei potenti.
Il ruolo passivo della popolazione, di cui la famiglia protagonista di Klondike può essere un efficace campione, è evidenziato dal loro essere spettatori. Sul muro hanno un telo che propone uno scorcio tropicale, che possono guardare sognando di essere al mare; oppure possono semplicemente guardare la televisione, uno dei pochi elementi moderni della casa. Quando la bomba gli squarcerà il soggiorno, potranno direttamente godersi i tramonti del Donbass dall’impolverato divano. Sono semplici spettatori, fuori campo rispetto al centro dell’azione e se per disgrazia ci finiscono in mezzo, non è mai un buon segno, si veda appunto il bombardamento come esempio. Il tema del fuori campo è il tema di Klondike che prova a ribadire le ragioni di chi è tenuto ai margini: non a caso il film è dedicato alle donne che, nelle guerre, sono relegate fuori dalla scena pur pagando conseguenze durissime.
L’idea di mettere al centro del racconto l’abbattimento dell’aereo malese MH17, che costò la vita a 298 persone, è emblematico: l’evento non fu rimarcato come avrebbe dovuto, dal momento che, errore di valutazione o meno, si trattò di un fatto gravissimo. I tentativi di insabbiare le responsabilità da parte degli occupanti filorussi dell’area furono probabilmente efficaci ma, al di là dell’unanime cordoglio, la comunità internazionale si interessò relativamente poco alla cosa, come del resto fece per il conflitto nel Donbass, almeno fino al 24 febbraio del 2022. Eppure, l’avvistamento, nei pressi dell’area dell’abbattimento del MH17, di un Buk, un sistema missilistico di fabbricazione russa, smentiva palesemente le dichiarazioni di Putin. Nel film il mezzo militare si vede prima arrivare e poi andare in direzione opposta; non è un vezzo narrativo, visto che si tratta di un passaggio cruciale, una tangibile prova dell’ingerenza militare del Cremlino già da allora, oltre che della malafede nelle dichiarazioni di facciata. Nonostante questo, come detto, l’occidente non prestò particolare attenzione al significato dell’accaduto. Questa indifferenza è, come detto, tema del film anche se si rivela in un certo senso reciproca: se la Russia è evocata più volte come coinvolta, perfino nella provocazione di Tolik che risponde a Yaryk che il figlio in arrivo si chiamerà Vladimir, l’Europa è sostanzialmente ignorata. Per la regista è probabilmente più importante sottolineare l’influenza americana, tanto che il titolo del film richiama un’area degli Stati Uniti ricca di miniere, proprio come il Donbass. Interrogata in proposito, ovvero sul motivo della scelta di un titolo così criptico, la Gorbach ha dichiarato: “Se qualcuno può chiamare un lanciarazzi col dolce nome femminile di Katyusha, allora io posso a mia volta chiamare il film Klondike, perché credo anch’io nel fantasma degli Stati Uniti.”
Nonostante si tratti di un testo dai contenuti così rilevanti, uno degli aspetti più interessanti e originali di Klondike è anche di natura squisitamente tecnica. Il ritmo del racconto è lento e la macchina da presa si muove quasi con circospezione, del resto si è detto che la messa a fuoco del film non è al centro dell’azione. La ripresa caratteristica più tipica di Klondike è un carrello laterale che spesso si perde i personaggi, superandoli oppure venendo lasciato indietro dal loro muoversi, in ogni caso finendo per mettere in scena il fuori campo. La scena emblematica in questo senso è nel finale, quando la macchina da presa in un primo momento segue Tolik e il miliziano che si avventurano in un luogo che si intuisce sarà fatale. Pur essendo ufficialmente un filorusso, l’uomo ha infatti appena ammesso di aver visto qualcosa di troppo in merito al citato abbattimento del Boeing malese MH17. La macchina da presa nel suo incedere a fianco degli uomini scorre leggermente in avanti, lasciandoli indietro: quando si ferma, compare sullo schermo Yaryk che Tolik teneva legato in cantina e che i miliziani hanno evidentemente trovato. Stavolta il fuori campo non è vuoto ma ha riservato una sorpresa, perché prima o poi i nodi vengono al pettine.
E’ una svolta, una
svolta finale, chiaramente tragica. Del resto, non ci si può certo aspettare un
lieto fine, almeno non in Ucraina e tanto meno nel Donbass. Eppure Yaryk e
Tolik, pur nel deplorevole detestarsi vicendevolmente, troveranno il modo,
tragico fin che si vuole, di uscire con onore dalla situazione disperata in cui
finiscono per trovarsi. E non è poco. Ma ancora meglio farà Irka. E’ sola, in
mezzo al nulla, in una casa diroccata, con spietati criminali in divisa che si
aggirano nei dintorni; è incinta, povera ragazza, cosa mai potrebbe succederle?
Che le si rompano le acque, che domande. Nella scena di parto più esplicita e
insostenibile della Storia del Cinema, Ykra si contorce per il dolore sul
divano impolverato dai detriti, mentre uno dei militari le passa accanto nella
più totale indifferenza, preoccupato di recuperare le sue armi. Ma si è detto,
l’indifferenza può finire per essere reciproca. Mentre Ykra recide a mani nude
il cordone ombelicale, il militare se ne va. Silenzio, la tensione lascia il campo
alla paura: poi, il pianto infantile e possiamo tirare il fiato. Nonostante le
avversità, anche oggi la vita ha vinto la sua battaglia. Quando i maledetti
guerrafondai si renderanno conto dell’inutilità del loro affannarsi, sarà
sempre troppo tardi. Ma la granitica convinzione che la vita non si farà mai piegare
è il messaggio che Klondike, in modo forse insospettabile visto la crudezza,
ci lascia dentro. Perché, manuale del cinema alla mano, se nasce un bambino nel
finale del film c’è un solo significato possibile.
E non c’è alcuno motivo di dubitarne: Klondike è
un film ottimista.
Oksana Cherkashyna
Galleria di manifesti





.jpg)


.jpg)






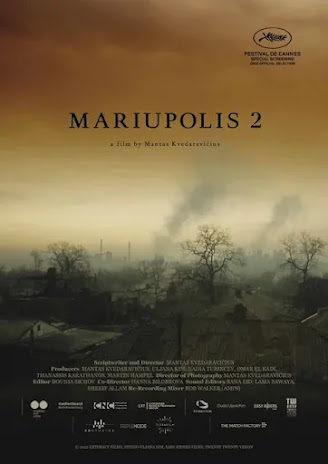












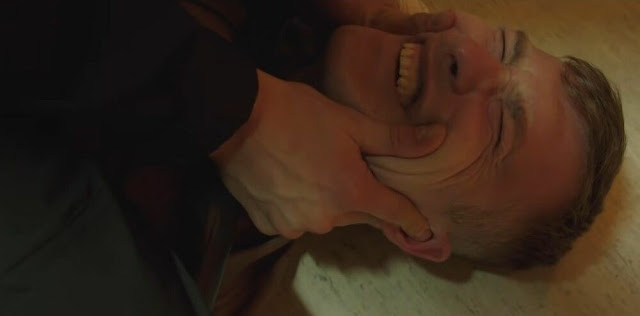









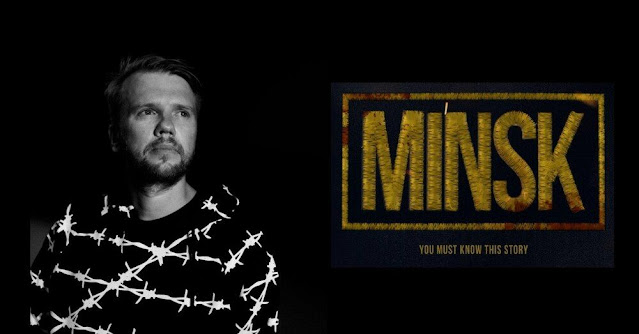















.jpg)







