1501_FURIA (Fury). Stati Uniti 1936; Regia di Fritz Lang.
Lang non era arrivato nel Nuovo Continente che da pochi giorni, che Selznick cambiò idea sull’opportunità di realizzare il film che stava progettando insieme al regista. Il 22 giugno il vulcanico produttore ufficializzò la rinuncia: come si vede, a strettissimo giro di posta. Per comprendere come sia possibile che un cineasta arguto come Selznick vada a prelevare in Europa un regista come Fritz Lang promettendogli di fare un film per poi cambiare idea nell’arco di una ventina di giorni, è forse utile ricordare che, in quel fatidico 1934, esattamente il 13 giugno, entrò in vigore un emendamento del famigerato Codice Hays, che istituì la PCA, Production Code Administration, senza il cui certificato i film non sarebbero potuti approdare nelle sale a partire dal primo luglio. Il primo film a subire gli effetti del Production Code –che era quindi un codice auto-impostosi da Hollywood al fine di evitare noie con la censura – fu Tarzan e la compagna [Tarzan and his mate, 1934, di Cedric Gibbons] per via delle scene di nudo della controfigura dell’attrice protagonista Maureen O’Sullivan. <http://en.wikipedia.org/wiki/Hays_Code visitata l’ultima volta il 13 giugno 2024>.
In quel particolare frangente, in cui la PCA non era ancora operativa, Selznick si rivolse direttamente a Will H. Hays per chiedere consiglio riguardo al suo progetto con Lang. Ciò che preoccupava il produttore era il tema del film, nel quale un gruppo sovversivo arrivava a rovesciare il governo. Il 18 giugno, Hays rispose così a Selznick: “A seguito della nostra conversazione relativa al film preso in considerazione per il signor Fritz Lang: il signor Pettijohn è tornato da Washington e vi allego il suo memorandum originale dell’ufficio che mi riporta il suo colloquio con il Dipartimento di Giustizia su questo argomento. É mio giudizio ragionato, con il quale il signor Pettijohn è d’accordo, che in ogni circostanza non sarebbe saggio procedere con il film contemplato e me ne raccomando”. Selznick non poté che convenire: “Caro generale Hays, ho ricevuto una lettera da Charlie Pettijohn che afferma la violenta obiezione del Dipartimento di Giustizia all’idea del film suggerito dal signor Fritz Lang e a Voi sottoposto attraverso la mia proposta. Mi rammarico enormemente che non ci sia altra strada se non quella di abbandonare l’idea, anche se penso che avremmo potuto svolgere un vero servizio pubblico”. <http://starsandletters.blogspot.com/2014/06/selznick-abandons-fritz-lang-project.html visitata l’ultima volta il 13 giugno 2024>. Sebbene cerchi di salvare in parte la faccia, è evidente che Selznick scarichi abbastanza rapidamente Lang, sottolineando come l’idea del film fosse del regista quando, dal momento che era stato da pochissimi giorni ingaggiato, è più che probabile che il produttore ne condividesse lo spunto. Tra le note di curiosità si può segnalare che Selznick si rivolga a Hays con l’appellativo di «generale», forse in quanto questi era stato Direttore Generale delle Poste degli Stati Uniti, mentre il citato Charlie Pettijohn era il Consigliere Generale dell’MPPDA, la Motion Picture Producers and Distributors of America, l’organizzazione guidata appunto dallo stesso Hays attraverso l’applicazione del noto codice di autocensura. Come detto, di lì a poco sarebbe entrata in vigore la PCA affidata a Joseph Breen, che inasprì pesantemente l’autocensura e il cui avvallo divenne vincolante per ottenere il visto di distribuzione: il clima, effettivamente, non era quindi dei migliori. In questo contesto, forse presentarsi da Hays con una proposta che aveva visto la “violenta obiezione” addirittura del Dipartimento di Giustizia del paese non era certo stata una mossa tempestiva. Per capire: Pettijohn faceva parte dell’entourage del Presidente Frank Delano Roosevelt, e il Dipartimento di Giustizia, in quel periodo, era in febbrile attività anche mettendo sotto osservazione il mondo del cinema. I crime movie del tempo esaltavano le imprese dei gangster, mentre i poliziotti, al loro inseguimento, dovevano fermarsi ogni volta che questi fuorilegge passavano un confine di Stato, facendoci ben poca figura. Se, per combattere direttamente il crimine, l’amministrazione Roosevelt intendeva riorganizzare il braccio armato del Dipartimento di Giustizia, ovvero quell’istituzione di polizia federale che, dal 1935, prenderà il nome di FBI, sul piano prettamente propagandistico Hays e soprattutto Breen si diedero da fare per contrastare il dilagante fenomeno di romantica ammirazione per Dillinger e compagni che il cinema aveva fin lì suscitato.
Il cineasta intellettuale, che, arrivando dalla Germania nazista con un atteggiamento che “suscitava incredibile rispetto e un’impressione di autorevolezza”, proponendo un film che ipotizzava movimenti sovversivi negli Stati Uniti, non si guadagnò certo il favore dell’ambiente.
Il progetto originale era quindi scartato; in ogni caso, il contratto c’era e un film andava realizzato. Mentre Lang ne approfittava per guardarsi un po’ in giro, in cerca di ispirazione, nel mese di settembre di quel 1934 la SS Morro Castle, un transatlantico americano in rotta da Cuba a New York, prese fuoco e s’incagliò, causando la morte di oltre cento persone. Con l’aiuto di Oliver H. B. Garret, il regista non padroneggiava ancora la lingua inglese, Lang mise giù una sceneggiatura, Hell Afload [t. l. L’inferno galleggiante], anche nota come The journey [t. l. Il viaggio]. Stando alle parole dello stesso regista, sul momento l’idea sembrava potesse funzionare: “A Selznick piacque molto, alla vigilia di Natale; dopo tre giorni era la cosa più disgustosa che avesse mai letto”. [Peter Bogdanovich, Il cinema secondo Fritz Lang, Parma, Pratiche Editrice, 1988, pagina 17]. Successivamente sviluppò Passport to Hell [t.l. Passaporto per l’Inferno], un trattamento da un racconto di James Warner Bellah, uno scrittore di pulp-fiction che sottolinea l’approccio di Lang all’America. Il regista dichiarò che imparò molto, nei suoi primi mesi negli Stati Uniti, dalla letteratura popolare e dai fumetti, che gli furono utili per comprendere la differente natura del paese che l’ospitava rispetto alla patria natìa. In ogni caso nemmeno questo progetto andò in porto come del resto anche l’interessante aggiornamento della vicenda del Dottor Jekyll e Mister Hyde, The Man behind You [t. l. L’uomo dietro di te], una sorta di studio sulla personalità schizofrenica. Niente da fare; ricorda, in proposito, Lang: “per un anno, non mi fu data l’opportunità di fare niente, e così cercai di imparare il più possibile dalla vita americana” [Peter Bogdanovich, Il cinema secondo Fritz Lang, Parma, Pratiche Editrice, 1988, pagina 17].
Alla MGM erano però scontenti e uno dei dirigenti dello Studio, Eddie Mannix, parlò con il regista paventandogli l’ipotesi di essere licenziato. Lang ottenne però un’ultima chance: gli fu consegnata Mob Rule [t. l. La legge della folla], una scaletta di quattro pagine con quello che sarebbe divenuto il soggetto di Furia [Fury], scritta da Norman Krasna, e gli fu affiancato un collaboratore, Bartlett Cormack, dal momento che il regista non era ancora autosufficiente con l’inglese. Tuttavia Lang si aiutava molto, nel lavoro di stesura, collezionando ritagli di giornale da cui trarre ispirazioni e spunti; utilizzando i quotidiani americani, era quindi in grado di interpretare a dovere la vita di un paese anche se lo conosceva poco. Tuttavia, nel momento di cominciare la stesura definitiva della sceneggiatura, il regista nato a Vienna dimostrò di non aver ancora colto l’essenza della cultura americana. Secondo la primissima versione di Furia, il protagonista, Joe Wilson, poi interpretato da Spencer Tracy, era un avvocato. Questo, secondo quanto racconta Lang nel fondamentale libro intervista a Peter Bogdanovich, avrebbe permesso a Joe Wilson di potersi esprimere meglio, di poter spiegare in modo più esauriente, i propri pensieri. Conoscendo Fritz Lang, viene da supporre che la svolta rabbiosa che intraprende l’uomo, una volta scampato al linciaggio, avesse a quel punto una forza maggiore, un’importanza più clamorosa, se a farla fosse stato un uomo di legge. Joseph L. Mankiewicz, al tempo neo produttore della MGM, spiegò al regista venuto dall’Europa che in America, il protagonista doveva essere «Joe Doe», Jane nel caso fosse una donna: qualcuno del popolo. E fu convincente, tanto che Lang pensò che questo era un segno della democrazia; il che era vero, naturalmente, dal momento che la forza rivoluzionaria del cinema americano era appunto quest’approccio popolare. É però innegabile che immaginare un distinto avvocato nei panni del Wilson divenuto brutalmente belluino, al punto da voler ardentemente veder finire sulla forca tutti i 22 individui che avevano preso parte al linciaggio, avrebbe dato ancora più forza al concetto. Argutamente, Paul M. Jensen nel suo The cinema of Fritz Lang notò come Furia, il primo film americano di Lang, avesse la struttura della sua opera forse più importante del periodo tedesco, almeno dal punto di vista culturale, I Nibelunghi, [Die Nibelungen: Siegfried + Die Nibelungen: Kriemhilds Rache,1924]. In questo caso, Joe, il protagonista è prima la vittima Sigfrido e, nella seconda parte, la vendicatrice Crimilde, confermando però i progressi psicologici già manifestati in M – Il mostro di Dusseldorf [M, 1931]. Joe, infatti, è personaggio moderno, non è completamente buono o cattivo, ma muta, nel corso della vicenda, si evolve sia in chiave positiva che negativa. Rispetto ai suoi formidabili sviluppi successivi, all’interno del cinema americano, Lang in Furia conserva qualche aspetto di troppo del suo bagaglio tedesco, in particolare il ricorso ad un simbolismo un po’ stucchevole. In seguito, lo stesso autore riconoscerà questo limite, in questa sua opera: “In Germania usavamo molto i simboli. Un simbolo deve spiegare qualcosa. Per esempio ne I Nibelunghi i due amanti sono seduti sotto una pianta in fiore (…) E così, dopo che se ne sono andati dal giardino, lei guarda l’albero dalla finestra, e improvvisamente vede questi fiori dissolversi e comparire un teschio. Questo è un simbolo per mostrare un pericolo incombente, un oscuro presagio. In Furia c’era una scena in cui mostravo il diffondersi di un pettegolezzo: una donna inizia a parlare, poi un’altra e un’altra ancora – dopo di che facevo una dissolvenza su alcune galline, che facevano lo stesso rumore. Lo stesso produttore che mi aveva parlato di Joe Doe (quindi probabilmente Mankiewicz, NdA) disse: «Fritz, agli americani non piacciono i simboli. Non sono così stupidi da non capire senza». E aveva ragione. Non so se l’ho tagliata o meno – ma aveva assolutamente ragione. Tutti sanno cosa fanno le donne pettegole”. [Peter Bogdanovich, Il cinema secondo Fritz Lang, Parma, Pratiche Editrice, 1988, pagine 27 e 28]. La scena è rimasta e, se è vero che crea un effetto ridondante, insistendo su un concetto già evidente, è anche vero che inserisce una vena ironica –il paragone tra le donne e le galline– e che, quindi, gratuita del tutto non è. Un aspetto non secondario: in sé Furia non è particolarmente «leggero», c’è un po’ di accorato romanticismo nella prima parte, che serve, per altro, a preparare il «terreno» alla svolta drammatica. Ma quel paragone ironico evidenzia come la situazione degeneri, e gli abitanti di Strand si trasformino in una folla inferocita, in seguito ad un meccanismo messo in moto superficialmente, senza riflettere. Senza cattiveria, nel senso di piena consapevolezza, ma con una superficialità tale che rende difficile non condividere il risentimento che Joe non riuscirà mai a vincere del tutto nei loro confronti. Racconta, sempre Lang nell’intervista con Bogdanovich, che la MGM non gradì affatto Furia. Addirittura Eddie Bendix, il dirigente che gli aveva affidato l’incarico per il film, lo accusò di aver cambiato qualcosa rispetto alla sceneggiatura. Come detto, il regista non se la cavava ancora così bene con l’inglese e, quindi, la cosa non era molto probabile; in ogni caso, su consiglio dello stesso Lang, vi fu un rigoroso controllo, copione alla mano, della pellicola. Nel frattempo, l’autore viennese venne “messo in castigo” con un’umiliazione pubblica che, nel 1965, oltre trent’anni dopo, sembrava ancora far male al regista di Metropolis. Il verdetto di Bendix fu emblematico: “Sì, hai ragione c’è (attinenza alla sceneggiatura, NdA) ma SEMBRA una cosa diversa sullo schermo!”. [Peter Bogdanovich, Il cinema secondo Fritz Lang, Parma, Pratiche Editrice, 1988, pagina 32]. Quello che avvertirono Bendix e gli altri dirigenti della MGM era l’essenza del cinema di Fritz Lang: in Furia, faticava ancora un po’, a trovare la giusta quadra all’interno del cinema americano, ma era già presente in forma cristallina. In seguito questa capacità del maestro troverà la sua massima espressione nei noir degli anni Quaranta e Cinquanta, ma Furia ne era già un sublime esempio. La storia di vendetta personale era un classico di Hollywood, e la morale era sempre che la vendetta non portava alcun beneficio, per chi la metteva in atto. Che è, in sostanza, la stessa conclusione che si può trarre da Furia, beninteso, come aveva dovuto ammettere a denti stretti persino Bendix. Quello che cambiava, era il rigore della messa in scena che contrastava l’emotività della storia, mantenendola viva e pulsante, ardente: in genere, i registi, dopo aver infiammato gli animi con qualche passaggio focoso, prendevano le distanze dalla violenza, in modo da condannarla. Lo spettatore seguiva ipocritamente questo percorso, prima facendosi prendere dall’enfasi e poi, nel finale, se non accusando il comportamento violento di turno, assai più spesso cancellando tutto con un colpo di spugna e celebrando idealmente il lieto fine insieme ai protagonisti. Lang non era tipo da sconti. Era, per sua stessa ammissione, un perfezionista, una persona meticolosa nel lavoro, e lo era anche dal punto di vista morale ed è proprio qui, nella sua statura etica, che risiede la sua grandezza. Per questo arrivò a dire, a proposito di Furia, che odiò il bacio finale, che rendeva sdolcinata e priva di rigore morale tutta quanta la storia. Joe non si meritava, almeno non così in fretta, di convolare con la sua bella Katherine (Sylvia Sidney), non dopo quello che aveva fatto nella seconda metà del film. In effetti, nel discorso finale, Lang fa precisare a Joe che dovrà pagare per il suo inganno alla corte del tribunale e alla collettività, nonostante lo stesso autore, è esplicitamente evidente, condivida il rancore che l’uomo prova nei confronti di quegli individui che, solo qualche tempo prima, avevano provato a mandarlo arrosto. È questa la forza del cinema di Fritz Lang: Joe non dimentica coloro i quali lo volevano linciare, e nemmeno li perdona. Il perdono non è, come il cinema e con esso tutta quanta la nostra cultura recente ha insegnato, un voltar pagina e pensare ad altro. Il perdono è una conquista dura e faticosa e non è qualcosa che ci verrà concesso, ma che dovremo meritare. Non è, quindi, compito di Joe, perdonare i suoi linciatori: essi dovranno fare i contri con la propria coscienza, e in questo senso ci sono le parole di Katherine a chiarire il punto di vista del regista. Se Joe non deve marcire nel rancore, e peggio ancora nella vendetta, è perché così facendo perde sé stesso e, in effetti, per buona parte del film, quando la brutale voglia di rivalsa lo pervade, egli è ufficialmente perfino morto. La capacità di Lang, quella che sfugge agli uomini della MGM, è di mantenere vivi questi sentimenti potenti, la rabbia di Joe o l’angoscia degli abitanti di Strand, che non sfociano mai in banali finali consolatori. Non si può convivere pacificamente con sé stessi dopo aver linciato un uomo: nemmeno se questo è scampato e se dovesse perdonarti. Bisogna certamente imparare a convivere coi propri demoni, e cercare di soffocarli, come spiega bene Joe, nel finale, rivolgendosi ai ventidue che tentarono di linciarlo: non si vendica ma neppure può perdonare così, con un nonnulla, una cosa di una tale gravità. Perfino dimenticare è impossibile ma proverà ad andare oltre. Se questi disgraziati riusciranno a far pace con la propria coscienza, non è affar suo ma loro: loro sono i rimorsi, e loro deve essere il percorso di redenzione. Ad Hollywood, il pragmatismo americano non aveva tempo per questi sofismi e, in genere, un lieto fine riusciva a lenire tutti i problemi, comprese le coscienze del pubblico nel caso l’opera avesse avuto una qualche forma catartica – cosa per niente infrequente con il cinema. Quello che Lang riuscì subito a cogliere del cinema americano è la responsabilità individuale del protagonista: Joe è un brav’uomo, diventa una belva in seguito ad un’ingiustizia ma saprà, finanche con l’aiuto di Katherine, fermarsi prima di commettere l’irreparabile. La vita è una questione di scelte e, per alcune di esse, non c’è poi tutto questo margine: e questo è meglio tenerlo bene a mente.



.jpg)





.jpg)





.jpg)


























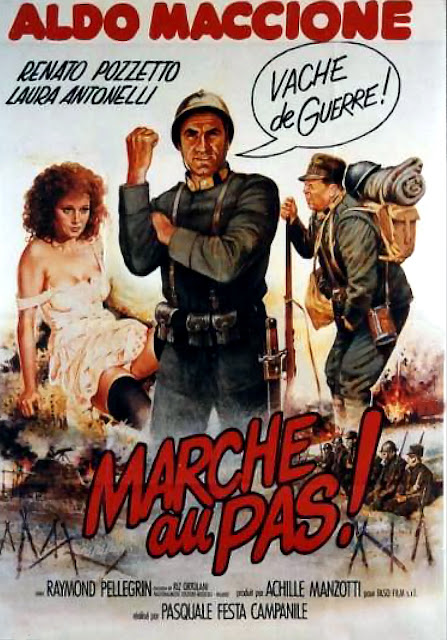










.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)


.jpg)