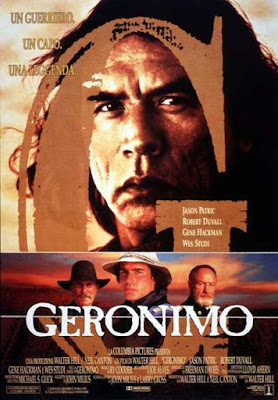273_LE FATICHE DI ERCOLE; Italia, Spagna, 1958; Regia di Pietro Francisci.
Quando si parla del peplum
italiano, tra i primi film citati c’è sempre Le fatiche di Ercole di Pietro Francisci. Questo non perché sia il
primo film in ordine di tempo: Le fatiche
di Ercole è del 1958 e già negli anni dieci del XX secolo in Italia si
erano prodotti lavori come Quo Vadis?
o Cabiria. E probabilmente nemmeno il
più interessante come vicenda raccontata; così come non è certo il più rilevante dal punto di vista
del casting, criterio cruciale in un genere
così imperniato sulla fisicità degli attori, se pensiamo che celebrità come
Kirk Douglas, Anthony Quinn o Mario Girotti, avevano già frequentato il peplum italiano in precedenza. Per tacer
delle attrici più in voga, le star
nazionali e non solo, da sempre appetibili in un genere che permetteva di
esaltarne il fascino senza troppe reticenze narrative. Ma il rilievo dato a Le fatiche di Ercole è sacrosanto; è un
film giustamente considerato fondamentale, sebbene più all’interno del genere peplum che in quello cinematografico
complessivo. Perché il film di Francisci è perfettamente oliato in tutte le sue
componenti e fila liscio come una palla sul biliardo: che in fondo è il
requisito più importante richiesto al tenore di questo tipo di pellicole. La storia
è vagamente ispirata al poema epico Le
argonautiche di Apollo Rodio ma Francisci si prende le libertà che gli
fanno comodo (come l’inserimento di Ulisse nell’equipaggio della Argo) per
imbastire un’avventura che sfrutti tutti i rimandi culturali possibili per aumentarne il fascino epico. Il tono
oscilla tra l’avventuroso e il romantico con passaggi anche da commedia, come
quello che vede coinvolte le amazzoni, sebbene il clima sia appena spruzzato di
piccante.
Per la verità Francisci indugia con insistenza sulle carni scoperte
delle guerriere, tra le quali spicca la regina Antea, interpretata con la
giusta presenza scenica da Gianna
Maria Canale pur senza esagerare. La
Canale è bella ma la figura femminile di spicco in questo
film è certamente Sylvia Koscina, nei succinti panni di Iole, giovane,
avvenente e luminosa. In ogni caso, non ce ne vogliano le due bellissime donne,
ma il primo piano in quest’opera è totalmente di diritto di Ercole, a cui lo
scultoreo Steve Reeves presta volto e poderoso fisico. Ma non è per la sua
prestanza, per altro impressionante, che il semidio si conquista senza indugio
il centro della scena. Quello che garantisce il primato ad Ercole è piuttosto
la statura morale; da cui derivano un comportamento coerente e coraggioso e un
linguaggio fermo, saldo e determinato, tanto che le sue parole sembrano
scolpite nella pietra. Nella sua rappresentazione cinematografica, e questo è
il merito maggiore dell’opera, Francisci ci regala un Ercole che, al di là dei
muscoli esibiti, è davvero un eroe. E un eroe vero, è sempre benvenuto.
Gianna Maria Canale
Silvya Koscina