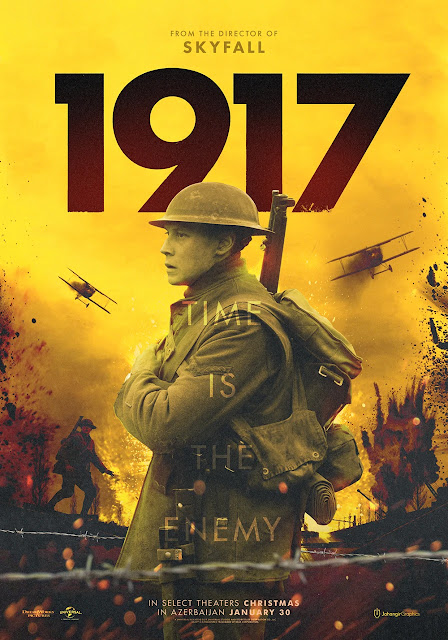1462_COMPANY K . Stati Uniti 2004; Regia di Robert Clem.
Alla base di questo film diretto da Robert Clem, c’è l’omonimo romanzo di William March, uno scrittore veterano e decorato della Prima Guerra Mondiale, il cui vero nome era Campbell. Tuttavia il protagonista di Company K, che è un testo fortemente autobiografico, viene chiamato Joseph Delaney (Ari Fliakos), volontario che si aggregò nel corpo dei Marines americani. Delaney e i cuoi commilitoni della Compagnia K, vennero poi spediti a combattere in Francia, da Verdun alla battaglia di Blanc Mont Ridge, dove il protagonista ottenne le citate decorazioni, come possiamo apprendere dai titoli di coda del film di Clem. Film che è una riflessione contro la guerra che si lascia apprezzare per la sincerità del testo pur non essendo, come opera filmica in sé, un lavoro di livello particolarmente elevato. Dalla regia, all’ambientazione, fino alle prestazioni attoriali, sono molti i rilievi che, volendo, si possono muovere a Company K ma, è palese, sin da subito, che non siamo di fronte ad un’opera mainstream e, quindi, un certo grado di clemenza è legittimo. In ogni caso, sebbene ci sia qualche riferimento a battaglie o eventi storici, la prospettiva di sguardo che conserva Clem è quella del soldato semplice, il private, sebbene non manchino i “paragrafi” dedicati a sergenti o sottotenenti. Il racconto filmico è, in effetti, scandito da didascalie che mettono l’accento ora su questo ora su quel personaggio della storia. Quello che preme agli autori, a March e di riflesso a Clem, è raccontare la guerra dal punto di vista di questi personaggi, di chi la subisce e ne subisce l’assurdità, piuttosto di chi prenda le decisioni strategiche. Ma, anche in questo caso, dopo aver trovato la linea generale che caratterizza l’opera, dobbiamo rilevare qualche eccezione, ad esempio nel passaggio in cui il tenente Smith (Lee Rosen), un novellino appena arrivato in prima linea, manda i suoi uomini incoscientemente incontro alla morte, nonostante il parere contrario del sergente Prado (Matt Seidman). I suoi tormenti, in seguito a questa scellerata decisione, fanno parte di un segmento intimistico/allucinante del film, che lascia, onestamente, un filo perplessi. Dall’apparizione di Gesù Cristo in trincea, al soldato Carter (Steve Cuiffo) che sogna di uccidere proprio il tenente Smith: o l’ha davvero infilzato con la sua baionetta? Carter era sfinito, non aveva chiuso occhio per giorni ma il tenente dimostrava ancora la sua noncuranza nei confronti dei suoi uomini: gli aveva quindi comandato di accompagnarlo in quest’ultima uscita di pattuglia. Ora Carter se lo trovava lì, davanti alla lama della baionetta, in un luogo isolato, proprio colui era anche il responsabile della morte dei suoi compagni di reparto nell’episodio citato.
Il soldato, sfinito, non era propriamente lucido, o forse lo era anche troppo, fatto sta che la tentazione era irresistibile. Quando il private si risveglia sulla sua brandina, il dubbio che aleggia su come possano essere andate le cose, non è affatto male, anche se, bisogna ammetterlo, sarebbe servito un po’ di “manico” in regia per valorizzarlo al meglio. Al di là del fatto che questa escursione onirica è comunque importante, nell’economia del film, rivelando lo stato allucinato in cui versavano i soldati, il momento davvero cruciale è quello in cui vengono uccisi i prigionieri tedeschi. Anche la fine del soldato Geils (James Knight) freddato quasi in principio dal sergente Pig Iron Riggin (Daniel Stewart Sherman), per la sua codardia durante uno dei folli assalti tipici della Grande Guerra, è scioccante, è vero. Ma, per assurdo, neanche più di tanto. Pig Iron, nonostante nell’epilogo, ambientato anni dopo, si mostri cameratesco e sorridente, non riesce proprio ad essere simpatico, non dopo quel mortale colpo di pistola al povero soldato Geils. Tuttavia si tratta di una decisione presa durante un delirante attacco, sotto il martellante fuoco tedesco e, nella distorta ottica militare, anche allineata alla filosofia bellica: la codardia di fronte al nemico era punibile con la corte marziale. Il sergente avrebbe semplicemente abbreviato i tempi, diciamo così. Assai diversa la posizione del capitano Matlock (Rik Alan Walter) che rivela la sua bieca natura in un passaggio narrativo ben costruito anche a livello filmico da Clem. Sono appena stati catturati alcuni tedeschi e il giovane ufficiale, mentre li guarda da una finestra di una baracca in legno, osserva come sarebbe più semplice farli fuori con una mitragliatrice e togliersi il pensiero. Il sergente Dunning (Terry Serpico) è seduto sul tavolo, nella baracca, mentre si accende una sigaretta, e ride alla battuta del superiore, rispondendo con un ironicamente rispettoso “Signorsì”. Ma il capitano non è per niente ironico, e prosegue il suo allucinante discorso. Il sergente e gli altri soldati presenti, sentendo le parole dell’ufficiale e cominciando a comprenderne i reali intenti, si raddrizzano, quasi a portarsi sull’attenti. Dunning è ora in piedi, guarda attonito gli altri mentre il capitano ripete la domanda: “Ha capito, sergente?” Il sottoufficiale ora risponde con maggiore rigore e disciplina, i suoi marziali “signorsì” diventano anche un modo per prendere le distanze dall’aberrante decisione del suo superiore.
Qualcuno tra la truppa, troverà poi il modo di giustificare la decisione del capitano, di uccidere i prigionieri a sangue freddo, tirando in ballo i giornali e una presunta tattica dei tedeschi che farebbero volontariamente catturare i propri soldati al nemico, per poi avere una forma di forza infiltrata oltre le linee avversarie. Ma la cosa suona posticcia mentre più credibile è la scena dell’eccidio, anche perché raccontata da una persona presente sul fatto, da uno dei soldati. Nel racconto, come detto, il narratore è il private Delany che impersona lo scrittore William March che, al secolo, era William Edward Campbell: già questa frammentazione della personalità, seppure dettata da esigenze letterarie, ci dice della propensione alla coralità narrativa dell’autore del testo, una propensione raccolta e conservata poi dal regista del film Clem. Una citazione, all’inizio della pellicola, ci avverte che, dopo aver osservato tanti compagni affrontare le atrocità della guerra, l’autore si è reso conto che nessuno le recepisce allo stesso modo e che nessuno ne rimane immune. Quello che si può dire, e si può dire con certezza e a maggior ragione dopo aver vissuto le diverse esperienze di differenti persone raccontate, a suo modo, mirabilmente in Company K, è che la guerra sia un orrore da evitare a qualunque costo.
Galleria