1700_FRATELLI D'ITALIA , Italia 1952. Regia di Fausto Saraceni
Ingiustamente relegato in quel limbo dell’anonimato in cui l’intellighenzia italiana del dopoguerra segregò tutti i riferimenti patriottici italiani, Fratelli d’Italia è un onesto film che racconta una fase importante della nostra nazione. Per nazione, letteralmente, si intende quella comunità che ha in comune origine, lingua e storia e, quindi, il fenomeno dell’irredentismo istriano, oltre a non essere campato in aria, appartiene di diritto al nostro vissuto. Era evidente che, nel 1952, a Seconda Guerra Mondiale appena conclusa, la questione fosse spinosa, visto che a liberare l’Italia pochi anni prima erano stati quegli stessi americani che, per mano del presidente Wilson, avevano arbitrariamente deluso le nostre più o meno fondate istanze sulla questione istriana. In Italia, si sa, c’è sempre la mania di essere più realisti del re, ed ecco quindi che l’élite politico culturale del nostro paese troverà il modo di compiacere i nuovi alleati (in cambio di copiosi aiuti e finanziamenti, questo va riconosciuto) andando a epurare dalla nostra tradizione popolare tutti quei riferimenti scomodi alle nuove esigenze. La figura di Nazario Sauro fu tra quelle che pagò questo scotto così come quella di Enrico Toti o di Francesco Baracca. Per decenni, in Italia, i ragazzini conosceranno a menadito le imprese di Davy Crockett e del colonnello Custer, mentre le figure storiche di eroi italiani come Toti, Sauro, Cesare Battisti (il patriota, non il terrorista) e compagnia resteranno completamente ignote. Certamente il cinema fece la fortuna degli Stati Uniti, della sua storia e della sua cultura ma non è che in Italia non conoscessimo la settima arte. Purtroppo, come si è detto, l’élite artistica sposò in toto una linea diversa, dando vita a fenomeni cinematografici di primo livello (ad esempio il neorealismo) ma raramente qualcuno si prese la briga di ribadire il valore e l’eroismo di certi nostri compatrioti. Anche perché, l’intellighenzia (ovvero l’élite intellettuale non artistica) operò in modo sistematico tacciando di anacronismo (nel migliore dei casi) questi argomenti sbandierando continuamente lo spettro del fascismo. In realtà, oggettivamente, per quel che riguarda i temi della Prima Guerra Mondiale, il fatto che il regime del Ventennio avesse utilizzato tutta la retorica possibile inerente alla Vittoria (e ancor più alla Vittoria mutilata), questo non rendeva questa materia necessariamente di loro esclusiva competenza. I Toti o i Baracca erano stati e continuano tutt’ora ad essere eroi italiani. A quel tempo l’Italia, giuste o sbagliate che fossero le scelte che prese il governo in carica, chiese a questi uomini di combattere e questi uomini fecero ben più di quello che erano chiamati a fare, ovvero il loro dovere, tanto da meritarsi pienamente l’appellativo di eroi, per quanto si possa, oggi, pensare che sia desueto. All’epoca non lo era: e Nazario Sauro, protagonista di Fratelli d’Italia, eroe lo fu di sicuro. Nel film, Sauro (interpretato efficacemente da uno statuario Ettore Manni), irredentista istriano, fugge in Italia per arruolarsi nella Regia Marina. Il tenore dell’opera di Fausto Saraceni, produttore in questa circostanza prestato alla regia, risente della corrente melodrammatica che negli anni cinquanta imperversava nella penisola e che, con i suoi eccessi, ben si prestava al connubio coi temi patriottici. In effetti la scena iniziale con Fausto che saluta sua madre Anna (Olga Solbelli) prima di abbandonare Capodistria, sembra raddoppiare il rapporto materno dell’uomo. E’ vero che Sauro lascia la madre naturale in Istria ma, approdando in Italia, lo fa quindi per abbracciare la sua patria, che è la sua terra madre.
Tuttavia la figura di Anna è introdotta sin dal principio, definendone il forte legame col figlio, anche per far comprendere bene la natura del suo comportamento nel processo finale, nel quale la donna sarà chiamata a deporre. Sauro si era, nel frattempo, fatto valere sotto le armi ma, per poter essere imbarcato in un ruolo attivo senza eccessivi rischi, aveva dovuto cambiare nome in Nicolò Sambo, con il quale divenne noto come una vera e propria ira d’iddio. Il cambio di nome non era un vezzo: se fosse stata nota la vera identità, il nostro poteva essere facilmente ricattabile dagli austriaci, vivendo la sua famiglia in una terra sotto il dominio imperiale. La cosa diveniva di pericolo estremo in caso di cattura del valoroso militare. Cosa che avvenne allorché il sommergibile Pullino finì incagliato nelle acque della costa adriatica del golfo del Quarnaro; una volta catturato, Sauro si qualificò come Nicolò Sambo ma venne fortuitamente riconosciuto, nel film dal tenente Sarnich (Carlo Hintermann). Il Sarnich era già stato al centro della scena, nella pellicola, durante una discussione quando Sauro stava ancora a Capodistria; a fronte dell’irredentismo convinto di Nazario, il compagno aveva controbattuto che l’Impero Austroungarico, con la sua forza e importanza, offriva protezione e sicurezza. C’è quindi, nel racconto, il tentativo di dar corpo alle istanze diverse dalla prospettiva principale del narrato. Tornando a Sarnich, in tribunale non sarà comunque lui ad essere l’elemento chiave ma questo ruolo se lo disputeranno Steffé (Paul Muller) e la madre di Nazario, Anna. Steffé era il cognato di Sauro oltre che maresciallo della guardia di finanza austriaca e non si fece problemi a riconoscere il prigioniero che si proclamava essere Nicolò Sambo con la vera identità di Nazario Sauro. La madre, chiamata anch’essa a deporre, si trovava in una difficile situazione: era di fronte al figlio potenzialmente condannato a morte, per cui decise di non riconoscerlo per evitargli la forca. Ma questo voleva dire non poterlo nemmeno riabbracciare oltre a rischiare di essere processata per falsa testimonianza. Infatti, se negava di essere la madre, perdeva il beneficio concesso per il suo stretto legame con l’imputato, e si poteva procedere contro di lei per verificare se avesse detto la verità. Una sorta di paradosso legale, in quanto bene o male era chiaro che Anna e Nazario erano madre e figlio. Tuttavia il capitano March (Marc Lawrence), incaricato di sostenere l’accusa, vi ricorse paventando contro Sauro la minaccia di inquisirne e interrogare, con i mezzi necessari per farla confessare, sua madre. L’irredentista però non cedeva e negava di essere Sauro, suddito dell’Impero Austroungarico e passibile, quindi, di pena di morte per diserzione e alto tradimento. March faceva leva su una presunta vigliaccheria di Sauro che si nascondeva dietro le bugie della madre per sfuggire la giusta condanna: e, in qualche frangente, il dubbio sembra assalire anche la prospettiva del racconto filmico. Era da considerare, infatti, onorevole per un eroe coinvolgere la madre nelle proprie imprese? Si trattava però di tener fede ad un giuramento, quello fatto da Nazario al momento del suo arruolamento presso la Regia Marina. Poi, quando March propone un confronto diretto tra Anna e Steffé, Nazario crolla: nel racconto riaffiora prepotente il tenore melodrammatico dell’inizio, Sauro rompe gli indugi e appella la donna con l’inequivocabile termine “mamma!” condannandosi praticamente a morte. La donna sembra rendersene conto e continua a negare quasi perdendo il lume della ragione: davanti alla sua disperazione, mentre due militari la portano fuori, la corte del processo si alza rispettosamente in piedi. E’ certamente un passaggio che trabocca un sentimentalismo, in questo caso tragico, esagerato, come era d’abitudine nei melodrammi strappalacrime dell’epoca: ma, forse, la morte per impiccagione come traditore, per un uomo che ha semplicemente combattuto per la sua gente, anzi, per la sua patria, è una situazione che giustifica gli eccessi di una simile narrazione. Nel bilancio complessivo molti fattori possono concorrere ma, alla luce della storia del cinema del nostro paese, Fratelli d’Italia non è tanto un buon film o un cattivo film, quanto un film indispensabile: essendo l’unico che ci narra le imprese di Nazario Sauro.






.jpg)
.jpg)






.jpg)






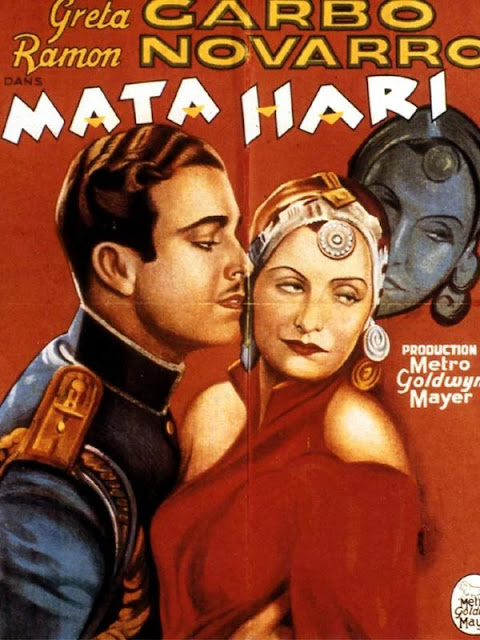


.jpg)








.png)



.jpg)













