1405_TARAS BULBA Germania,1924; Regia di Vladimir Strizhevsky e Joseph N. Ermolieff.
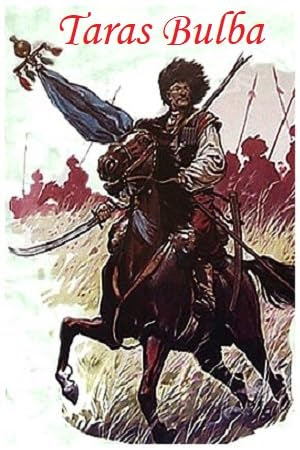
Nel settembre 2023, in un’intervista alla rivista
italiana 7, il settimanale del Corriere della Sera, lo scrittore Andrei Kurkov
ha dichiarato: «C’è troppa Ucraina [nella letteratura russa]. Il più ucraino
degli scrittori classici russi è Gogol, che nei suoi libri ha reso l’Ucraina
molto affascinante per l’impero russo. Ed è uno dei motivi per cui i russi non
possono immaginare il loro Paese senza l’Ucraina». (Kurkov Andrei. «La colpa è di Gogol se i russi non sanno immaginare
il loro Paese senza l’Ucraina» Marinelli Andrea. 7 il
settimanale del Corriere della Sera. 13 settembre 2023.)
Un’opera particolarmente significativa nel senso delle
parole di Kurkov è Taras Bulba, romanzo epico che racconta le gesta, a
cavallo tra il XV e il XVI secolo, dei baldi cosacchi. La vicenda è infatti ambientata
nell’attuale Ucraina e Taras Bulba e i suoi due figli possono, in un certo
senso, raffigurare lo spirito del popolo ucraino: il protagonista è un vero
cosacco, di cui il primogenito, Ostap, segue le tradizionali orme, mentre il
fratello Andriy subisce maggiormente l’influenza europea occidentale, nel
racconto incarnata dall’abbagliante bellezza di una principessa polacca. Gogol,
per questo romanzo epico, lascia un attimo da parte lo stile satirico e infonde
alla sua prosa una potenza degna degli eroi indomiti e brutali protagonisti, ma
non lesina anche passioni estreme in grado di far saltare il banco. D'altronde,
il Romanticismo era, nel 1835, in pieno fervore e la dichiarazione di Andriy
alla bella principessa polacca, trasuda proprio ideale romantico, che l’autore,
argutamente, mette in contrasto con ogni forma di patriottismo o nazionalismo.
Spesso, in Italia ma anche in altri paesi, il romanticismo è associato ai
sentimenti patriotici ma, se ascoltiamo le parole del figlio di Taras Bulba,
che ne incarnano perfettamente lo spirito, si può facilmente notare una
sostanziale alternatività. In effetti, il nodo della questione è proprio il tradimento
di Andriy che, innamoratosi perdutamente della principessa polacca, passa al
nemico giurato dei cosacchi, arrivando a combattere contro la propria gente. La
punizione che gli infligge suo padre Taras Bulba è, agli occhi nostri, inaccettabile
–lo uccide, sparandogli a sangue freddo!– ed è emblematica delle devastanti
potenze che animano questi personaggi, del tutto soggetti alle proprie emozioni
e incapaci di governale. Un testo pregno di tali forze primordiali è, ovviamente,
manna per il cinema, tanto che il racconto di Gogol finirà ripetutamente sul
grande schermo, curiosamente mai per mano ucraina. La prima versione filmata di
Taras Bulba di Gogol prodotta in Ucraina sarà il modesto film televisivo A Thought about Taras
Bulba, regia di Yevhen Bereznyak e Petro Pinchuk, che arriverà
solo nel 2009. Una sorta di timida risposta al Taras Bulba di Vladimir
Bortko, rutilante blokbuster uscito nelle sale quello stesso anno dove il
protagonista diviene l’eroe russo per eccellenza e, nel quale, di Ucraina non si
parla proprio. Del resto era stato russo anche il primo approccio all’opera di Gogol:
nel 1909, il regista Aleksandr Drankov, uno dei pionieri del cinema russo, diresse
un cortometraggio interpretato da Anisim Suslov. Ma quello di Drankov è solo un
film di alcuni minuti, davvero troppo pochi per provare seriamente ad adattare
il racconto Taras Bulba. La scelta del regista, per risolvere questo
problema, è quella di mostrare solamente alcuni passaggi tra quelli più
significativi: c’è il ritorno a casa dei figli di Taras Bulba, che li accoglie
nel suo tipico modo guascone, nella quale vengono presentati i personaggi più
importanti. Poi, c’è la scena dell’assedio a Dubno, con l’inserviente della principessa
polacca che penetra nel campo cosacco per contattare Andriy, a cui segue il
successivo fugace incontro tra i due giovani. Sbrigativamente, il cortometraggio
si chiude un attimo prima dell’esecuzione di Taras Bulba, con l’eroico cosacco
che si china mentre il boia è pronto con la sua ascia. Da notare che, se il
film è destinato a chi già conosce il romanzo –altrimenti sarebbe
incomprensibile– ci sono dettagli su cui la trama si sofferma a discapito dei
tanti brani totalmente tralasciati. Ad esempio quando Taras Bulba si sveglia e
sorprende il figlio Andriy abbandonare il campo con l’inserviente della
principessa: è forse uno stratagemma narrativo di Drankov per rievocare con
forza il racconto di Gogol, affidandosi poi alla memoria dello spettatore nei
momenti mancanti. Quello citato è, per altro, un passaggio forse cruciale, nell’intenzione
dell’autore, perché testimonia come il tradimento, per i cosacchi, fosse quasi
inconcepibile. Infatti Taras Bulba vede Andriy andarsene con una donna, molto
probabilmente proveniente dal castello sotto assedio, ma non prende minimamente
in considerazione che il figlio possa passare al nemico. Nel complesso quella
di Drankov è una rappresentazione che va a referto come approccio sperimentale
e poco più.

Le informazioni sul film Taras Bulba di Vladimir
Strizhevsky e Joseph N. Ermolieff sono tratte da: Gorelyk B. M. “La prima
versione straniera di Taras Bulba e il suo significato nella storia del
cinema nazionale.” A cura di Vykulova V. F. “Gogol e la cultura artistica
mondiale”
Copyright: Casa di Gogol – Museo memoriale e
biblioteca scientifica. 2021.
Copyright: Autori. 2021.
Helena Makowska


.jpg)







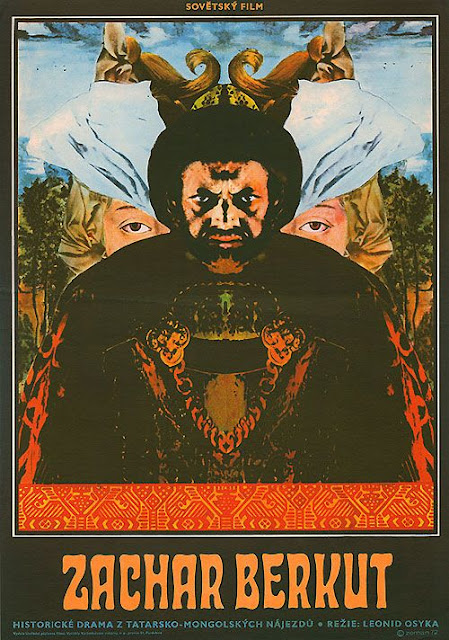

.jpg)



.jpg)

















.jpg)






.jpg)



.jpg)



.jpg)
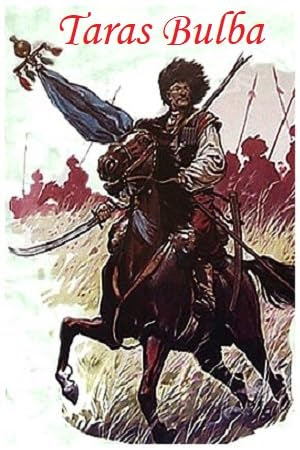

.jpg)
