1334_LA SETTA DEI TRE K (Storm Warning). Stati Uniti, 1951; Regia di Stuart Heisler.
A fronte di un’opera come La setta dei tre K di
Stuart Heisler, un quesito rischia di mettere in ombra qualsiasi altra
considerazione. Il film tratta una vicenda legata al del Ku Klux Klan, una
piaga diffusa nel Sud degli Stati Uniti dopo la fine della Guerra Civile
Americana, ma lo fa senza tirare in ballo la questione razziale. È un’operazione corretta e coerente? Per dovere di
cronaca, nel film alcune persone afroamericane fanno la loro comparsa, ma sono
marginali alla traccia del racconto. A finire sotto i colpi del KKK è un
giornalista, attivista dei diritti civili o cose del genere; fatto sta che dava
fastidio e finisce morto ammazzato. È proprio sulla scena del delitto che si
innesta la traccia della protagonista, una splendida e intensa Ginger Rogers
nel ruolo di Marsha, un’affermata modella. Notare che Ginger era sulla
quarantina eppure risulti decisamente credibile nel ruolo; bellissima, in forma
strepitosa e sempre elegante, attraversa con la sua classe anche una storia
tragica come La setta dei tre K. Tra gli altri interpreti, stupisce
positivamente Ronald Regan nei panni del giudice istruttore Burt Rainey, che
cerca in tutti i modi di arginare la nefasta opera del Klan nonostante l’omertà
dei cittadini di Rock Point. Apparentemente gli abitanti sembrano tutti brava
gente; in realtà, molti di loro sono fanatici membri del Klan e si macchiano
dei crimini più odiosi. È proprio il caso di Hank (Steve Cochran), cognato di
Marsha, per conoscere il quale la ragazza si era giusto fermata nella piccola
cittadina. Ad attenderla aveva trovato sua sorella minore Lucy (Doris Days,
giovanissima), tutta orgogliosa del buon marito che si era appena trovata: se
non fosse che, proprio sotto gli esterrefatti occhi di Marsha, nascosta in un
androne, era stato proprio lui ad uccidere il giornalista. Per Marsha, già
scioccata dall’agghiacciante scena vista appena messo piede in città, scoprire
che l’assassino era suo cognato era decisamente troppo. Di questo suo stato di
debolezza ne approfitta, nel corso della storia, il giudice istruttore Rainey,
che riesce a strapparle qualche informazione preziosa. Qui scatta il tipico
meccanismo per cui i benpensanti provano a mettere a tacere il magistrato, per
il quieto vivere, ma Rainey non ci sta. La trama ha un buono sviluppo, la
Rogers illumina lo schermo con il suo charme che le riusciva utile anche nelle
storie drammatiche e, sotto un certo aspetto, anche lo sguardo etico del film è
rispettato. Tuttavia rimane il problema citato in apertura: perché fare un film
sul KKK senza coinvolgere direttamente gli afroamericani, che erano il
dichiarato obiettivo della setta? Per lo stesso quieto vivere che il film mette
sotto accusa? Un dubbio mica da poco.
Ginger Rogers
Doris Day
Galleria di manifesti





.jpg)






.jpg)

















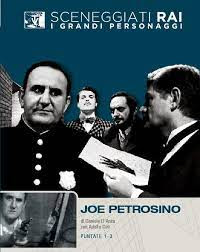

.jpg)






.jpg)






.jpg)







.jpg)




