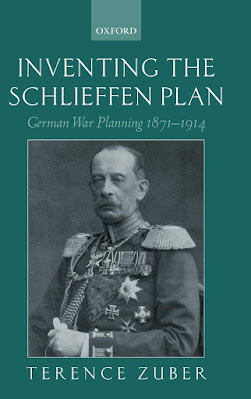868_PATRIA - NO MAN'S LAND. Paesi Bassi, 2014; Regia di Klaas van Eijkeren.
C’è qualcosa che sfugge, in Patria - No Man’s Land (in seguito distribuito nel circuito home video col titolo 1914 The Western Front) di Klass van Eijkeren. Forse è solo la volontà del regista di fare un film credibile, realistico, e per farlo col budget risicato di cui disponeva la produzione, si è ricorsi a scelte narrativamente non convenzionali nel tentativo di non scivolare nei classici cliché. Si è letto, infatti, che gli autori avessero a disposizione 15.000 euro che sono pochi in assoluto, al cinema dei giorni nostri, ma considerato che il tema di Patria - No Man’s Land era la Prima Guerra Mondiale, è chiaro che si è dovuto fare di necessità virtù. Riuscendoci, a grandi linee. Sommariamente si può ritenere il film una rivendicazione legittima del ruolo avuto dagli olandesi nella Grande Guerra: probabilmente perché i Paesi Bassi non parteciparono al conflitto ma è un dato di fatto che al cinema non ci siano molte testimonianze del loro contributo bellico. Patria - No Man’s Land va quindi al colmare questa lacuna raccontando le gesta di Artur Knapp, olandese di origine indonesiana che vive in Francia e si arruola nella Legione Straniera per difendere il paese transalpino dall’aggressione degli unni, come vengono spregevolmente sempre chiamati nel film i tedeschi. Dell’adesione entusiasta dei giovani dell’epoca alla guerra, della successiva atroce scoperta di quanto questa fosse diversa dall’ideale diffuso ai tempi, delle illusioni sulla brevità del conflitto che andarono presto e ripetutamente infrante, della crudezza degli scontri, della presenza ossessiva della morte, del fango delle trincee, del cameratismo tra soldati, di tutto questo Patria - No Man’s Land non aggiunge niente di quando non si sia già visto decine di volte.
Pur se è evidente, già a partire dal cast, che le risorse per realizzare il film erano quelle che erano, va detto che van Eijkeren fa un lavoro diligente dietro la macchina da presa e il risultato è funzionale. Non sono però questi gli aspetti che rendono interessante, ma anche interlocutorio, il film: del tributo agli olandesi si è detto, ma qui occorre approfondire meglio perché la cosa è forse meno scontata di una rivendicazione da parte orange. L’essere olandese di Knapp, personaggio realmente esistito, sembra un pretesto per affermare l’infondatezza delle idee nazionaliste che furoreggiavano al tempo e che stanno rinvigorendosi ancora oggi ad un secolo di distanza. Il titolo originale contrappone infatti due concetti di significato contrario, Patria e No Man’s Land, giocando sul termine nazionalista per eccellenza utilizzato dalla propaganda del tempo in alternativa a quella striscia tra le trincee che veniva chiamata terra di nessuno. Inoltre, il protagonista è evidentemente di origine asiatica, ha passaporto olandese ma si schiera per la Francia e combatte contro gli Imperi, ovvero istituzioni che del concetto di patria erano il superlativo assoluto. Tutto ciò sembra concordare in un’unica prospettiva. Eppure non si può evitare di notare lo sputo di un soldato in divisa francese quando vede sopraggiungere un suo commilitone di colore; l’uomo di origine africana, che darà il massimo contributo alla causa perdendo la propria vita poco dopo, è notato da Knapp che del resto non era neppure lui di stirpe europea.
Certo, si erano visti anche episodi di tiepido nonnismo, nella storia, poco più che scherzi; questo passaggio è però un po’ disturbante seppure potrebbe essere un semplice contributo di credibilità del racconto. Oppure una velata insinuazione che i francesi non fossero poi così convinti di quei concetti sbandierati durante la propaganda bellica se, per caso, fossero coinvolti gli abitanti delle colonie. Volendo c’è un altro piccolo segnale, di questa vena critica da parte del film, già in avvio, quando Knapp sta giocando a pallone con gli amici e se la prende animatamente con l’improvvisato arbitro. Sophie (Marie-Claire Vugts), la sua fidanzata, che osserva la partita, lo richiama: perché diamine si infuria col suo amico per una questione tanto amena? Knapp si giustifica in modo semplice: in quel momento il suo amico ha la funzione di arbitro e quindi è normale insultarlo. Un banale passaggio di realismo nel film o un vago dubbio sul fatto che l’uomo, in modo naturale, debba sempre avere qualcuno contro cui scagliarsi? E che dire delle parole che si sentono nel finale, mentre Knapp sta morendo in seguito all’esposizione ai tremendi gas usati nella guerra, parole che sono parte di un discorso che si conclude così: “Quando già la vita e le origini del nostro popolo sono divise per economia, classi sociali, formazione e retroterra finanziari, l'obiettivo politico non può essere fondato su questa divisione e aspettarsi che duri!” Qualcuno proclama che le disparità finanziarie e sociali siano l’ostacolo da combattere politicamente: quel qualcuno è Adolf Hitler. Nelle sue parole, che preparavano già il terreno al secondo conflitto mondiale, concetti pericolosamente simili a quelli in cui credeva e per cui è morto Arthur Knapp. Insomma, al di là della retorica di facciata, si fatica a capire da che parte stia la ragione, posto che stia da qualche parte. Sono davvero passati più di cent’anni?