1565_JUDGMENT DEFERRED. Regno Unito 1952; Regia di John Baxter
Per
essere un piccolo B-movie girato in economia, Judgement Deferred di John
Baxter si prende come riferimento nientemeno che M - Il mostro di Dusseldorf
di Fritz Lang, da cui il tribunale dei senzatetto che si riunisce in una cripta
è un evidente ma ingombrante debito. Peraltro, il film riprende molti elementi
già visti in Doss House, film del 1933 dello stesso Baxter, a testimonianza
dell’interesse del regista per queste tematiche e per le ambientazioni nei ceti
sociali più disagiati dell’Inghilterra post bellica. Il lungometraggio può
essere ascritto al «genere»
crime, e si apre con l’ingiusta condanna a Bob Carter (Fred Griffiths) per
traffico di droga. In realtà il colpevole è Coxon (Elwyn Brook Jones), un laido
boss malavitoso, forse il miglior personaggio dell’intera storia. Nominalmente,
il protagonista è il reporter David Kennedy (Hugh Sinclair), affiancato dalla
bella e algida moglie Helen (Kay), ma si tratta, tutto sommato, di figure
ordinarie. Più interessanti i personaggi che si riuniscono nella citata cripta,
sorta di covo dei disagiati, tra cui si possono segnalare il Cancelliere (Abraham
Sofaer), Dad (Bransby Williams) e Flowers (Leslie Dwyer). Ma Judgement
deferred è ricordato, doverosamente, per il primo ruolo di rilievo di Joan
Collins: nel film la giovanissima attrice inglese, non ancora ventenne, è Lil,
figlia di Carter, l’uomo ingiustamente accusato all’inizio del racconto. Lil è
una ragazza piuttosto intraprendente e non esista a chiedere aiuto ai
senzatetto della cripta, debitori nei confronti di suo padre, se la giustizia
ordinaria si rivela tanto ostile. Il racconto filmico fa quindi un balzo di un
paio d’anni, nei quali Carter passa da recluso ingiustamente ad evaso, ma
quello che stupisce è trovare Lil divenuta una ragazza di strada, capace anche
di prendere a pistolettate il cattivo della storia per vendicarsi, dopo essersi
addirittura arrampicata sul tetto di un edificio. Ci penseranno David ed Helen
a salvarla dalla brutta strada prima nella scena finale che, come anticipato,
riprenderà il processo a Peter Lorre in M – Il mostro di Dusseldorf. Lil
è al banco dei testimoni dell’accusa, nell’improvvisato tribunale dei
senzatetto allestito nella cripta, Coxon finalmente su quello degli imputati.
Il finale, per altro, è particolarmente interessante: Coxon, già sfuggito dalla
Giustizia ufficiale, sul più bello, si sottrae anche alla condanna dei
disadattati, grazie al provvidenziale intervento dei suoi tirapiedi. I gangster
hanno interrotto il processo a suon di colpi di pistola, e, lanciato una fune a
Coxon, lo stanno issando per svignarsela, in barba a tutti quanti, quando la
struttura cede e seppellisce tutti i cattivi della vicenda. L’inquadratura che
chiude Judgement deferred è un carrello ascensionale sull’architettura
gotica della chiesa sovrastante la cripta, e sembra indicare che l’unica
giustizia davvero efficace sia quella divina. Come detto, Joan Collins era al
suo primo ruolo di rilievo, benché non fosse certo la protagonista: tuttavia è
evidente che la sua presenza scenica, nonostante l’aspetto non sia affatto
sofisticato ma sia quello di una semplice ragazza del popolo, si mangi
letteralmente il film. Oltre a ciò, Joan dimostra una sorprendente capacità di
interpretare a dovere i differenti passaggi che il copione le sottopone. È
credibile come figlia di un padre vittima di un’ingiustizia, come ragazza di
strada e, nel confronto finale in tribunale, regge perfettamente la tensione
della situazione: è nata una stella.
Joan Collins

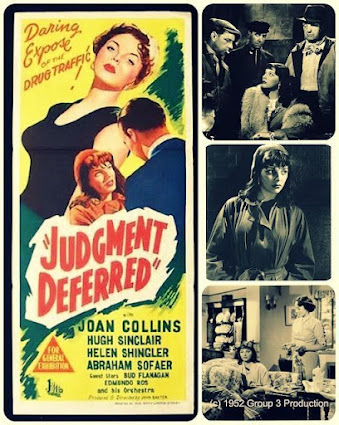














.jpg)


























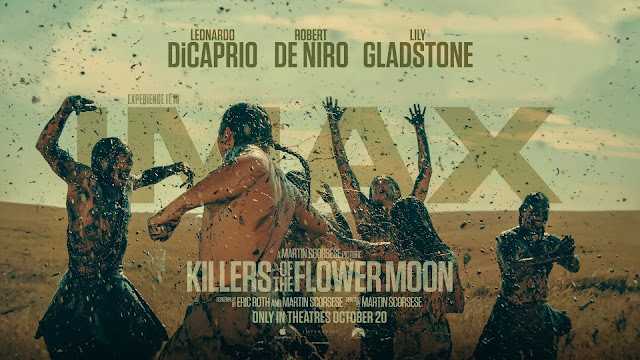

.jpg)
.jpg)





















.jpg)
.jpg)



