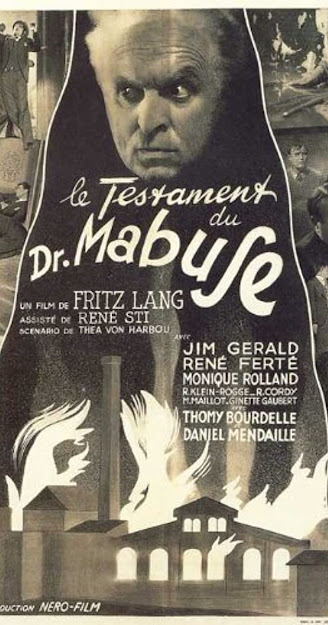All’alba degli anni ottanta, visto il positivo riscontro di Brood (1979), la Filmplan
è ansiosa di rimettere il regista David Cronenberg al lavoro, cogliendo ancora la
contingente possibilità offerta dai Tax-Shelter.
In Canada, infatti, c’era ancora l’opportunità di detrarre parte degli oneri
dovuti al fisco investendo nell’industria cinematografica: non poteva
trattarsi, quindi, di operazioni finanziarie pianificate per tempo, ma
occorreva sfruttare l’occasione buona. A Cronenberg vennero date due settimane
di tempo per organizzare il suo nuovo film: senza alcuna sceneggiatura pronta.
L’idea dei produttori era forse che, andando a scegliere un progetto che girava
ormai da tempo, The Sensitives, che
oltretutto era una sorta di remake di Stereo,
l’opera prima del regista canadese, la fase di pre-produzione potesse essere in
qualche modo sveltita. In realtà questo modo di lavorare, questo lasciare il
campo all’improvvisazione, era del tutto estraneo ad un autore come Cronenberg,
che si era al contrario dimostrato assai calcolato e ponderato nelle sue scelte
registiche, anche quelle meno comprensibili dei primi film sperimentali. Lo
stesso autore confessò un certo disagio nel non avere pronto il set per poter
girare o nel non poter dare rassicurazioni alla protagonista, Jennifer O’Neil
(è Kim, una degli scanner del film),
che non voleva recitare in scene scabrose, visto lo stato d’improvvisazione
della produzione. Tuttavia, come sempre, quando un artista ha la mano calda, è
in grado di convertire a proprio favore anche le difficoltà ambientali o
contingenti e così sarà anche per Scanners,
ulteriore passo in avanti nella carriera autoriale
di Cronenberg.
Brood aveva sancito in
modo esemplare la capacità del regista di gestire un film
commerciale, peraltro piegandolo perfettamente ai propri stilemi;
con
Scanners questa abilità nel
confezionare un prodotto fruibile al grande pubblico verrà ulteriormente
affinata.
Scanners è un film che si
presenta, sin dalla sua più celebre scena, quella con il soggetto dotati di
poteri telepatici a cui esplode improvvisamente la testa, come un film
horror fantascientifico basato sugli
eccellenti effetti speciali. Ed è vero, l’opera è godibile come un prodotto
d’evasione ben costruito e assemblato, sebbene poi non lasci, e questa è la
grandezza del regista, affatto tranquillo lo spettatore come era invece prassi
del
genere. Per la verità, con gli
anni settanta si era imposta, nel cinema dell’orrore, la moda del finale
aperto, dove il mostro, il male, una volta
sconfitto, lasciava intendere di non essere affatto totalmente fuori gioco.
Questo, se aveva comunque un senso
autoriale,
nell’angoscia che correva sottilmente in quegli anni, permetteva ai produttori
di mettere già in cantiere un eventuale sequel nel caso gli incassi fossero
buoni; cosa che verrà presto d’abitudine nel
genere a quei tempi.
Il cinema dell’orrore aveva sin dal principio
avuto una funzione sociale catartica e quindi, passato lo spavento, lo
spettatore poteva dormire sereno. I film dei settanta provavano quindi a
mettergli un po’ di agitazione ma, una volta preso coscienza della consuetudine
dei contro-finali, il loro effetto poteva infatti venire diluito quando non
ridotto a mero cliché. Se era quindi la norma dell’epoca avere un finale sibillino,
Cronenberg si smarca anche da questa prassi (probabilmente senza neppure
prendere in considerazione la cosa, sia chiaro) visto che il finale di Scanners lascia un’inquietudine assai
più profondamente indefinita e spiazzante.
In ogni caso, allo spettatore
abituale dei film horror, viene offerto con
Scanners
un’opera che non offre la solita prevedibile soluzione ed è quindi anche da qui
che si può incominciare a capire il motivo per cui il canadese diverrà un
regista
di culto a suo modo popolare,
mantenendo una cifra assolutamente personale e di altissimo profilo artistico. Ma
per cominciare a dirigere
Scanners,
Cronenberg dovette improvvisare e gli effetti di questo si possono scorgere in
una semplicità strutturale del narrato che, da un certo punto di vista, rende
il film quasi più funzionale. Volendo vedere, ci sono dei passaggi che, per
essere un film
di genere, non sono
forse vere e proprie incongruenze ma non hanno poi la classica spiegazione che
li
risolve; si prenda, ad esempio,
quando Keller (Lawrence Dane) dice a Kim che gli altri
scanners gli hanno rivelato che la ragazza non è una di loro.
L’uomo scoprirà in seguito a sue spese come la cosa sia falsa e, da un punto di
vista narrativo, in prima istanza la cosa è funzionale perché allo spettatore
può perlomeno sorgere un dubbio; ma poi, quando Kim piega col pensiero il
braccio di Keller, viene spontaneo chiedersi che cavolo vadano a raccontare in
giro gli altri
scanners.
Nell’economia del film è un dettaglio insignificante, è ovvio, ma rivela come
Croneneberg dica il vero, (nel libro intervista di Chris Rodley
Il cinema secondo Cronenberg, Nuova
Pratiche Editrice, 1994) quando lamenta la mancanza di tempo avuta per lavorare
alla sceneggiatura del film.
Di contro, come detto, il film risulta quasi più
spontaneo, più agile, rispetto ad altri testi del canadese, che ormai
padroneggia talmente bene la regia da imbastire comunque, anche in queste
condizioni di improvvisazione, una confezione formale notevole. L’impostazione
scenografica è eccellente, con un utilizzo degli ambienti che si era già visto
nei primi lavori dell’autore: gli spazi chiusi sono raffigurati come una sorta
di organismo vivente, i corridoi, le scalinate, gli atri, sembra di girare all’interno
di un’immensa creatura, nello stesso modo in cui la macchina da presa si aggirava per l’Arca di Noè, il complesso residenziale al centro de Il demone sotto la pelle.

Ma stavolta
l’attenzione di Cronenberg è posta altrove; e l’obiettivo del suo esplorare ce
lo mostra, assai efficacemente, l’immagine simbolo di Scanners, con la famosa testa che esplode. L’operazione del regista
nato a Toronto è sempre di natura metalinguistica, come le precedenti: il
dottor Ruth (Patrick McGoohan) mostra a Cameron (Sthepen Lack), il protagonista
del racconto, un filmato, mentre altre volte osserviamo Keller spiare con l’utilizzo
di qualche telecamera nascosta. Il cinema, il virus cronenberghiano, è sempre al centro della scena e con il suo
dipanarsi si insinua per i corridoi delle aziende chimiche o farmaceutiche
presenti nella storia.
In questa occasione, in realtà, non si pone come obiettivo il
corpo, di un edificio come di un uomo,
ma di questi vorrebbe sondare la
mente;
e, infatti, protagonisti della storia sono individui dalle facoltà telepatiche.
E’ però una penetrazione più ardua: la scena con Cameron legato sul letto di
fronte ad una platea di volontari, di cui riesce a percepire ma non a gestire
l’enorme flusso di pensieri, sembra voglia mostrare questo tipo di difficoltà.
Il regista si affida alle dissolvenze incrociate, alle immagini che sfumano,
per illustrare l’altro aspetto che caratterizza il pensiero, la mente umana:
impenetrabile, ma al tempo stesso sfuggente, immateriale. Nonostante questa
ammissione di trovarsi alle prese con qualcosa di differente e meno sondabile
rispetto al corpo, almeno per gli strumenti del suo operare, quelli
cinematografici, Cronenberg sembra però convinto, almeno secondo una certa
chiave di interpretazione, della similitudine, della stretta attinenza, della
connessione saldata, tra mente e corpo. Un corpo si può penetrare per poter
accedere al suo interno e questa è una delle motivazioni alla base del suo
interesse per il sesso; in questo film, che prova ad analizzare la mente, ci
sono comunque un sacco di
penetrazioni.
Alcune virtuali, quelle telepatiche degli scanners,
altre metaforiche come le iniezioni di Ephemerol,
ma la più interessante è quella che riguarda Revok (Michael Ironside), il cattivo del film. L’uomo, lo scanner più potente del lotto, si è
aperto un buco sulla fronte, proprio tra gli occhi: un folle tentativo di
alleviare la pressione che il potere telepatico gli procurava nella testa. Una
penetrazione per mettere in contatto l’interno del cranio con l’esterno,
quindi, in un certo senso, un tentativo di portare alla luce la psiche. E
l’idea di Revok di coprire la cicatrice con un occhio si collega all’atto di guardare,
in questo caso guardare dentro le
cose, come fa il cinema cronenberghiano
quando diventa strumento di analisi.

L’occhio è qualcosa che penetra così come
il cinema è qualcosa che penetra: i corpi possono essere penetrati così come le
menti, possono esserlo. La penetrazione è collegata alla procreazione, così
come i poteri telepatici degli scanners
sono conseguenza delle iniezioni di Ephemerol,
e così come il cinema di Cronenberg
viene creato dallo sguardo penetrante del regista. Tutto questo insistere su
questo tema, nel film evidenziato anche dalle porte che si aprono e chiudono e
con i personaggi che entrano negli
ambienti delle scenografie, si trova in una
storia che si distingue per la sua completa mancanza di ogni riferimento
sessuale esplicito. Per tagliare la testa al toro, e forse per tranquillizzare
la sua attrice protagonista, il regista evita infatti di inserire nella
sceneggiatura ogni aspetto non solo sessuale ma anche sentimentale, tanto che
fa specie vedere due personaggi giovani e attraenti come Jennifer O’Neil e Stephen
Lack ignorarsi completamente da quel punto di vista.


Cronenberg, piuttosto, forse
proprio non avendo una storia studiata e calcolata, ma dovendo sbrigarsi a
trovare le idee per girare ogni giorno senza sprecare tempo, dà libero sfogo
alla sua affascinante e malata fantasia. Lo
studio
di Pierce (Robert Silverman), lo
scanner
che trasforma in arte il suo disagio extrasensoriale, è un saggio
dell’inventiva e della genialità del cineasta canadese. Scenograficamente è un
passaggio di grandissimo fascino visivo, ma ha anche un suo efficace
significato simbolico, con la testa enorme in cui Pierce
penetra e
abita al suo
interno. L’artista è quindi colui il quale riesce a rendere concreta, al punto
da poterci entrare, la mente umana; dare una forma, non solo tangibile ma
addirittura penetrabile, al pensiero.
Questo, in Cronenberg, non è il
raggiungimento dello scopo ultimo della sua arte, ma il suo principio.
Scanners, come detto, è infatti una
sorta di remake di
Stereo, suo
esordio nei lungometraggi, e rappresenta quindi una specie di
re-boot dell’autore canadese. Nella sua
riflessione sulla natura umana, Cronenberg si muove sempre lungo le coordinate
cartesiane psiche/corpo e, naturalmente, questo suo nuovo
primo passo nel tentativo di conoscere sé stessi prende in esame la
mente, laddove risiede appunto la coscienza di sé. Il regista riconosce la
difficoltà dello
strumento cinema,
sebbene si tratti di uno strumento potente, in questo ambito.
Il cinema è
l’arte che meglio permette la visione, una visione di immagini in movimento e
accompagnate dal suono, quasi una ricostruzione attendibile della realtà. Ma
è davvero possibile vedere quello che
abbiamo nella testa? Il buco sulla fronte di Revok non sembra una soluzione,
anche perché il problema della mente umana non è quello di nascondersi ma di
faticare ad essere contenuta. Non serve, quindi, una perlustrazione materiale,
che passi attraverso un foro, un pertugio, un modo di indagine che Cronenberg
ha già efficacemente messo in scena nei suoi precedenti film. Il finale di
Scanners sembra dirci che il problema
non è nello strumento, nel cinema. E’ la mente umana ad essere insondabile.
Quelli che si scoprono essere due
fratelli,
Cameron e Revok, sorta di due
metà oscure
(una meno oscura e l’altra decisamente di più; o no?) in conclusione si uniscono,
si fondono, in un solo individuo. La scena della lotta decisiva tra i due è un
altro passaggio topico del film, con Cameron che brucia in un fuoco che ne
esalta la deriva messianica (la ricerca della verità, la castità nei confronti
di Kim oltre al sacrificio finale) mentre a Revok le pupille diventano bianche,
anticipando il vero significato del film. La conclusione dello scontro è la
sintesi dei due personaggi in un unico individuo dall’aspetto di Revok ma che
ha una voce ambigua, più simile a quella di Cameron.
Il dettaglio principale è
però lo sguardo del nuovo soggetto: dalla fronte dell’uomo è scomparso il terzo
occhio mentre le
normali pupille sono
quelle chiare di Cameron, ma sembrano essere rimaste cieche come era diventato
Revok nei momenti finali del combattimento telepatico. Da un intenso primissimo
piano sugli occhi l’immagine dissolve infatti in un bianco accecante, prima di
passare ai titoli di coda che scorrono come dati sullo schermo di un computer. Anche
il cinema alza bandiera bianca, sembra dirci Cronenberg, di fronte
all’insondabilità della mente umana. Quanto all’informatica, la
mente meccanica, che si prende la briga
si congedarci, aveva già subito una pesante lezione nella scena in cui Cameron
fa saltare con i suoi poteri telepatici l’intero Centro Operativo. Un altro
elemento che si aggiunge alla celeberrima e citata scena del film, per dirci
che la mente umana ha davvero una potenza esplosiva. Come il cinema di David
Cronenberg.