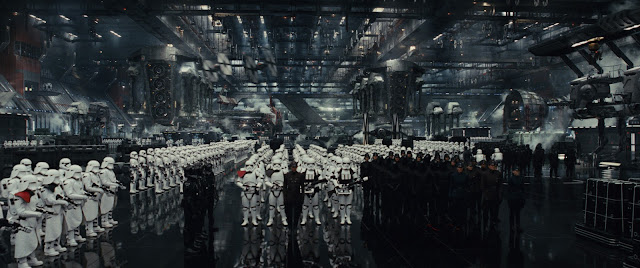73_BLACK DAHLIA (The Black Dahlia) Stati Uniti, 2006; Regia di Brian De Palma.
 “Le persone mentono”, riflette
l’agente Bucky (il valido Josh Hartnett), a proposito di una deposizione
fasulla che intendeva metterlo fuori strada. Un’affermazione che va tenuta a
mente quando, dopo la scritta The End
in coda a Black Dahlia, leggiamo che
il film è ispirato al celebre fatto di cronaca della Dalia Nera, mentre la trama è imbastita sull’omonimo libro opera di
James Ellroy. Perché anche i registi sono persone; non che non si debba credere
alle didascalie citate, ma perché, pur se veritiere, sono fuorvianti. Perché,
se è sicuramente vero che la principale ispirazione è dovuta al fatto di
cronaca e lo sviluppo narrativo si basa sul lavoro di Ellroy, in realtà
l’obiettivo di Brian De Palma, formidabile regista dell’opera, è focalizzato altrove
(e qui sta’ la piccola bugia della didascalia), e guarda caso proprio sul luogo
dove è ambientata la vicenda, ovvero il paradiso della finzione, e quindi della
menzogna, Hollywood. Hollywood, la fabbrica dei sogni, di personaggi eterei,
bidimensionali, vuoti: come il corpo
della povera ragazza trovata morta,
“Le persone mentono”, riflette
l’agente Bucky (il valido Josh Hartnett), a proposito di una deposizione
fasulla che intendeva metterlo fuori strada. Un’affermazione che va tenuta a
mente quando, dopo la scritta The End
in coda a Black Dahlia, leggiamo che
il film è ispirato al celebre fatto di cronaca della Dalia Nera, mentre la trama è imbastita sull’omonimo libro opera di
James Ellroy. Perché anche i registi sono persone; non che non si debba credere
alle didascalie citate, ma perché, pur se veritiere, sono fuorvianti. Perché,
se è sicuramente vero che la principale ispirazione è dovuta al fatto di
cronaca e lo sviluppo narrativo si basa sul lavoro di Ellroy, in realtà
l’obiettivo di Brian De Palma, formidabile regista dell’opera, è focalizzato altrove
(e qui sta’ la piccola bugia della didascalia), e guarda caso proprio sul luogo
dove è ambientata la vicenda, ovvero il paradiso della finzione, e quindi della
menzogna, Hollywood. Hollywood, la fabbrica dei sogni, di personaggi eterei,
bidimensionali, vuoti: come il corpo
della povera ragazza trovata morta,
De Palma gira con tutta la maestria di cui è capace, con
calma, muovendo la mdp attorno ai
personaggi, accompagnato dalla trama che ha mille rimandi e mille sottotracce.
Le cose si rivelano poco a poco, ma nessun colpo di scena sembra essere quello
definitivo, c’è sempre qualche particolare ancora da chiarire, niente è mai
come sembra. Il regista non è però tanto interessato alle precisione dei colpi
di scena, perché sono talmente tanti e talmente aggrovigliati che per lo
spettatore è impossibile coglierli tutti, almeno alla prima visione; ma De
Palma usa questo intrico per ammaliare e stordire i sensi, aiutandosi con una
regia ipnotica nel suo costante e perfetto movimento d’accompagnamento.
Alcune sequenze sono, come al solito, strepitose, una per
tutte quella aerea che precede il ritrovamento del cadavere della Dalia Nera.
L’obiettivo di De Palma, si diceva, è il Cinema: d’altra parte il
protagonista e voce narrante del film cosa fa, durante quasi tutto il racconto
se non guardare provini e filmini? A differenza del suo socio, il sergente Lee
(Aaron Eckhart), che della coppia è
il personaggio sbagliato, e infatti non sopporta la visione del filmato hard,
cruciale per le indagini, e lascia la saletta di proiezione anzitempo. Il tema
del doppio, classico in De Palma, è fondamentale anche in Black Dhalia: i poliziotti protagonisti sono appunto due, Bucky e
Lee, ghiaccio e fuoco, come venivano soprannominati nel loro passato di pugili.
E il focoso Lee finirà proprio per bruciarsi,
perché mantenere il sangue freddo nei momenti cruciali, come accade a Bucky nella
penultima scena, è fondamentale per salvarsi. Ma le coppie nel film sono
molteplici: la Dalia Nera
Ma, tornando alle coppie, Madeleine ha una sorella,
Martha, con la quale costituisce quindi un’altra coppia; Martha è un abile
caricaturista, disegna cioè vignette umoristiche; è un dettaglio secondario, ma
ha una sua piccola valenza. Comunque possiamo vedere che di coppie nella storia
ce n’è a iosa: Mr. Linscott ha una moglie, Ramona (ecco un’altra coppia) e un
amico fidato Georgie (con il quale forma una coppia di amici), i quali tra loro hanno una tresca (un’altra coppia
ancora), che poi è anche quella che scatena la tragedia quando Ramona scopre
che il suo amante ha un appuntamento con la
Dalia Nera
Come si vede le coppie sono molte, ma nessuna di
queste ha fondamenti validi: l’unica legale è tra i coniugi Linscott, ma Ramona
si premunisce di dirci che il marito l’ha sposata per soldi, mentre Georgie tradisce
la fiducia dell’amico e tra le sorelle non corre certo buon sangue e così via.
Manca ancora un elemento all’appello, che in questo gioco delle coppie è il grimaldello, quello che le farà saltare,
insomma il personaggio-chiave: una splendida Scarlett Johansson è Kay (Key = chiave) la compagna di Lee.
Compagna, e non moglie, e per l’epoca, viene detto esplicitamente, questo
rendeva la coppia illecita. Ma in
effetti, Key forma più che altro un trio, andando a completare quella coppia
fatta per contrasto (ghiaccio e fuoco) composta da Bucky e Lee.
 Il mondo rappresentato in Black Dahlia è quindi un
invischiante gioco basato sulle menzogne (tutti, più o meno mentono, nella
storia) e su legami opportunistici. Pur se con i propri limiti, Kay è una che
rompe il legame con DeWitt, il criminale che la faceva prostituire, e poi prova
a rompere anche con Lee. E’ quindi un personaggio di rottura; simbolicamente
poteva essere intesa come il doppio speculare (e quindi formare una coppia) di
Madeleine, le due donne che nel finale si contendono Bucky. Ma a differenza di
Martha (abbinata a Madeleine in quanto sorella), lei ha smesso di disegnare
(studiava infatti disegno), e quindi, per una sorta di parallelismo, smette di
essere il doppio di Madeleine. La rottura dei legami, degli schemi, questo è il messaggio che porta Kay, la donna che su di se porta il marchio BD, inciso dal suo protettore Bobby DeWitt.
Il mondo rappresentato in Black Dahlia è quindi un
invischiante gioco basato sulle menzogne (tutti, più o meno mentono, nella
storia) e su legami opportunistici. Pur se con i propri limiti, Kay è una che
rompe il legame con DeWitt, il criminale che la faceva prostituire, e poi prova
a rompere anche con Lee. E’ quindi un personaggio di rottura; simbolicamente
poteva essere intesa come il doppio speculare (e quindi formare una coppia) di
Madeleine, le due donne che nel finale si contendono Bucky. Ma a differenza di
Martha (abbinata a Madeleine in quanto sorella), lei ha smesso di disegnare
(studiava infatti disegno), e quindi, per una sorta di parallelismo, smette di
essere il doppio di Madeleine. La rottura dei legami, degli schemi, questo è il messaggio che porta Kay, la donna che su di se porta il marchio BD, inciso dal suo protettore Bobby DeWitt.
Un marchio che indica sia le iniziali dell’uomo ma
anche l’acronimo che si usa per il Bondage
& Discipline (genere che ritorna nei filmini hard della Dalia Nera), e
che prevede appunto corde e legacci per tenere legati, imbrigliati, e che
invece Kay riuscirà più volte a rompere nel corso della storia.
Ecco perché uno dei temi era il depistaggio, perché proprio
il film che fa della propria apparente cifra stilistica la perfezione formale,
il suo circumnavigare le cose, come la mdp di De Palma insegna, ci sprona
invece ad andare al sodo, a rompere gli intrecci, i formalismi, i legami
posticci. Si è stancato pure Bucky di sparare a destra, a manca, in alto, a un
vaso, ad una statua o ad un lampadario.
E’ tempo di mirare al cuore.
Hilary Swank
Mia Kirshner
Rose McGowan