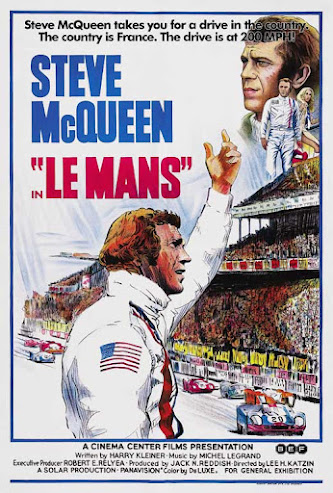1530_FERRARI 312B . Italia 2017; Regia di Andrea Marini.
È innegabile che un film documentario incentrato su una specifica vettura di Formula 1 di mezzo secolo fa, attiri unicamente l’interesse di un pubblico selezionato e, si suppone, preparato. Tuttavia, nell’introduzione all’opera, è dato forse poco spazio alla definizione dell’operazione che si è deciso di seguire con il racconto filmico. Perché Ferrari 312B di Andrea Marini non è solo una descrizione tecnica sulla mitica autovettura che corse per il Cavallino Rampante nelle stagioni 1970 e 1971. O meglio, estratti da quegli anni, immagini dei Gran Premi, ci sono, ma fungono da sfondo alla vicenda raccontata in primo piano, che riguarda l’acquisto e la completa ristrutturazione di un esemplare della vettura in questione. Ed è qui che Andrea Marini, la fa troppo facile: come se trovare d’«occasione» una Ferrari di Formula 1 degli anni Settanta sia una cosa quasi naturale, al pari di conoscere di persona Mauro Forghieri, lo storico progettista che lavorò a Maranello per anni e che fu responsabile anche del progetto 312B. Certo, se ti chiami Paolo Barilla –fai il pilota, d’accordo– e sei il rampollo della nota famiglia di produttori di pasta, allora tutto assume un’altra prospettiva. Se c’è un appunto, che si può fare al docufilm di Marini, infatti, è proprio questo: guardando il suo Ferrari 312B si può infatti avere l’illusione che restaurare un bolide di Formula 1 di quell’epoca sia una cosa, non si dice alla portata di tutti, ma nemmeno così proibitiva. In realtà, probabilmente, è un’operazione preclusa alla totalità degli appassionati, e, allora quello di Marini diventa un’occasione unica per vedere davvero come è fatta e come funziona –e, anche come non funziona– un’auto da competizione. Infatti, pur avendo la consulenza di un geniaccio come Forghieri, e smontando e rimettendo a nuovo ogni singolo pezzo della vettura – motore compreso, revisionato da un’azienda specializzata– la 312B, una volta riassemblata, fa un po’ i capricci. Barilla non demorde, perché ha un sogno: guidarla al Gran Premio di Montecarlo per auto storiche. Un’idea che può suscitare qualche dubbio: è il caso di portare un autentico pezzo da museo –nel senso che è una vera e propria opera d’arte– a rischiare di schiantarsi ad ogni curva? Barilla, anche in base alle opinioni raccolte, si convince di sì: la Ferrari 312B è stata concepita per gareggiare e solo in una corsa potrà davvero rivivere. L’entusiasmo del buon Paolo è contagioso e finisce per essere anche convincente: se non fosse che, durante le prove, una Lotus dalla fiammante livrea John Player Special nera e oro, finisce contro il guard-rail e, a quel punto, qualche dubbio sull’opportunità di far correre rischi a quelle meraviglie tecnologiche ritorna eccome. In ogni caso, guardare Ferrari 312B, vedere smontare e rimontare una leggendaria monoposto di Maranello, è un’esperienza mistica più che cinematografica.
Galleria









.webp)


























.jpg)