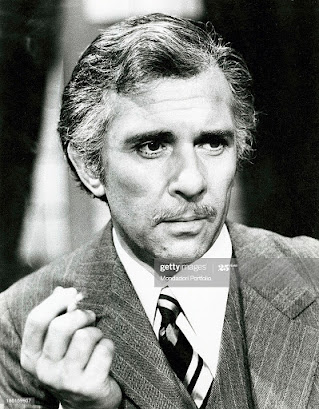Sceneggiato in tre puntate per un totale di 200
minuti, Accade a Lisbona, scritto da Luigi Lunari e diretto da Daniele D’Anza,
è l’ennesimo esempio di come la RAI, la rete televisiva nazionale italiana, a
suo tempo avesse una notevole capacità di produrre opere tra loro eterogenee
mantenendo un elevato tasso qualitativo. Accadde a Lisbona è basato
sulla vicenda dello Scandalo della Banca del Portogallo del 1925, che
vide il personaggio storico di Alves Reis organizzare una delle più clamorose
truffe del secolo. Lo sceneggiato di Lunari e D’Anza parte un po’ in sordina,
sostanzialmente nel primo episodio, ma già verso la fine di questo ha catturato
l’interesse dello spettatore. Nel resto del racconto filmico l’attenzione non
andrà mai più scemando e, semmai, si può rimpiangere che l’epilogo arrivi
troppo in fretta, sebbene questo sia legato alle vicende storiche a cui i narratori
si attengono abbastanza scrupolosamente. Rispetto ad altri prodotti simili
dell’epoca, il soggetto all’origine di Accadde a Lisbona ha alcune
peculiarità che gli autori riflettono poi nelle scelte narrative e registiche
per un risultato finale assai singolare ma nel complesso convincente, nella
migliore tradizione RAI.

Chiamato non soltanto ad essere il protagonista della
storia ma a fungere da vero e proprio mattatore è Paolo Stoppa, un attore di
grandissima esperienza non solo in campo cinematografico ma anche teatrale. E
alla sua verve da palcoscenico Stoppa fa appello per recitare il ruolo di Alves
Reis, il truffatore della nostra storia: il personaggio avrebbe una trentina
d’anni mentre l’attore romano quasi settanta, ma la sua istrionica performance
regge praticamente da sola la storia. La scelta di un attore così
ingombrante
è ben sfruttata dal regista Daniele D’Anza: a Stoppa,
in borghese, sono
affidate anche le introduzioni ai tre episodi e una sorta di epilogo, nei quali
l’attore dà un minimo di indicazioni per comprendere le coordinate per una
storia interessante ma abbastanza estranea ai canoni dell’abituale narrativa di
intrattenimento. Con l’interprete del personaggio principale in una veste più
contemporanea immerso in una Lisbona degli anni settanta mentre fornisce alcune
delucidazioni sulla vicenda, la credibilità della storia viene così alimentata.
Ed è un’impressione corretta, perché lo sceneggiato RAI segue abbastanza
fedelmente gli
incredibili avvenimenti che portarono Reis e i suoi
collaboratori a stampare in modo
privato un centinaio di milioni di
escudo
portoghesi; banconote tecnicamente non false, quindi, visto che furono
realizzate dallo stesso fornitore che abitualmente aveva l’incarico di produrle
per la Banca del Portogallo.
Come detto la storia è incentrata su un Paolo
Stoppa in gran spolvero, che si prende i suoi tempi e spesso dialoga con la
telecamera, riflettendo sui quei passaggi che gli sono necessari per imbastire
una truffa così colossale. Ad affiancarlo, in tono certamente minore (il che,
in questo caso, non può certo essere un demerito), Paolo Ferrari, Enzo
Tarascio, Roberto Brivio, tra gli altri. Maria Fiore, nei panni di Maria Luisa,
moglie di Reis, è l’unica presenza femminile di un certo rilievo, ma non è che
la vicenda gli conceda poi questo grande spazio. D’altra parte si è già
ripetuto, il racconto è abbastanza fedele agli eventi e gli autori decidono di
rispettarne anche quegli aspetti, come il ruolo avuto dalle donne nella storia,
che in altri casi si sarebbero potuto invece
accomodare in linea con la
consuetudine narrativa della televisione. Insomma, dando un po’ più di corda a
qualche intreccio amoroso; ma il punto più sorprendente della coerenza alla
realtà storica di D’Anza e Lunari è un altro e di ben altra portata. Perché a
mancare, nel loro sceneggiato, è soprattutto il cosiddetto quadro morale:
d’accordo si parla di soldi equando ci sono di mezzo loro si sa che è dura
mantenere la barra dell’onestà dritta ma la RAI non aveva mai nascosto la sua
natura educativa. Che, volendo, è presente in modo esplicito anche in
Accadde
a Lisbona, nel momento in cui l’emittente riporta in luce un evento storico
tanto importante quanto misconosciuto. Però nel racconto manca completamente
una figura a cui far riferimento in senso etico, il classico
eroe,
insomma e, in alternativa, manca anche un narratore esterno che funga un po’ da
grillo parlante. In questo ruolo è chiamato addirittura Stoppa che,
seppure si mantenga abbastanza distaccato nelle introduzioni agli episodi, è
pur sempre lo stesso che è protagonista del racconto nella parte del
truffatore.
Ma attenzione: non è che la RAI faccia un elogio alla furbizia che
tante altre volte si è visto al cinema di casa nostra, soprattutto nella
commedia; qui ci si attiene ai fatti e, semmai, c’è un approccio adulto e
rispettoso della maturità degli spettatori che sono chiamati a trarre da soli
la
morale della favola. Un aiuto, in questo senso, è affidato alle
canzoni di Fie Carelsen (Marisa Bartoli) ma per contrasto, visto che la sua
interpretazione nel cabaret è uno spudorato inno al potere del denaro. Del
resto la vicenda è ambientata nei
ruggenti anni venti che, con la loro
folle euforia finanziaria, portarono il mondo alla catastrofe finanziaria del
1929. E, proprio ascoltando le parole della cantante, Reis riflette su come ci
sia poca differenza tra sfondare una banca (per rapinarla) e fondarla, coagulando
in modo dichiarato la vena critica che corre lungo tutta la vicenda in modo implicito.
Curiosamente, in un’opera che sembra scegliere di non esporsi sugli aspetti
morali della vicenda, è proprio la
finzione nella finzione a
manifestarli, sebbene, come detto, rovesciati nel senso. Ha naturalmente torto
l’austera Fie così come si sbaglia anche Reis nella sua riflessione guardando
nell’obiettivo della telecamera; il denaro non dà la felicità e nemmeno si può
pensare che le banche siano un covo di poco di buono. Alla fine la truffa viene
smascherata in modo abbastanza banale, come in fondo è, se non banale perlomeno
ovvia, anche la morale di tutta quanta la storia: ma, un po’ nella scia dello
sceneggiato, lo è talmente che si può lasciare anche implicita.